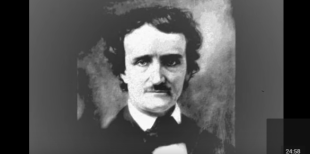 Un uomo senza nome, che dunque potrebbe essere ognuno di noi, che si incattivisce contro qualcosa che gli dà fastidio. Senza un motivo particolare. Ma soltanto perché non gli piace. Il tutto inserito in una catena di eventi lucidamente organizzati e presentanti, che però portano all’uccisione di un altro uomo.
Un uomo senza nome, che dunque potrebbe essere ognuno di noi, che si incattivisce contro qualcosa che gli dà fastidio. Senza un motivo particolare. Ma soltanto perché non gli piace. Il tutto inserito in una catena di eventi lucidamente organizzati e presentanti, che però portano all’uccisione di un altro uomo.
E’ “Il cuore rivelatore”, racconto breve di Edgar Allan Poe datato 1843, che riprende alcune caratteristiche dell’horror a firma dello scrittore statunitense: protagonista senza nome, luoghi isolati, finale con morte.
Un uomo va in sofferenza quando vede l’occhio vitreo e fisso dell’avvocato per cui lavora. Lo disturba, lo mette in agitazione. Per questo cerca di uccidere quell’occhio, ben sapendo di dover così uccidere anche l’avvocato. Così tutte le notti cerca l’attimo buono per farlo, calibrando i suoi movimenti in maniera scientifica e studiata. Una lucida follia.
Fino a quando i sensi di colpa prendono il sopravvento: l’avvocato si accorge della sua presenza in camera e si ribella. Ma è ormai troppo tardi: il delitto va in scena, nonostante diversi rumori di varie cose (tra cui anche il cuore della vittima) mettono in subbuglio l’animo dell’assassino. Anche quando arrivano i poliziotti: prima l’uomo regge la scena, poi però, quando il cuore dell’avvocato alza il volume dei suoi battiti, ecco che i sensi di colpa hanno la meglio e l’aggressore confessa.
Fino a dove siamo disposti a muoverci per soddisfare le nostre pulsioni? Fino a dove arriviamo per eliminare quello che ci turba? Anche andando ad oltrepassare i nostri limiti? E fino a che punto siamo pronti a giustificarci, a trovare delle lucide scuse, pur di arrivare a quello che vogliamo?








