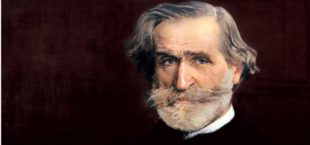 Paolo Isotta provoca sempre reazioni estreme: o lo si ama o lo si odia, ma lo si legge sempre. E poi, quale Isotta? Quando faceva il critico musicale, era un piacere non essere quasi mai d’accordo con lui; quando fa lo storico della musica, è sempre un piacere esserlo quasi sempre, e spesso anche imparando molto.
Paolo Isotta provoca sempre reazioni estreme: o lo si ama o lo si odia, ma lo si legge sempre. E poi, quale Isotta? Quando faceva il critico musicale, era un piacere non essere quasi mai d’accordo con lui; quando fa lo storico della musica, è sempre un piacere esserlo quasi sempre, e spesso anche imparando molto.
Questo Verdi a Parigi è un Isotta tipico: alluvionale, solo apparentemente divagante, documentatissimo. L’autore vi esibisce la sua cultura mostruosa (proprio in senso etimologico, monstrum, prodigio, portento) come si vedrà non solo musicale, la sua dottria e la sua prosa “alta” e sdegnosamente “antica” che oggi potrà sembrare preziosa fino alla civetteria, ma forse soltanto perché ci siamo ormai arresi a leggere, e talvolta a scrivere, una specie di subitaliano. Abbondano, ovviamente, le citazioni latine e, dato il soggetto, francesi.
In effetti, parlare di Verdi e Parigi significa parlare di Verdi tout court (a proposito). L’attrazione della “capitale del XIX secolo” era per lui, come per qualsiasi compositore di successo, irresistibile. Verdi sicuramente non amava quella “grande boutique” che era l’Opéra, ma sapeva che si trattava di un passaggio obbligato. Però Isotta non si limita ad analizzare i quattro titoli che Verdi scrisse per Parigi, tre per l’Opéra, Jérusalem, Les Vepres siciliennes e Don Carlos, uno per il Theatre Lyrique, il secondo Macbeth (rimangono un po’ in ombra, invece, i rapporti contraddittori del Maestro con il Theatre Italien, ma forse il recente dettagliatissimo studio di Ruben Vernazza è stato pubblicato troppo tardi per essere utile). Isotta sostiene che Verdi ebbe ben presente il modello grandopéristico parigino fin dai tempi di Nabucco, ne cerca e ne trova le tracce in tutta la sua produzione, analizza le fonti francesi dei capolavori e così via.
In effetti, il paradossale destino del teatro musicale francese è quello di essere opera degli italiani. La tragédie lyrique fu inventata da Lully che, nonostante la ipsilon della naturalizzazione, era nato Giovanbattista Lulli, e a Firenze; i grand opéra migliori li scrissero gli italiani in trasferta parigina, da Spontini a Verdi, passando per Cherubini, Rossini e Donizetti. Isotta può scriverlo perché si muove nel repertorio quasi dimenticato degli Auber e degli Halévy come nel salotto della sua splendida casa napoletana, e solo personalmente dispiace l’accanimento sull’Hamlet di Thomas (si sa, ognuno ha le sue perversioni).
Qui sono davvero importanti le pagine dedicate al rapporto tra Verdi e Meyerbeer. Per Verdi, il modello è affascinante. Ma dei kolossal storici meyerbeeriani conserva la cornice spettacolare, il décor, l’uso della Storia per intrecciare tragedie private a pubbliche calamità. La sostanza è tutta diversa e infinitamente superiore: la sintesi, il senso del teatro, l’unitarietà di visione verdiana, insomma la sua sapienza drammaturgica più ancora che musicale ribaltano dall’interno il “genere” fino all’esito supremo di Don Carlos. Meyerbeer, nota Isotta, procede per accumulo; in Verdi “l’omogeneità stilistica è sintetica e unitaria, e i particolari ne discendono”. Senza contare l’aspetto, diciamo così “morale”, perché se il teatro di Meyerbeer si muove dentro l’ideale di Scribe della pièce bien faite, non ha alcuna ambizione di critica sociale, è sempre funzionale all’ordine costituito, Verdi è invece artista supremamente “politico”, dunque critico. E allora altrettanto illuminanti sono le considerazioni sui benpensanti e spesso malfacenti verdiani: la “roba” la chiamano Dio, scrive Isotta.
C’è però un’altra caratteristica che rende prezioso questo saggio. Di regola, gli storici della musica conoscono la storia della musica, ma poco la Storia. Isotta, sì. Le sue nozioni sulla letteratura, l’arte e la società francesi dell’Ottocento sono vastissime: finalmente qualcuno che spiega la differenza fra monde e demi-monde che è fondamentale per capire l’ambiente della Traviata. Naturalmente, anche qui emerggono i suoi fieri disgusti: vedi la violenza con la quale demolisce il povero Luigi Filippo ogni volta che può. Segnalo però che Louvel, l’accoltellatore del duca di Berry, non era un “giacobino” (pag. 22), semmai un bonapartista. E poi è vero che Carlo X non era affatto quel mostro, in senso attuale, che hanno inventato la storiografia liberale o Dario Fo, ma farne “un amante delle arti” (pagina 53) è un po’ troppo. Di certo non della musica, stando alla celebre descrizione che Castil-Blaze fece del Re sospirante o sofferente fra le donne della famiglia, la duchessa d’Angouleme e quella di Berry, all’ascolto del Viaggio a Reims di Rossini, che pure celebrava il suo Sacre.
Chi ama Isotta si godrà i suoi giudizi tranchant, tipo “Gounod, un Meyerbeer di serie C”, le battute fulminanti (fin nei titoli: Quer pasticciaccio brutto de via Le Peletier) le stroncature di artisti anche già amati, espresse con una sferzante acribia che lascia a bocca aperta: muti, diciamo. Ma questo è un libro che dovrebbe leggere anche chi Iostta non lo ama. E perfino chi non ama la musica, perché Verdi e la civiltà borghese dell’Ottocento sono ancora quello che siamo. Consigliatissimo”.
*Da La Stampa del 24.4.2020








