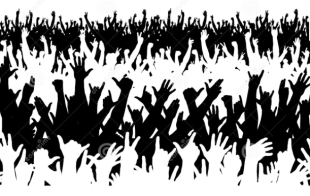
Paolo Borgognone è un giovane ricercatore non allineato, non conformista, collaboratore del quotidiano La Verità che da anni analizza la modernità con studi a metà fra storia e politologia. Si è occupato, nei suoi libri, di disinformazione e media, del dceclino della sinistra radicale e della globalizzazione. Ultimo libro uscito è Deplorevoli? (Zambon ed., pagg. 334, euro 18) sugli Usa di Trump e i movimenti sovranisti europei.
Il 9 novembre dell’anno scorso la vittoria di Donald Trump alla elezioni Usa ha scompaginato i piani delle lobby finanziarie e soprattutto ha mostrato come una maggioranza silenziosa, senza ascoltare il 98 per cento dei mass media Usa, abbia scelto il cambiamento nella politica statunitense in senso sovranista. Perché questo esito nonostante la martellante propaganda “democratica”?
“Il 9 novembre 2016 ha costituito una grande rivolta elettorale di cittadini americani di ceto medio-basso, proletarizzati (middle class-proletariat), penalizzati dalla mondializzazione liberale e residenti nelle aree periferiche, rurali e postindustriali del Paese, ovvero la Rust Belt deindustrializzata e depressa a seguito dei processi di modernizzazione (leggasi finanziarizzazione e digitalizzazione) del capitalismo. L’affermazione elettorale di Trump in Usa, come del resto Brexit in Gran Bretagna, si è concretizzata nel Paese che più, negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, ha investito sulla finanziarizzazione economica, avviando al contempo giganteschi processi di deindustrializzazione. L’affermazione di Trump è, in qualche modo, frutto della rivincita dell’economia reale nei confronti di quella virtuale (responsabile, quest’ultima, della serie di collassi e default innescati, a livello planetario, tra il 2007 e il 2011, proprio a seguito del crash dell’economia finanziaria globalizzata). Naturalmente, i media liberal internazionali, cultori del primato pubblico della finanza privata sans frontières, non potrebbero in alcun modo riconoscere che l’elezione di Trump è occorsa a seguito del fallimento del modello dispotico della globalizzazione unipolare e, pertanto, al fine di occultare le autentiche ragioni alla radice della sconfitta del beniamino di Wall Street, Hillary Clinton, inventarono di sana pianta la narrativa mainstream secondo cui, a votare Trump, sarebbe stata una cricca minoritaria di “razzisti” e “bifolchi” di provincia, abilmente imbeccati a tal fine dai servizi segreti russi. I ceti “neoproletari” dell’America “profonda” e deindustrializzata hanno sostanzialmente detto “no” ai programmi di liberalizzazione e internazionalizzazione ulteriore proposti da Hillary Clinton e “sì” ai propositi trumpiani di protezionismo economico volti a tutelare i posti di lavoro e i redditi dell’economia reale nazionale. Inoltre vi è stato, il 9 novembre 2016, un netto rifiuto, da parte dei ceti americani penalizzati dalla globalizzazione liberale, nei confronti del tentativo della classe agiata, liberal e cosmopolita urbana, newyorkese e californiana, di esercitare una sorta di dominio sul tono e il ritmo di vita (non solo di lavoro, di vita nel suo complesso) del resto della popolazione statunitense. Un dominio evidentemente senza egemonia, al netto degli eventi elettorali verificatisi “sul campo”. Gli americani “periferici” avevano molte ragioni per rifiutare il candidato dei “democratici”, Hillary Clinton, riconducibili essenzialmente al fatto che il Partito Democratico, negli Usa come qui da noi, è il partito delle classi urbane, agiate, istruite (ovvero interne ai codici culturali simbolici di adattamento al mondo così com’è), cosmopolite, transgender. E gli stili di vita e i modi di essere degli ereditieri e delle classi manageriali di fascia “alta” (upper class) di New York e San Francisco hanno nulla a che vedere con i reali bisogni e le esigenze quotidiane di chi, nella provincia americana postindustriale, combatte ogni giorno contro i demoni della globalizzazione, della decadenza e dello sradicamento. Affermare che gli americani appartenenti a specifiche fasce sociali e contesti di insediamento territoriale abbiano votato Trump perché “razzisti” o “allocchi” imbeccati dai russi significa negare scientemente il macroscopico conflitto culturale e di classe in atto, riducendo tutto a una narrativa politica simbolica attinta direttamente dalle trame delle serie televisive americane per rinfanciulliti e sognatori di ogni sorta. Trump ha perso a New York patendo un grave distacco da Hillary Clinton in termini di voti pro capite (70 a 30) ma ha vinto nettamente in tutte le aree nevralgiche dell’America “profonda” e l’affermazione del tycoon repubblicano è dovuta a motivazioni di carattere politico, culturale ed economico autoctone e non può certo essere posta in relazione a presunti, e indimostrabili peraltro, interventi esterni (russi in questo caso) tramite hackeraggio di e-mail o sofisticazione di profili Facebook. Chi, a sinistra, per offrire una sponda di legittimazione a Hillary Clinton sostiene che Trump sia stato votato anche da numerosi ricchi e oligarchi, dimentica che l’elettorato repubblicano, in larga parte composto da benestanti, ha ovviamente in maggioranza votato per Trump ma non sono stati costoro a determinare la vittoria di questo candidato “anomalo” interno al GOP. Trump ha vinto perché ha promesso protezionismo economico ai ceti penalizzati dall’economia capitalistica globalizzata e fondata sul criterio della delocalizzazione permanente. La maggioranza silenziosa pro-Trump non è certamente composta da miliardari…”.
La fine della storia annunciata da anni dai filoni di storici liberal (per primo Francis Fukuyama) sembra non arrivare più: forse il popolo si sta risvegliando, come emerge da quanto accade in varie parti del mondo occidentale (si pensi alla Brexit, al rafforzamento delle compagini populiste in Italia e in Francia, in Polonia e in Repubblica Ceca, in Ungheria ecc.) e quindi sta comprendendo che la cancellazione della sovranità è un pericolo per la sopravvivenza dei popoli?
“Il ciclo storico neoliberale ha subito, con Brexit e Trump, colpi durissimi, inferti da elettori in rivolta contro i processi di globalizzazione liberale. Nel 2016 gli oligarchi neoliberali che, attraverso la City of London, Wall Street e i colossi dell’e-commerce governano il mondo, hanno trovato avversari temibili e combattivi nei lavoratori e nei produttori “reali”, quelle maggioranze silenziose che, a prescindere dai propri orientamenti politici ed elettorali di riferimento (molti simpatizzanti di sinistra oggi votano per i “populisti”), hanno ribadito come l’intangibilità delle frontiere degli Stati nazionali sia il presupposto fondamentale per l’esercizio, nel perimetro dello Stato-Nazione, dei diritti democratici dei popoli sovrani. In Ungheria, per limitarci a un solo esempio, Orbán ha ripristinato la democrazia perché ha perfettamente capito che in regime di globalizzazione finanziaria, di revoca delle frontiere (nazionali, etiche, morali) e di primato di reti digitali hi tech (suicidio della sovranità nel “buco nero” dei mercati finanziari, monetari e valutari internazionali nonché nell’indistinta galassia di Internet) non può esistere alcun potere decisionale appannaggio dei ceti esclusi dalle citate dinamiche di globalizzazione. E i ceti esclusi e penalizzati dalla globalizzazione sono la maggioranza del corpo sociale ed elettorale dei Paesi della Ue. Ovviamente, le classi globaliste hanno, nel 2017, preparato e attuato la controffensiva (depotenziamento della proposta “isolazionista” trumpiana, elezione di Macron in Francia, tentativi di sabotaggio della Brexit in Gran Bretagna, ecc.). Tuttavia, la controffensiva globalista ha trovato risposta flebile da parte dei populisti, a loro volta divisi, spesso espressione di istanze rivendicative meramente patrimoniali di fasce sociali benestanti e “impaurite” dall’incedere inarrestabile dei flussi migratori dai Paesi africani, incapaci di individuare la contraddizione principale interna al conflitto di classe postmoderno (upper class transnazionali e transgender, o gerarchia dei “vincenti” della globalizzazione vs resto dell’umanità) e perlopiù votati da elettori protestatari poco disposti, per molti aspetti anche comprensibilmente, al confronto frontale e finale con le forze del Capitale sovranazionale. Il populismo resta, sostanzialmente, un mito incapacitante poiché ripiegato su una dimensione univocamente “patrimoniale” dei rapporti di forza, ma è comunque preferibile a qualsivoglia ipotesi globalista o “progressista””.
Globalizzazione e sinistra, un binomio che avrebbe dovuto conferire a Hillary Clinton la vittoria non ha sortito effetti. In Usa, o meglio in Occidente, la sinistra si sta smarrendo, la globalizzazione mostra la corda e non convince più quanto meno quei ceti sociali lontani dalla vulgata lib-lab, dall’ideologia tipica della finanza mondiale, quei ceti che registrano le maggiori difficoltà, quei ceti tanto disprezzati dalla Clinton che li definì “deplorevoli”?
“La sinistra occidentale mostra, con la globalizzazione, il suo vero volto, cioè quello del liberalismo culturale. L’insulto (déplorables) rivolto dalla Clinton agli elettori deprivati e periferici di Trump è perfettamente comprensibile alla luce dei riferimenti ideologici e culturali di chi l’ha pronunciato. Io credo che, oggi, i ceti e gli apparati ideologici (politici, giornalistici e accademici) della sinistra intesa come versante di adattamento politico e simbolico al postmoderno, siano i principali fattori di impedimento al dispiegarsi, anche solo in potenza, di qualsiasi ipotesi rivoluzionaria in campo politico, economico, sociale, culturale e scientifico. Per non parlare della geopolitica, che la sinistra tuttora finge di rifiutare degradandola a “pseudo-scienza nazista”, preferendo parlare di un Occidente “liberale” che autoistituisce, per se stesso, cioè per i propri ceti oligarchici e professional, il cosiddetto diritto di ingerenza negli affari interni di Stati sovrani da destabilizzare, invadere e porre sotto embargo stragista poiché giudicati incompatibili con il liberalismo culturale e le politiche di deregulation e privatizzazione in mani straniere in ambito economico. Oggi è noto a tutti, e solo Giorgio Napolitano si ostina a negare l’evidenza dei fatti (per motivi legati al suo essere diretto protagonista, dal versante atlantista, di quella stagione di guerra coloniale) che la guerra in Libia del 2011 fu un’invasione militare condotta da alcuni Paesi della Nato (Francia, GB, Usa) e dai loro alleati islamisti sunniti, del Golfo (Arabia Saudita, Qatar) e in loco (LIFG), per motivi meramente economici e volti a ingigantire i profitti delle multinazionali occidentali del petrolio ma allora, occorre ricordarlo, la guerra fu giustificata dai grandi organi d’informazione internazionali facendo ricorso alla narrativa liberale della “responsabilità dell’Alleanza Atlantica di proteggere” (R2P) i civili libici da presunti, e mai dimostrati poiché inesistenti, stermini di massa condotti, secondo il mainstream, dall’Aviazione di Gheddafi in Cirenaica. E i media liberal, nel 2011, non risparmiarono insulti, censure, manipolazioni e contumelie per ridurre al silenzio gli oppositori della guerra e legittimare il pretesto, “umanitario”, alla radice dell’invasione… La sinistra occidentale, oggi, è il partito della guerra “umanitaria”, dell’embargo istituito contro gli Stati ribelli e resistenti, della “rivoluzione colorata” nei Paesi da ricondurre nell’orbita atlantica e dell’apologia diretta dei processi di delocalizzazione (di uomini, merci, capitali e forza lavoro)”.
La retorica dell’antifascismo, in assenza del fascismo, che lei ha ben descritto nel suo libro, ha lo scopo di mobilitare, di inventare falsi miti e proprio per questo forse ora in Usa c’è la corsa alla repressione di associazioni di destra, la corsa ad abbattere i simboli politicamente scorretti sebbene ampiamente storicizzati, come la storia degli Stati confederati dell’Ottocento, le statue del generale Lee, Jackson ecc.
“La repressione delle associazioni di destra è riprovevole e c’è anche in Italia, non solo negli Stati Uniti! Questa repressione viaggia di pari passo con la russofobia. Si afferma infatti, e ciò è una stupidaggine come tale priva di fondamento, che vi siano i russi dietro le manifestazioni indette dai suprematisti americani a Charlottesville. L’obiettivo del mainstream è quello di assimilare la Russia, e il suo leader, Vladimir Putin, ai gruppi settari neonazisti americani. Tuttavia, come detto, la repressione delle associazioni di destra c’è, ma nessuno la denuncia, perché gli intellettuali borghesi “tengono stipendio, famiglia e reputazione” e non possono certo, anche qualora, ipotesi remota e puramente “accademica”, avessero una minima intenzione di farlo, condannare le misure repressive varate dallo “Stato democratico” contro associazioni formate perlopiù da attori politici e sociali considerati déplorables dal mainstream giornalistico. Procediamo con ordine. Sui monumenti: l’abbattimento e la rimozione sono veri e propri tentativi di memoricidio. Consiglio a tutti, invece di abbattere le statue che raffigurano i protagonisti della Confederazione, di leggere il libro di Dominique Venner, Il bianco sole dei vinti (Settimo Sigillo, Roma, 2015), un testo che rappresenta, in una prospettiva storiografica rigorosa, i fatti riconducibili alla guerra civile americana del 1861-1865. Lo stesso per la Spagna, dove il governo “socialista” (in realtà liberista) di Zapatero fece rimuovere la statua di Franco da una delle piazze principali di Madrid adducendo come motivazione per questo gesto la necessità di completare, anche a livello simbolico, la “transizione democratica” iniziata nel Paese all’indomani della morte del Caudillo (novembre 1975) e, contestualmente, varò leggi che implementarono i processi di precarizzazione sociale. Oggi in Spagna non ci sono più statue “fasciste” ma il 60 per cento dei giovani è disoccupato. Eppure, nessuno, tra gli intellettuali del mainstream, oserebbe affermare che la Spagna non sia un Paese democratico. A mio avviso non lo è, perché nessun Paese che fonda la propria economia sul lavoro flessibile e precario e sull’utilizzo della disoccupazione giovanile di massa come esercito industriale di riserva, sottopagato, impiegato a intermittenza, sfruttato e perennemente ricattabile, può essere definito democratico. Sulla repressione: pur non essendo io particolarmente di destra o di sinistra, bensì antiglobalista (la globalizzazione è un fatto totale onnicomprensivo, che si riproduce a destra in economia e a sinistra nella cultura), condanno apertamente i divieti prefettizi alle manifestazioni indette dai partiti neofascisti. Anche qualora mi trovassi nella condizione, come spesso accade, di non condividere i presupposti di quelle manifestazioni. Invece viviamo nella condizione, paradossale, in cui lo Stato che si definisce, impropriamente peraltro, “democratico” (in realtà viviamo in una oligarchia di ricchi, non c’è alcuna democrazia, non vengano a prenderci in giro…), incentiva le espressioni di sciovinismo funzionali a consolidare il globalismo imperialista e la società di mercato nei costumi (gay pride) e proibisce le dimostrazioni scioviniste che si collocano in opposizione al politically correct (“Marcia dei patrioti”). E questo è inaccettabile! Lo Stato non può essere selettivo, sancendo per decreto l’esistenza di sciovinismi “buoni” (gay-friendly e ogni espressione di minoranze globaliste e “creative” strumentali a legittimare l’ordine “liberal-cosmopolita” esistente e a recuperare consensi al regime) e sciovinismi “cattivi” (etnonazionalismi) poiché considerati incompatibili con il politically correct. Tuttavia, lo Stato occidentale postmoderno non solo è selettivo, ma è addirittura ideocratico, esattamente come, a loro tempo, lo furono il Terzo Reich e l’Unione Sovietica. Come scrisse Costanzo Preve in un libro pubblicato da Settimo Sigillo qualche anno fa, l’«ideocrazia imperiale americana» è il Credo dispotico di riferimento delle élite politiche prive di coscienza infelice che amministrano, in conto terzi, i Paesi della Ue. Naturalmente, nessuno tra i cosiddetti intellettuali à la page si sognerà mai di prendere posizione contro le misure repressive e censorie varate dallo “Stato democratico” contro le organizzazioni di destra poiché ciò significherebbe, in qualche modo, assumere, benché in maniera indiretta, le parti dei “proscritti della Storia” e obiettivamente non conviene ad alcuno, tra i giornalisti e gli accademici manipolatori di cui sopra, porsi volontariamente fuori dal perimetro della struttura di potere politically correct che li ha cooptati e che li mantiene. Rendite di posizione (economiche e di status) e vanità (scrivere su “la Repubblica”, “La Stampa” o il “Corsera” è “sempre meglio” che farlo sull’ultimo samizdat di provincia o quartiere) fanno sì che, per i più, sia pressoché impossibile rinunciare alla cooptazione in luogo della dignità. Il problema, dunque, non è stabilire quale sciovinismo identitario sia “buono” o “cattivo” per definizione, ma cominciare a ravvisare nel Politicamente Corretto il versante culturale entro cui si articola la Forma Capitale e mobilitare il numero più elevato possibile di attori politici e sociali, a prescindere dalla loro identità etnica, condizione di censo e riferimenti politico-culturali, nella lotta senza quartiere contro la teologia del progresso, il capitalismo liberale e la società di mercato”.
Il sovranismo in Europa non è omogeneo ma sta crescendo un sentimento forte contro i partiti tradizionali. Addirittura adesso la sinistra scopre una parola d’ordine sull’immigrazione che da almeno vent’anni era la proposta principale della destra: “Aiutiamo i migranti a casa propria”. Che sta succedendo? Hanno ragione i populisti?
“Non nutro alcuna fiducia nelle classi dirigenti della sinistra “di governo”. Per costoro “aiutare i libici a casa propria” significava foraggiare, con soldi e armi, i jihadisti internazionali combattenti in Cirenaica per deporre e assassinare Gheddafi, leader dello Stato sovrano libico internazionalmente riconosciuto. I liberal, i fautori della guerra “umanitaria” e della teoria dell’esportazione del caos all’estero ragionano in questi termini: l’Occidente, in virtù di un (invero inesistente) primato morale che le sue élite globaliste si arrogano in quanto soggettivamente “progressiste” ed “emancipate” dai tabù patriarcali caratteristici dell’epoca del capitalismo “autoritario” (1810-1990 circa), ha il “dovere” di intervenire, con i dollari o con le armi, per rimuovere le “dittature” considerate ostili agli interessi delle multinazionali anglo-americane in Medioriente o nell’area eurasiatica (ex Urss) e, pertanto, “liberare” (ossia, mettere a disposizione dei dispositivi di controllo sociale e delle esigenze economiche del capitalismo liberale) le popolazioni precedentemente soggette a codesti “regimi”. Dopodiché, a guerra “umanitaria” avvenuta, sarà “il mercato” a decidere il destino dei popoli ricolonizzati… Non ho alcuna fiducia in chi si rifà a una simile concezione dei rapporti internazionali e tra Stati! Per quanto mi riguarda, la sinistra liberale e radical-chic, da Renzi alla Boldrini, così come la destra liberale che difende il capitalismo politico-economico e, contemporaneamente, pretende la conservazione dei “valori culturali pregressi” (cosa impossibile perché il capitalismo, per definizione, è tutto fuorché conservatore e tende a spezzare i legami comunitari preesistenti e non certo a costruirne di nuovi), ha più nulla da dire e riproduce sistematicamente la formula dicotomica del bipolarismo solidale centrata sulla rissa televisiva per questioni di furti (i politici di professione che si accusano vicendevolmente di “rubare”) e gossip (i politici di professione che vantano scappatelle estive con questa o quest’altra show girl) tra berlusconiani e antiberlusconiani, esclusivamente allo scopo di puntellare, grazie al circo mediatico di legittimazione dello spettacolo profano basato sul duello fittizio sinistra/destra, un regime altrimenti in crisi terminale di consensi e credibilità. Un regime che esercita un dominio dispotico senza egemonia sui ceti popolari (mentre vanta una effettiva egemonia culturale soltanto sulla nuova classe media globalizzata). I sovranisti potranno dirsi tali nel momento in cui capiranno che il nemico principale non è il migrante ma le élite transnazionali e transgender della e-economy (o economia “4.0”) che, in nome di un surplus sempre crescente di profitti aziendali, promuovono, organizzano e sfruttano i flussi migratori alla stregua di una vera e propria tratta dei negri tradotta nell’ambito dei codici culturali simbolici di adeguamento (politically correct) caratteristici della postmodernità. I sovranisti potranno dirsi tali, ed essere credibili, nel frangente in cui capiranno che in un contesto di guerra di classe globale strutturata attorno alla dicotomia flussi/luoghi, lo Stato potrà essere veramente democratico soltanto previo/a ripristino della propria leva monetaria, valutaria e fiscale interna, reintegro del controllo pubblico sulle frontiere, abolizione delle leggi anti-popolari sulla deregulation del cosiddetto “mercato del lavoro” e dei trattati neoliberisti imposti dalla tecnocrazia transatlantica di Bruxelles a popoli e nazioni del Vecchio Continente, nonché stipula di accordi politico-militari con attori geopolitici alternativi al dominio atlantico (Russia in testa)”.








