
Negli ultimi anni è balzato alla ribalta dei quotidiani di tutto il mondo il “Drago cinese”, la forte economia cinese, la liberalizzazione parziale del mercato in quella parte vasta dell’Asia e la crescita davvero notevole, se paragonata alla condizione economica di qualche decennio fa.
Ma qual è stato il percorso che in Cina è stato intrapreso (ancora non concluso), quale politica economica è stata scelta e perseguita da una nazione immensa che per secoli ha vissuto in miseria?
L’ultimo numero del trimestrale Eurasia fa il punto su questi temi e su questo momento cruciale della storia della Cina spiegando i passaggi storici e politici che il Paese ha dovuto superare soprattutto nei periodi di maggiore crisi, non solo interne ma soprattutto quelle emerse nei periodi di frizione con l’Urss e nel lungo periodo della guerra fredda…
Così, nell’introduzione al fascicolo, a cura del direttore Claudio Mutti (La muraglia che non crolla) viene analizzata la battaglia finanziaria combattuta nell’estate scorsa, quando le borse asiatiche registrarono colossali perdite: solo l’8 luglio Shanghai perse il 5,9 per cento e Shenzen il 2,5 per cento. In totale, nello spazio di due settimane, la perdita globale fu quantificata in 3.700 miliardi di dollari. Cinque esperti cinesi di economia definirono queste perdite frutto di terrorismo finanziario citando, in uno studio redatto appositamente, il “terrorista finanziario” George Soros, definito “burattinaio” di Barack Obama. Non solo: nel giro di pochi giorni il Consiglio di Stato cinese informò il Ministero degli Esteri russo che “uno stato di guerra de facto esiste ufficialmente fra la nazione asiatica e gli Stati Uniti d’America”. Comunicazione contemplata nell’Accordo russo-cinese sulla sicurezza cibernetica, siglato nel maggio scorso, secondo il quale una delle due potenze deve informare l’altra se ha fondati motivi di ritenere che possano scoppiare le ostilità con una terza potenza. Un’informazione obbligata per consentire all’alleato di prepararsi alla difesa. Episodio importante che mostra bene i livelli di scontro che in più d’una occasione vengono sfiorati e magari non vengono percepiti dall’opinione pubblica come episodi di guerra a “bassa intensità”.
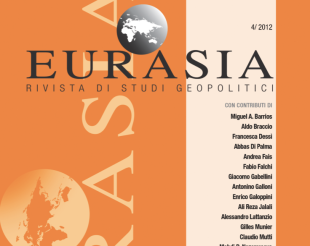
Segue, nel fascicolo, un ampio saggio di Spartaco Puttini sul socialismo cinese. Puttini spiega che a partire dall’epoca di Deng Xiaoping, è stata avviata una politica economica che contempla l’apertura del libero mercato (mantenendo i mezzi di produzione di proprietà statale), un po’ come fece l’Unione sovietica nel 1921-1929 con il piano economico Nep. Inoltre, in questo processo innovativo, in Cina fu data importanza al valore nella produzione. Insomma, un socialismo di mercato che utilizzava – e uilizza – le armi della globalizzazione contro i globalizzatori. Certo tutto questo tenendo ben presente la lezione e le esperienze dell’Unione sovietica prima e della Federazione russa dopo. Un processo innovativo, quello della Cina, che è stato accompagnato anche da una ridefinizione ideologica necessaria per coniugare l’apparato statale, le dinamiche del partito unico e la nuova economia.
La questione del popolo uiguro
Il direttore Claudio Mutti analizza le tendenze separatiste degli uiguri nello Xinjiang e Giacomo Gabellini dimostra come quella regione (chiamata Turkestan orientale da Arabi e da Turchi) abbia un ruolo strategico nella “Via della Seta” e comunque causi difficoltà alla Cina. Non mancano articoli di carattere storico, utili per inquadrare le premesse della situazione attuale economica e politica: fra questi, uno sulle tradizioni culturali e spirituali del Tibet a cura di Marco Costa. Reg Little analizza in un breve saggio il comunismo di Mao e seguono articoli di economia sulla Cina e la banca dei Brics, il ruolo della Cina nell’Asean (Associazione delle nazioni del Sud Est asiatico), le operazioni della banca d’investimento cinese, il turismo e le sue potenzialità e l’accordo sul gas fra Cina e Russia. Segue una nutrita sezione di documenti e la riproposizione di un saggio di Ugo Spirito del 1961, sulla “nuova Cina”, e uno del 1948, di Giuseppe Tucci, sulla preistoria tibetana.
(Eurasia n. 2 del 2015; Edizioni All’Insegna del Veltro, pagg. 214, euro 18. Per ordini: www.eurasia-rivista.org)








