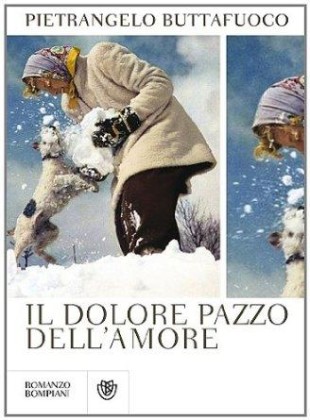 Dopo giorni di vacanza, cenoni parentali di ferreriana memoria e grandi emigrazioni che mi hanno riportato dall’isola alla grande città, mi decido a riprendere il registratore e riportare qui l’intervista realizzata il 26 di dicembre, per Santo Stefano dell’anno che fu, in un bar della sempre più – ahimè! – desolata via Etnea di Catania a Pietrangelo Buttafuoco. Tra cioccolata calda e pizza con l’acciuga.
Dopo giorni di vacanza, cenoni parentali di ferreriana memoria e grandi emigrazioni che mi hanno riportato dall’isola alla grande città, mi decido a riprendere il registratore e riportare qui l’intervista realizzata il 26 di dicembre, per Santo Stefano dell’anno che fu, in un bar della sempre più – ahimè! – desolata via Etnea di Catania a Pietrangelo Buttafuoco. Tra cioccolata calda e pizza con l’acciuga.
Pietrangelo, il suo ultimo libro, Il dolore pazzo dell’amore, ha molto a che fare con la forma popolare del “cunto”. In che cosa consiste questa parentela?
«Io non avevo idea di cosa fosse il cunto, se non attraverso quello che avevo cucito addosso alla mia pelle, nella mia memoria. Il cunto lo incontravo spontaneamente nelle mie giornate da bambino, attraverso tutti i personaggi di quello che, con gli occhi di oggi, può sembrare un presepe, ma che era invece un paese che riusciva ad essere mond, dove ognuno aveva la capacità non solo di fare racconto, ma aveva anche la capacità di mettere in scena quei fatti, di farli vivere, di far sì che le parole – o la Parola in senso alto – non fossero qualcosa di algido, di concluso, ma fossero rese vive. Una Parola vivificata proprio dalla capacità di far muovere i personaggi, i fatti, i contesti, e quindi di raccontare. Le storie, poi, diventavano sempre più pressanti man mano che crescendo incontravi la vita. E ti capitava, a volte, d’incontrare qualcuno che stava dalla parte del male e, altre, chi stava dalla parte del bene.
Vi è poi questa specificità, credo, legata a quel tempo che ho vissuto, dove un bambino aveva la possibilità di nutrirsi della memoria dei propri genitori, dei propri nonni, dei propri avi, di farsene mondo e farsene scudo. Il cunto era questo modo di raccontare. Non ne avevo idea, l’ho avuta dopo aver scritto il libro, quando Silvano Nigro ha trovato la formula in cui mi riconosco, che è quella del Diwan, il canzoniere. Il mio libro si apre con Ibn Hamdīs e si chiude con Ibn Hamdīs proprio perché è cantato».
Parlando di incontri e di storie, ha parlato di bene e male. In quel mondo che era Agira, non vi era traccia di relativismo…
«Eppure non nel senso manicheo: vi era un nutrimento reciproco, era un capire e conoscere la vita attraverso tutte le sue sfumature. C’era il ragazzo che, magari, decideva il passo verso il suicidio, a cui subito rispondeva una sana reazione di popolo attraverso la quale questo gesto non veniva compreso bensì risultava inaudito, veniva esorcizzato o con un paio di ceffoni o con la risata, con l’incomprensione nei confronti di un linguaggio che sembrava astruso (la famosa frase “ho il dolore della vita”. E tutti si guardavano con aria interrogativa: “che sarà mai questo dolore della vita!?”)».
 In un certo senso, però, Agira, al di fuori del suo libro, è Mondo, ovvero è stato crocevia di culture, centro di quel centro che è tutt’ora il Mediterraneo. Che ne pensa?
In un certo senso, però, Agira, al di fuori del suo libro, è Mondo, ovvero è stato crocevia di culture, centro di quel centro che è tutt’ora il Mediterraneo. Che ne pensa?
«Se per crocevia di culture intendi la memoria di quei luoghi, dove convivono una traccia islamica, una traccia greca, una romana, una medievale profondamente segnata dall’attività di un santo, beh… sì. Ma la percezione di tutto ciò è riconoscibile in una determinata fase della nostra memoria, non dopo, non adesso. Non adesso. Non adesso perché tutto il nostro mondo è stato livellato in una sorta di unico dormitorio dove vi abitano anime compranti, consumatori e nient’altro. Non c’è più nessuna possibilità, se non quella di vivere un’apnea rispetto a quella memoria».
Secondo lei potranno, un giorno, queste nostre terre uscire dal limbo in cui sono cadute?
«Abbiamo necessità di sangue nuovo, e questo può derivare solo dalla possibilità che immigrati scelgano di venire a ripopolare queste terre, la maggior parte delle quali erano terre loro nel passato. Io ritengo che anche la condizione stessa in cui si è ridotta la nostra terra, ciò in cui è stata trasformata, una pura periferia, pura deriva, un luogo dove non accade niente, sia stata determinata dal fatto che siamo scappati da noi stessi. Abbiamo rinunciato alla bellezza, abbiamo rinunciato alla grandezza, abbiamo rinunciato a tutto ciò che contraddistingue l’idea del nostro abitare. Freddamente: abbiamo uno dei posti più incantevoli, più belli, ma è anche il posto più lordato, più sporcato, più infangato, ridotto a una condizione di minorità sociale e culturale spaventosa. Siamo noi stessi ad aver rinunciato alla nostra identità, la nostra Storia, la nostra bellezza».
Parliamo un po’ della scrittura della sua ultima opera. Nella prosa, in questo evocare quasi in preghiera, c’è una volontà di veicolare quello che possiamo chiamare sentimento poetico, spirito, la Parola…
«Sì, attraverso le emozioni. Premessa: io non mi ritengo un intellettuale. Forse neppure uno scrittore. Però, un artista, sì. Io credo profondamente nella fatica dell’artista, e io a quella mi voglio riferire. E ritengo che la scrittura, allo stesso modo delle arti figurative, come di qualsiasi altra forma di espressione, cammini sull’onda dell’emozione, e le emozioni hanno la possibilità di raccontare e di chiudere in una gabbia – che altri immaginano essere quella della logica – dei racconti, dei fatti che vengono svelati nella loro essenza».
Il “dolore pazzo dell’amore”: quanto questo dolore pazzo ci è necessario per essere uomini?
«È banale tutto ciò che io provi a dire, è banale e ne ho quasi pudore, ma banalmente dico che è così, è così perché sarebbe una beatitudine idiota quella di immaginare tutto nell’ambito di chissà quale gioia precostituita. Io immagino che non ci sia un Nirvana da cui ci siamo staccati. C’è semmai un sorriso fondamentale, un’ ἀρχή (arché) che è quello che un bimbo ritrova nel sorriso della madre nella culla, quello della mezzaluna che saluta la volta del cielo. Quello della risata argentina di Krishna, la divinità bimba, che con un suo solo respiro riesce a far sollevare il Cosmo, a renderlo tale. Però qualunque altra cosa mi risulta banale, se non altrimenti immaginando la nostalgia. Sono stato sempre turbato rispetto a una riflessione: chissà cosa prova il Diavolo, rispetto a tutti gli altri. Poiché è l’unica creatura ad aver conosciuto Dio, l’unica tra le creature a non aver la necessità della fede, a non avere bisogno neppure della conoscenza, per intraprendere una strada. E da ciò ne ho ricavato una convinzione: ognuno di noi ha un dovere di nostalgia. Per cui il dolore deriva dall’incapacità, spesso, di far fronte a questo percorso di conoscenza e di ricordo. Il dolore c’è perché, nella pazzia dell’amore, siamo impediti a poter afferrare quello che abbiamo visto. Però, ripeto, tutto inevitabilmente mi diventa banale. Attraverso le sensazioni so spiegartelo, e magari so utilizzare le pennellate adatte per fare il quadro, ma attraverso una costruzione logica mi rendo conto che neppure Kant riuscirebbe a svelarlo».
Domanda provocatoria. Un parere sul panorama letterario di oggi.
«Penso che la la letteratura in forma di romanzo sia diventata come la poesia, una materia che ormai tocca poche corde, nel senso che pochi cuori hanno a disposizione queste corde per nutrirsene. Molti cercano rifugio nella dimensione intellettuale, perché è quella più comoda, quella che determina lo status di guru, di pifferaio, di carismatica guida attraverso cui dispensare le proprie perle. Una volta mi colpì, in metropolitana, una bellissima ragazza, molto elegante, graziosissima, concentrata sulla lettura di un libro. E mi incuriosii, cercando di capire quale poeta fosse, quale grande romanzo, quale pagina di letteratura potesse coinvolgere così tanto questa ragazza: stava leggendo un libro sugli affari della famiglia Moratti. Ne restai sconvolto: immaginavo fosse Prévert, Campana, Dostoevskij, e invece no. E questo mi ha fatto capire che ormai è venuto meno il pubblico, è venuto meno chi ha la voglia di potersi infilare in queste pagine. Per cui, se mi chiedi come io giudichi il panorama letterario, ti dico che noi abbiamo una grande tradizione, anche recente: il fatto di aver avuto un poeta immenso come Dino Campana, che non viene studiato nelle scuole; di aver avuto Giuseppe Berto, che non viene studiato nelle scuole; di aver avuto grandi geni come Carmelo Bene, che non viene studiato nelle scuole. Tutto questo la dice lunga. Ti fa capire che oramai c’è uno stacco che non è solo quello derivato dalla capacità di trasmettere il sapere e di farne patrimonio, ma anche uno stacco rispetto alle discipline, alle arti stesse, alle muse. Le muse si saranno annoiate pure, però è un fatto che la letteratura – romanzo o poesia – sia diventata lingua morta, un retaggio forse per abitué – tant’è vero che chi pratica la letteratura si ritrova in luoghi che sembrano delle jazz session, sono pochissimi a conoscerli. Oggi, invece, trionfa il non-prodotto. L’altro giorno leggevo l’intervista al direttore generale di un importante gruppo editoriale, il quale affermava che “bisogna rivolgersi ai non-lettori”, ma nel rivolgervisi era implicito il ragionamento: “ bisogna rivolgersi a un target al quale dare un prodotto che non è il libro, ma il non-libro”. Con tutto il rispetto per quella che era una volta la letteratura d’intrattenimento, c’è un passaggio spaventoso di differenza. Se oggi possiamo dire che un Paolo Villagio tiene testa ad un Achille Campanile, nel senso che Achille Campanile avrebbe apprezzato Paolo Villaggio e ne sarebbe stato compiaciuto del paragone, adesso non corrisponde più nessuno, nell’intrattenimento, che possa rispondere al canone. Una volta si faceva la distinzione tra Gabriele D’annunzio e Guido Da Verona: D’Annunzio era per chi riusciva a capire Alcyone; Guido Da Verona era fatto per chi non arrivava a quel livello. C’era un solco. E c’era anche un’altra Italia: l’Italia che riusciva a capire le battute del quartetto Cetra quando diceva “Una lacrima sul Griso”. L’Italia di oggi non lo capirebbe. Quindi non ti dico che è desolante il panorama della letteratura oggi, è desolante il pubblico. È desolante perché la capacità di riflessione, ricezione, gestione delle emozioni è pari a zero. Nessuno è più in grado di avere una soglia di attenzione che vada oltre il minuto e mezzo. E le forme della poesia, dell’emozione, della coralità, forse le assolvono altri mezzi.
La cultura, la letteratura, la trasmissione dei saperi non sono una competenza pura degli eruditi: è puro sangue di popolo. E quando un popolo non è più in grado di nutrirsi di tutto questo, è già destinato a essere qualcos’altro, clientela forse, target perfetto per soddisfare le esigenze di quel direttore generale di un importante gruppo editoriale che ha bisogno di non-lettori, perché daranno prodotti, e non libri.
Non ci resta che affidare la cultura alla desolante mano invisibile, se il pubblico è diventato clientela?
Per dirla con Camille Paglia, ci sono dei totem altamente seduttivi nelle arti che passano attraverso canali che non riusciamo più a controllare: il nostro Pantheon attuale è un flusso di immagini in cui noi riconosciamo come divinità immediata la mela di Apple, Facebook, Twitter, e tutta una serie di brand o loghi che sono diventati i nostri riferimenti. In mezzo a tutto ciò, c’è qualcosa che cammina e si consuma velocemente per cui, ad esempio, un capolavoro della letteratura della nostra memoria recente, quale il Signore degli Anelli, è diventato un prodotto di largo consumo. Che cosa è arrivato al grande pubblico? Certe volte arriva la parodia, certe volte il merchandising per chi vuole aprire rivendite di bastoni di Gandalf… Insomma, è tutto un ribaltamento del principio di Carlo Marx, per il quale tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria. Ora tutto ciò che era dissolto è diventato solido, tutto ciò che era dissolto nell’etica, nel racconto, nella poesia, è diventato materia. Probabilmente sono altri i percorsi che bisogna seguire. Però è anche vero che la danza dell’apprendista stregone di Topolino o l’immagine di Semola che estrae la spada dalla roccia, sono realizzazioni materiali di un intuizione epica che ha attraversato i tempi. E lì interviene un principio che probabilmente se ne fa beffe, di tutto ciò: per quanto siamo capre noi, ci sarà qualcuno che sarà lupo, e deciderà il linguaggio proprio del tempo, dello Zeitgeist, lo spirito del tempo. Qualcuno che avrà più alfabeto di noi. Gli indiani, ad esempio, riescono a fare prodotto commerciale della loro memoria ancestrale, perché Bollywood non è altro che la riproposizione della grande tradizione dei Veda in forma pop. Ed è una cosa impossibile per noi. Noi, a Cinecittà, non riusciremmo mai a fare un musical dall’Eneide, non riusciremmo a trarre un film neppure dalla tradizione greca, perché manca nel pubblico la familiarità verso certe cose… Mentre lì diventa anche motivo commerciale, perché già le loro star somigliano a Shiva, alla dea Kali, a Gilgamesh per andare in ambito mediorientale; oppure in Iran che, per quanto sia una repubblica specificatamente islamica, invece, ha un saldo legame con la propria tradizione zorohastriana, con la propria memoria. E questo è il mondo di domani. E allora ciò che resta da chiederci è questo: perché, se il mondo di domani è così pieno della propria memoria ancestrale, noi, che abbiamo concluso la nostra fase, non abbiamo più altro deposito, altro bagaglio se non quello che ci è stato costruito in epoca recentissima, solo per renderci consumatori e basta?








