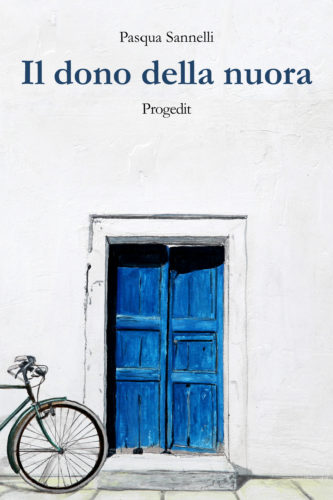
Il dono della nuora (Progedit), opera prima di Pasqua Sannelli, dirigente scolastico in quel di Laterza, è un lungo romanzo di genere realistico scritto in terza persona e ambientato in un periodo storico che va dal primo dopoguerra fino al referendum tra monarchia e repubblica del 1946 nel quale si intrecciano varie storie familiari.
Diciamo subito che la Sannelli ha certamente talento narrativo, che mostra soprattutto nella descrizione, a tratti poetica, dei luoghi che fanno da cornice alle vicende, come la fontana Venere «con le sue arcate tardo-medievali e i lavatoi consumati, dove la notte chiacchierano e ridono i fantasmi delle donne di una volta»; o come la gravina, le cui pareti «degradano verso il mare che è andato lontano lasciando nella pietra conchiglie e pesci fossili. Vi si arrampicano, come monili, i fichi d’india». E lo dimostra anche nel tratteggiare varie situazioni, come quella tra Luigi e il gatto:
«l’uomo parlava e il gatto lo ascoltava con enigmatica attenzione che, a tratti, aveva qualcosa di umano»; o come quella, assai efficace, in cui descrive il primo voluttuoso incontro d’amore tra Peppino e Maria: «non conoscevano parole comuni per vestire l’attrazione magnetica e incontrollabile dei corpi: era la terra assetata che cercava l’acqua, l’onda che veniva da lontano per abbracciare la sabbia ardente».
La scrittura è generalmente scorrevole, fluida, a tratti cruda, con qualche caduta qua e là, come, ad esempio, l’uso del termine «arrapare». Quel che invece, a nostro avviso, nuoce alla narrazione sono i troppi nomi, le troppe storie secondarie, le troppe minuzie, in cui il lettore rischia di perdersi. Una maggiore stringatezza avrebbe giovato all’architettura del romanzo.
Non condivisibile è invece la visione manichea e ideologica sottesa alla narrazione, dove i buoni sono l’impiegato socialista Luigi e il proprietario liberale Don Giuseppe e i cattivi i fascisti, descritti secondo lo stereotipo del fascista tronfio, intollerante, violento. Opportunisti, infingardi, violenti, corrotti, d’altra parte, allignano in tutti i regimi e sotto tutti cieli. Gli stessi personaggi, calati in altre situazioni storico-politiche, avrebbero seguito medesime pulsioni e scelte di vita. Il male, che l’autrice individua a torto nel fascismo, è, a ben vedere, un male metafisico, è il male insito negli esseri umani. Verità questa che la stessa Sannelli finisce in qualche modo per riconoscere, quando nell’ultima pagina del romanzo mette in bocca all’amico fantasma, il marchese don Pietro, queste parole: «nessuno può chiudere il cerchio della storia».
Spicca tra i tanti personaggi la travagliata storia del socialista Luigi che per fedeltà alle sue idee socialiste rifiuta di prendere la tessera del partito fascista, esponendosi a intuibili ritorsioni. Ci chiediamo: quale socialismo ha in mente Luigi, così sensibile a «i furori del fascismo»? Quello libresco di un’ingenua e testarda utopia? Oppure quello reale di stampo sovietico, infinitamente più repressivo e sanguinario del fascismo italiano?
Quando Benito Mussolini nel 1944 dichiarava che «la socializzazione altro non è se non la realizzazione italiana, umana, nostra effettuabile del socialismo», questa affermazione non era affatto campata in aria, o peggio velleitaria, ma era supportata da fatti indubitabili, aveva dietro di sé un’imponente legislazione sociale e un’altrettanto imponente realizzazione. Come scrivono Pino Rauti e Rutilio Sermonti nella loro Storia del fascismo: quella del fascismo fu «un’opera che ebbe anche un profondo retroterra giuridico-culturale […] e che conobbe anche gli incalzanti ritmi delle decisioni che diventavano in poco tempo case, strade, acquedotti, intere città e cittadine sorte dove per secoli o era stata malaria, palude pestifera, o desolazione vuota di speranza». La lotta alla mafia, l’eliminazione della malaria, le bonifiche, le infrastrutture, erano condizioni indispensabili per un miglioramento reale delle popolazioni rurali in genere. In nome del «ritorno alla terra» si «trasformava decine di migliaia di famiglie, per lo più di coloni e braccianti poverissimi, in proprietari di aziende, poderi e fattorie». Con questo non si vuole certo negare che ci furono ritardi, resistenze delle vecchie classi privilegiate, errori. Ma quel che importa, storicamente, era la direzione di marcia, l’incontestabile «opera di innovatrice promozione sociale».
Una caduta di livello si avverte nella seconda parte del romanzo, a cominciare dal XVII capitolo. Attribuire al fascismo la «soluzione finale» e a Mussolini la volontà di «far fuori» gli zingari, raccontare che i tedeschi dopo l’8 settembre sparassero a qualunque inerme paesano trovato per strada o stuprassero le donne (cosa invece che accadde davvero nella Ciociaria, dove le truppe di colore “alleate” si abbandonarono alla pura bestialità, tanto che fu coniato il termine “marocchinate” e ne scrisse Alberto Moravia nel romanzo La ciociara), non solo non risponde alla verità storica, ma pure pedagogicamente è un errore. Che senso ha rinfocolare odi postumi a distanza di più di settant’anni dai fatti sulla base peraltro non di fonti storiche, ma di aneddoti, di labili ricordi, di pregiudizi ideologici? Ricordiamo a noi stessi le parole del filosofo Benedetto Croce: «la vera storia non nega ma giustifica, non respinge ma spiega, non conosce figli bastardi e degeneri, ma solo figli legittimi».
Nel finale i toni un po’ cupi dei precedenti capitoli si distendono grazie anche al presentarsi di una nuova e illusoria situazione politica rappresentata dalla imminente nascita della Repubblica e dal dono della nuora, che dà il titolo al romanzo e che consiste nel garofano rosso che la nuora appunta sull’occhiello del suocero Luigi a significare la speranza di un riscatto sociale. Sennonché il mondo nuovo che a mano a mano prenderà forma nell’orizzonte storico mondiale avrà piuttosto i tratti angosciosi di quello descritto da Aldous Huxley nel suo omonimo romanzo che di quello sognato da Luigi in questo romanzo.








