
Ci eravamo già occupati dell’opera prima di Fabiano Spessi, L’arte dell’incontro, un paio d’anni fa sulle pagine di Barbadillo. Ora ci è pervenuta una seconda raccolta, Una promessa di felicità (Giuliano Ladolfi editore, pp. 87) composta da sessantasei componimenti, omogenei per tematiche e stile, che si collocano in un’ideale continuazione con l’opera precedente. Anche qui il poeta ci presenta una galleria di personaggi e di luoghi della sua Milano, ritratti, come scrive nella prefazione Giulio Greco, “con un tratto di garbato realismo, a volte condito con ironia, ma sempre con rispetto, con profonda pietas e simpatia”.
La Milano di Fabiano Spessi, ci fa pensare, si parva licet componere magnis, alla Spoon River di Edgar Lee Masters: in questa sono i morti a raccontarsi, a parlare di una vita vissuta e ormai compiuta, a trarre esplicitamente una morale; nell’opera di Spessi invece ad essere raccontati sono i vivi, colti nel presente con le loro angosce, le loro frustrazioni, i loro progetti piccoli piccoli e la morale da trarre è lasciata spesso al lettore. Così, esemplificando, c’è il giovanotto che sogna il bilocale a due passi dall’ufficio e che in attesa del colloquio di lavoro si fa un selfie davanti alla casa agognata: “Il futuro ti sorride / anche se / ne hai solo / un’immagine / sullo smartphone.” (Selfie); c’è il guidatore d’uno scuolabus che pensa “che in America / la sua esistenza sarebbe diversa / e che anche gli ingorghi / avrebbero un sapore diverso / ma la sua vita / si gioca qui / in questa città” (Scuolabus); o l’atleta mancato, benché provvisto di talento, che ha un lavoro da asfaltista a cui, “a furia di straordinari”, “hanno divelto / il sorriso dalla faccia.” (Talento da vendere); c’è ancora il commesso part time separato dalla moglie che vede la figlia solo due domeniche al mese, al quale “la libertà di cui gode / sembra un’ordinanza restrittiva a vita.” (Ordinanza restrittiva); e c’è il nudo proprietario che non sa se può rallegrarsi del fatto che il vecchio usufruttuario non compare da alcuni giorni nel bar in cui di solito andava a pranzare, mentre nel bar “gestito dalla famiglia cinese / che lo aveva quasi adottato / c’è un gran vociare di clienti / che ne ricordano / i vezzi i vizi / le abitudini e le manie” (Nuda proprietà). Serpeggia a volte nei vari personaggi un’ansia sotterranea, inconscia di felicità, che viene repressa dalla precarietà del vivere e dalla società dei consumi: “La luce stonata del bar / e le voci scomposte dei clienti / le misero addosso / una malinconia / che non accennava / ad andarsene. /Così decise / di tornarsene / a casa / dove l’aspettava / un uomo con gli occhi lucidi / a fissare un televisore spento. / Lei gli chiese di ballare / e lui all’orecchio le disse: / è dura, ma ce la faremo. / Quella notte / fu l’inizio / di qualcosa di nuovo, / nuovo e inaspettato.” (E’ dura, ma ce la faremo). Ed ancora: “E dopo dodici mesi di letargo / Carlo decise / che finalmente / era giunto il momento / di scendere di nuovo per strada. / Vada come vada / prenderò il largo / anche se nessuno mi aspetta / sono tutti / in cerca di me. / Vide dei babbi natale / appesi alle finestre / supermercati affollati / per le feste di fine anno / nuovi quartieri sorti / in vista dell’Expo / e certi sorrisi dal vivo / che aveva dimenticato / persino di sognare. / Rimase per un istante / in contemplazione / e poi riprese a camminare: / nelle vie e nelle piazze invase dal sole / Carlo leggeva una promessa / di raggiante felicità.” (Una promessa di felicità – prima parte).
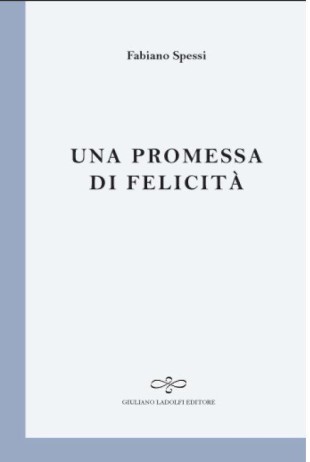 Ma tra i personaggi, a sorpresa, fa capolino anche il poeta che, smessa la sua veste di osservatore, si fa tutt’uno con l’umanità dolente e desolata che descrive, fino a trovare nello spettacolo della natura uno stato di grazia: “La luna piena / sul campo di calcio / è di una bellezza commovente. / Nella notte più fredda /dell’inverno tutto tace. / E’ il mio compleanno e sto bene. / Sono felice.” (La notte del mio compleanno).
Ma tra i personaggi, a sorpresa, fa capolino anche il poeta che, smessa la sua veste di osservatore, si fa tutt’uno con l’umanità dolente e desolata che descrive, fino a trovare nello spettacolo della natura uno stato di grazia: “La luna piena / sul campo di calcio / è di una bellezza commovente. / Nella notte più fredda /dell’inverno tutto tace. / E’ il mio compleanno e sto bene. / Sono felice.” (La notte del mio compleanno).








