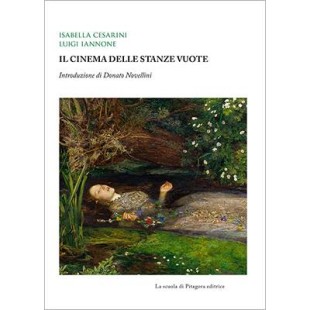Afflato vitale prima di inabissarsi, bagliore lugubre, la malinconia veglia sulle esistenze – per Cioran “la disperazione è un ultimatum che facciamo a Dio” -, passeggia tra le vite e le accarezza, si avvinghia alle pellicole dei registi non conformi dopo averle sfiorate sull’ultima nota del preludio a Tristano e Isotta di Wagner. A questi cineasti eretici è dedicata l’ultima fatica di Isabella Cesarini e Luigi Iannone, “Il cinema delle stanze vuote” (ed La scuola di Pitagora), con prefazione di Donato Novellini. La malinconia è un filo tetro come l’atrabile di Ippocrate – l’umore malinconico – o come le lenti di Pietro Germi che affogano nella nube di una sigaretta mai spenta. Stacco, un attimo prima che sia troppo tardi. Subito dopo, oltre la vita e la consapevolezza, c’è il capolavoro di Malle, Le feu follet, omaggio all’omonimo romanzo di Pierre Drieu La Rochelle, trionfo del disperato grido contro il mondo grigio dell’uggia parigina. Stacco, ormai è troppo tardi. La malinconia pervade anche i colori caldi di Wes Anderson, intrisi d’inquietudine anche se smaliziati, salvati, come ne Il treno per il Darjeeling, unicamente grazie al ritorno al nostro animo dell’infanzia: un po’ Baudelaire un po’ Pascoli, la puerizia è la sola condizione di serenità. Il riso è un refugium possibile contro il male di vivere, il magistrale Gastone Moschin aveva già avvertito tutti in Amici miei. Stacco, fine del primo tempo. Il libro si sposta, poi, sulla maestria di Fellini che, nel dirigere oniriche sfilate circensi danza tra ciò che è reale e ciò che non lo è, sprofonda nella finzione e nel non detto, proprio come nella conflittualità di Nostalghia di Tarkovskij.
Ed eccoci allo stacco più cupo. Tra le pagine piomba Bergman, cantore della malinconia del nord, debitore sincero di Kierkegaard e Heidegger. Il settimo sigillo compie sessant’anni ed è ancora uno squarcio inclemente della nostra vita e della modernità. La Morte – che “è solo un confine” – aspetta il cavaliere Block (accompagnato dal miscredente scudiero Jons) che decide di sfidarla a scacchi, cercando invano – zugzwang sarebbe il termine tedesco, cioè sapere di subire lo scacco matto qualsiasi mossa si faccia – il divino in un percorso, lastricato di incontri, che solo in parte si rivela essere catartico. Lo stesso sacro che il professor Borg scova a fatica nei seppelliti ricordi, quasi primordiali, del suo passato (con lo stesso spaesamento di Block per ciò che verrà) ne Il posto delle fragole. Gli ultimi capitoli sono dedicati ad Into the Wild, deliziosa ribellione e ode al bosco, al puro, di Sean Penn che racconta la storia vera di Alexander Supertrump e del suo viaggio di vita nell’incontaminato e alle sinfonie malinconiche di Lars von Trier, tra lo smarrimento di Nicole Kidman nella città di Dogville e l’ineluttabile mestizia di Justine in Melancholia, ritratto desolato di chi è isolato ma cosciente del proprio destino. Zugzwang, appunto. Tornano le luci in sala e l’Ophelia di Millais in copertina e resta l’irrequietezza di sempre. Isabella Cesarini e Luigi Iannone hanno trovato l’intima connessione tra le manifestazioni dell’inimitabile genio delle cineprese, tolto il velo di Maya e dedicato un primo piano meraviglioso alla malinconia, all’inquietudine, al senso della fede – “Quando l’agnello aprì il settimo sigillo nel cielo si fece un silenzio di circa mezz’ora e vidi i sette angeli che stavano dinnanzi a Dio e furono loro date sette trombe” -, alla ricerca angosciosa di una palingenesi e alle lacerazioni di questa società. Il posto delle fragole è il salvifico giardino che ossessiona von Trier, lo stesso bosco di Supertrump e di Block. Lo stesso Mal de’ fiori di Carmelo Bene, cui è tributato un capitolo essenziale. Tutti, però, si ritrovano nella stessa straziante implorazione: “Che fai tu, Luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna?”. Preludio e titoli di coda, questo silenzio assordante è la malinconia.