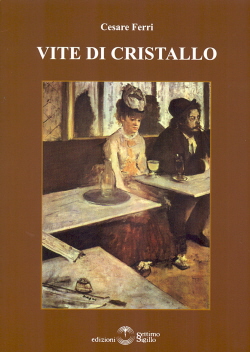 Arriva in libreria “Vite di Cristallo”, il nuovo romanzo di Cesare Ferri, un lavoro duro, complesso e intrigante. Con scrittura limpida l’autore traccia le coordinate di un’anabasi spirituale di un uomo differenziato, Ruggero — il protagonista —, nelle tortuosità oscure di una Milano amara e callida, paradigma della metropoli post moderna e mercantile. In questa “città di quarzo”, prisma in cui si rinfrangono le mille contraddizioni e i linguaggi dell’oggi, il viandante ferriano — fedele al monito jungeriano “vivere la città come un fronte” — cerca“d’attraversare” le linee di un’umanità massificata e ormai “liquida” conservando — o ricercando?— un senso “alto” alla propria vita, una “visione eroica” del mondo. Un’impresa terribile, inattuale in un tempo post-eroico. Forse impossibile.
Arriva in libreria “Vite di Cristallo”, il nuovo romanzo di Cesare Ferri, un lavoro duro, complesso e intrigante. Con scrittura limpida l’autore traccia le coordinate di un’anabasi spirituale di un uomo differenziato, Ruggero — il protagonista —, nelle tortuosità oscure di una Milano amara e callida, paradigma della metropoli post moderna e mercantile. In questa “città di quarzo”, prisma in cui si rinfrangono le mille contraddizioni e i linguaggi dell’oggi, il viandante ferriano — fedele al monito jungeriano “vivere la città come un fronte” — cerca“d’attraversare” le linee di un’umanità massificata e ormai “liquida” conservando — o ricercando?— un senso “alto” alla propria vita, una “visione eroica” del mondo. Un’impresa terribile, inattuale in un tempo post-eroico. Forse impossibile.
Come il Gilles di Drieu o come il Meursault de “Lo Straniero” di Camus, Ruggero è attanagliato dai suoi incubi, da troppi ricordi agrodolci, da tanta rabbia. Uno spettro di fattori contradditori che si annegano e si confondono — ecco ancora Camus — in un’angoscia esistenziale infinita.
Nelle prime pagine di “Vite di cristallo” ogni cosa sembra scorrere inutilmente tra i “non luoghi” di una città plumbea: anonimi caffè, uffici tristi, colazioni senza allegria e camere da letto senza amore; Ruggero si perde e si ritrova tra le braccia di donne sbagliate o inadatte «quelle che sognano d’essere compagne di toreri, poi incontrano un venditore d’aranciate e non distinguono più un grembiule da una muleta», vede sfilacciarsi i rapporti familiari, subisce inizialmente la ripetitività idiota di un lavoro alienante in una compagnia d’assicurazioni.
In questo deserto metropolitano vi è però un’isola di buona energia, un rifugio: è l’improbabile bistrot gestito da un personaggio felliniano, Gibì, e popolato da una strana compagnia di anticonformisti. Lì, in quest’area libera, l’eroe ferriano pensa (spera) d’aver trovato dei ribelli autentici, delle figure lontane da ogni morale borghese, dei personaggi capaci di reagire all’appiattimento con il sorriso, l’intelligenza. Nel piccolo “spazio liberato” di Gibì — figura tragica e coerente — la trasgressione non è mai banale e mai plebea. Ma la realtà è diversa. Il prisma è ingannevole e le immagini si dissolvono e si ricompongono in nuove forme. Talvolta spiacevoli, spesso tristi. Sempre disperate.
In breve tempo, incalzata dalla “normalità” la piccola tribù — la “comunità dell’assenzio”, un omaggio alla scapigliatura milanese e alla Parigi perduta — si scioglie mestamente. I proclami diventano lagne e gli urli di rivolta si spengono. Nel scoprire la vacuità, o più semplicemente i limiti, dei suoi compagni di viaggio, Ruggero — e sono le pagine più intese — (ri)trova nella solitudine, nei suoi libri e nella musica il disincanto necessario per “superarsi” una volta di più. Senza arrendersi. Per Camus (e Ferri) «la speranza equivale alla rassegnazione. E vivere non è rassegnarsi».
Ma “Vite di Cristallo” non è soltanto un libro bello e difficile; il lettore avvertito coglierà sicuramente una profondità rara e una pluralità di piani di lettura. Ferri non vuole essere (e non è) un epigono in salsa meneghina di Bukowski, ma è un autore originale e, soprattutto, un fine intellettuale con frequentazioni inconsuete e deliziosamente inattuali. Oltre a Camus, ritroviamo nel lavoro ferriano tratti del rifiuto cioraniano del mondo — la convinzione che gli uomini possono convivere in società senza distruggerla solo perché non sono all’altezza del loro odio reciproco — ma, soprattutto, scorgiamo la forza terribile del messaggio nietzschiano.
A nostro avviso, il protagonista di “Vite di Cristallo” è una trasposizione letteraria di Zarathustra. Pagina dopo pagina, delusione dopo delusione, donna dopo donna, bottiglia dopo bottiglia, ritroviamo nella ventura di Ruggero sprazzi della poesia della III parte del capolavoro di Nietzsche e, più precisamente, l’eco dei passi “Del passare oltre”. Quando — ed ecco il significato della metropoli ripresa dall’autore — il viandante si ferma davanti “alla porta della grande città”, vi è “la scimmia di Zarathustra” — il discepolo incapace, la farsa del messaggio —, colui che, avendo copiato qualcosa del tono e dei gesti, tenta di arrestare il Maestro. «Abbi compassione dei tuoi piedi. Sputa piuttosto sulla porta della città e torna indietro!» La scimmia si scaglia contro la metropoli. Il suo discorso è l’apoteosi del romantico. Sulla feccia della folla, sulle torme della metropoli, Zarathustra dovrebbe “tornare indietro”. No. L’eterno ritorno non è tornare indietro ma ripetersi oltrepassando, la solitudine non è ascesi, ma preparazione a ripetersi.
Ferri lo sa bene e decide di “passare oltre”. Ruggero abbandona i suoi sodali — le scimmie di Nietzsche — e sceglie un rifugio nella saggezza, nel sapere. Una libreria intitolata con un nome evocativo — l’eremo del folle, chiaro richiamo alle jungheriane “Scogliere di Marmo” — sarà il suo rifugio e la sua trincea da cui osservare le convulsioni pre agoniche di un mondo al tramonto. E prepararsi.
Come Zarathustra, il protagonista del romanzo guarda a lungo la metropoli e tace. Il suo (nostro) problema è conoscerla: vederne il tempo e il destino. Ritornare indietro è l’idea dei nani e delle scimmie.
VITE DI CRISTALLO
Cesare Ferri
ppgg 182 – euro 18,00
Settimo Sigillo, Roma 2012








