
Nella sua lunga e straordinaria vita, preziosamente incastonata tra due comete ed oltre, Ernst Jünger trovò tempo per dedicarsi anche al romanzo, raggiungendo vette assolute col capolavoro Sulle scogliere di marmo, dipoi seguendo una sorta di personale traccia utopico/distopica, escursione visionaria d’ambientazione arcaico-futurista che prese forma compiuta nei vari Heliopolis, Le api di vetro, Eumeswil. A margine di questa concatenazione romanzesca piuttosto uniforme per tematiche e stile, in qualche modo affine alle approfondite indagini su tecnica e nichilismo espresse altrove (semmai filosoficamente già trasposta “oltre la linea”, va da sé tracciata dal Leviatano), trovano asilo due libri apparentemente minori: Un incontro pericoloso, esercizio di stile poliziesco ambientato a Parigi e per l’appunto La fionda (1973), pubblicato per la prima volta in italiano da Edizioni Settecolori, con traduzione di Alessandra Iadicicco. Se il primo può considerarsi un torbido trastullo urbano non privo di spunti d’interesse atmosferici, il secondo coglie maggiormente nel segno: trasponendo alcune suggestioni peculiari dello scrittore tedesco nel passato, retrodatandole agli albori della civiltà delle macchine, ovvero all’epoca della gioventù nei primi anni del XX secolo, può a ragion veduta essere definito un romanzo di formazione.
La storia, ambientata in Bassa Sassonia, narra delle vicende di due giovanissimi compagni di scuola, il timido quanto impacciato Clamor e il determinato, carismatico Teo, i quali assieme al rozzo Buz, dopo le prime diffidenze formano una piccola banda dalla connotazione teppistica. Tutti provenienti da Oldhorst, in campagna, vivono presso un ostello cittadino gli anni della prima formazione; Clamor è orfano, dapprima adottato per senso di colpa dal mugnaio, datore di lavoro di suo padre caduto sotto il peso dei sacchi di farina, quindi, dopo la morte del primo tutore viene preso in cura dal Pastore del villaggio e poi spedito in città a studiare. L’impatto con la nuova realtà, tra disciplina talvolta sadica dei professori e una malsana sessualità adulta aleggiante sottoforma di omertose perversioni, è a dir poco traumatico per l’introverso fanciullo, tant’è che le rievocazioni nostalgiche della precedente vita campestre sono frequenti. Sentendosi escluso, alienato, inetto ed inadeguato a tutto, Clamor per autodifesa sviluppa ulteriormente l’atteggiamento contemplativo al quale è già incline, le sue spiccate doti di osservazione deragliano sovente in elucubrazioni oniriche, mimetismo sociale e strade secondarie diventano rifugio per l’astrazione solitaria; di contro Teo è un capo nato, perfettamente inserito, astuto, ambizioso e sicuro di sé, abile organizzatore di piccoli atti vandalici e furti, a tratti cinico, prenderà Clamor sotto la sua ala protettiva, nominandolo addirittura guardia del corpo. La complicità carbonara – passaggi segreti, un covo esclusivo dove gozzovigliare e complottare, le prove di coraggio e l’imberbe cameratismo – troverà ragion d’essere nel recupero dell’arma necessaria per stare al mondo al pari degli adulti: la fionda, die Zwille, termine carico di ambiguità, simbolico, evocante giochi di doppi significati o possibilità già a partire dalla forma biforcuta, com’è di un sentiero che si divide nel bosco.
Romanzo non propriamente autobiografico (benché l’autore venne effettivamente mandato in collegio ad Hannover, per punizione dopo essersi arruolato nella legione straniera ancora minorenne), La fionda risulta affascinante sia per ciò che di vitalistico mostra che per quello che di mostruoso dissimula; già in Cacce sottili Jünger era sceso scrupolosamente nel microcosmo naturale, da appassionato entomologo e scrutatore di minuzie d’ogni sorta, altresì in grado di non scadere nell’ottuso scientismo del quale solitamente si riempiono la bocca i verbosi divulgatori positivisti, semmai prediligendo la sintesi asciutta, il riconoscimento dei Segni e le arcane corrispondenze tra loro, cosmiche, alchemiche, ultramondane, celesti, abissali o telluriche che siano, le grandi sponde alla speculare piccolezza del creato. Qui, similmente ai romanzi Robert Walser (Jakob von Gunten, soprattutto, dal quale sembra tratto di netto il fragile Clamor de La fionda) – benché con stile e piglio opposti – serpeggia un’inquietudine premoderna d’ascendenza romantica e prima ancora greca (il labirinto fattosi foresta), un topos pagano che regolarmente torna minacciosamente a lambire i dominii del consorzio umano. Il bosco infatti si manifesta celandosi, attira respingendo, ospita occultando, quale meta-spazio ambivalente difende e minaccia: è la zona proibita per il civilizzato decadente infatuato dalle vacue novità dettate dalla stampa, area pericolosa, selvaggia, inospitale e d’altro canto rappresenta la più credibile via di fuga dalla società borghese, un riparo arcaico dai cascami coercitivi della civilizzazione, dalla cattività rieducativa permanente.
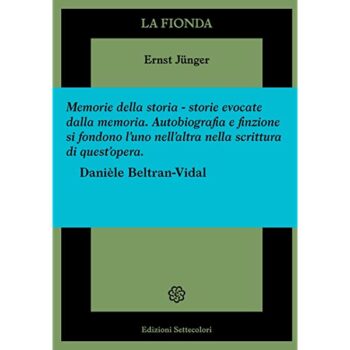 A differenza dello scrittore svizzero, aduso a celare il mostro (Minotauro? Rübezahl? Krampus?) sotto una coltre di amene parole, bucoliche guazze, carinerie assortite ed ingenuità di lumpen, tipi umani senza ambizioni né speranze, Jünger crea una sorta dialettica movimentista e dinamica col Bosco, accettandone la demonica natura, la doppia funzione, ne rinnova l’enigma forgiando un archetipo ancora moderno. Il Forestaro, in Sulle scogliere di marmo, tiranno di un bosco metallurgico, meccanico, sintetizza la forza bruta, oscura, perversa, distruttrice dell’armonico equilibrio monastico resistente all’eremo della Ruta; d’altro canto, proprio il bosco, nemico dell’umanesimo più virtuoso, diventa per contrappasso destinazione elettiva, casa dell’anarca ne Il trattato del ribelle e più addietro funge da riparo o trappola di fuoco per l’arruolato volontario sul fronte della Somme. Nel romanzo La fionda prevale proprio il tratto del Waldgänger, colui che attraversando il bosco si ritrova vergine dall’altre parte, forse nel futuro, più probabilmente nei pressi d’una palude marcia, tra i ruderi di fabbriche abbandonate al collasso del mondo moderno. Irrequieta tensione giovanile meravigliosamente calata in un originario, seppur crepuscolare già in odore di Musil e fine di un’epoca, sfondo di folklore germanico – dal cibo alle rune, dal vestiario agli utensili, flora e fauna, armi, paesaggi, antichi rituali – destinata all’implosione, all’autodistruzione o peggio alla farsa rievocativa: “Chi vuole guarire fino in fondo, guarisce fino a morire”. A quasi ottant’anni, Ernst Jünger rilascia un romanzo psicologicamente profondo, leggibile su più piani, eppure ancora vivacemente conflittuale, ma consapevole che non è più tempo di guerreggiare per qualche perduto onore, lo fa interpretare a dei ragazzini che un poco gli somigliano, ai quali si perdona tutto, anche la vetrata di ricchi palazzi, infranta dal tiro di una fionda.
A differenza dello scrittore svizzero, aduso a celare il mostro (Minotauro? Rübezahl? Krampus?) sotto una coltre di amene parole, bucoliche guazze, carinerie assortite ed ingenuità di lumpen, tipi umani senza ambizioni né speranze, Jünger crea una sorta dialettica movimentista e dinamica col Bosco, accettandone la demonica natura, la doppia funzione, ne rinnova l’enigma forgiando un archetipo ancora moderno. Il Forestaro, in Sulle scogliere di marmo, tiranno di un bosco metallurgico, meccanico, sintetizza la forza bruta, oscura, perversa, distruttrice dell’armonico equilibrio monastico resistente all’eremo della Ruta; d’altro canto, proprio il bosco, nemico dell’umanesimo più virtuoso, diventa per contrappasso destinazione elettiva, casa dell’anarca ne Il trattato del ribelle e più addietro funge da riparo o trappola di fuoco per l’arruolato volontario sul fronte della Somme. Nel romanzo La fionda prevale proprio il tratto del Waldgänger, colui che attraversando il bosco si ritrova vergine dall’altre parte, forse nel futuro, più probabilmente nei pressi d’una palude marcia, tra i ruderi di fabbriche abbandonate al collasso del mondo moderno. Irrequieta tensione giovanile meravigliosamente calata in un originario, seppur crepuscolare già in odore di Musil e fine di un’epoca, sfondo di folklore germanico – dal cibo alle rune, dal vestiario agli utensili, flora e fauna, armi, paesaggi, antichi rituali – destinata all’implosione, all’autodistruzione o peggio alla farsa rievocativa: “Chi vuole guarire fino in fondo, guarisce fino a morire”. A quasi ottant’anni, Ernst Jünger rilascia un romanzo psicologicamente profondo, leggibile su più piani, eppure ancora vivacemente conflittuale, ma consapevole che non è più tempo di guerreggiare per qualche perduto onore, lo fa interpretare a dei ragazzini che un poco gli somigliano, ai quali si perdona tutto, anche la vetrata di ricchi palazzi, infranta dal tiro di una fionda.








