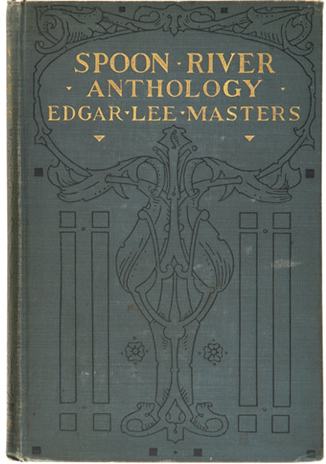
Gli anni ’60 furono per me il passaggio dalla fanciullezza delle scuole elementari e medie, all’adolescenza, quindi alla gioventù in Facoltà. Come per tutti quelli della mia età, ovviamente.
Era un periodo particolare, molto diverso da quello vissuto dalle generazioni precedenti e non solo perchè, per la prima volta da un secolo, l’Italia non era coinvolta in guerre. Perchè gli anni ’60 non solo ci portarono Beatles, Carnaby Street, minigonna. Ma perchè, anche prima del Sessantotto, c’era nell’aria un qualcosa di nuovo, che non proveniva dalla nebbiosa Albione, ma dalla solare California. Noi eravamo una provincia, più o meno mal amministrata dalla DC e dalla Chiesa di Roma; dagli Stati Uniti ci raccontavano, la televisione ed il cinema mostravano, manifestazioni per i diritti civili, l’opposizione alla guerra del Vietnam, l’apogeo del rock e del sesso libero, consentito dalla pillola, gli hippies libertari e pacifisti: quei ‘figli dei fiori’ cultori della non-violenza, finta innocenza idealista mescolata con l’uso di marihuana, cocaina, LSD e droghe pesanti. Nel 1967 ha luogo a San Francisco la Summer of Love, un festival musicale ed una concentrazione di centinaia di migliaia di persone che celebrano la nascita della nuova controcultura. In quell’estate, e fuori dai campus, il movimento hippie appariva travolgente. Nell’estate del 1969 si svolge il Festival de Woodstock, con oltre un milione di partecipanti. La musica rock servì da veicolo per la creazione di tale controcultura, che da San Francisco e dalla California si diffuse negli States. Miscelata con le canzoni di protesta, la musica rock si converte in attivismo politico, ribellione giovanile contro conformismo e consumismo, contro il razzismo. Easy Rider, film drammatico del sottogenere road movie, del 1969, diretto da Dennis Hopper ed interpretato dal medesimo con Peter Fonda e Jack Nicholson quali attori principali, diventa un emblema di ricerca di libertà e trasgressione, simbolizzata dalla moto chopper ‘Captain America’ e dalle strade quasi infinite, già raccontate, un decennio prima, da Jack Kerouac in On the Road, il romanzo-manifesto della Generazione Beat, erede, a sua volta, della sottocultura Hipster: giovani che alla fine della guerra, negli anni ’40, adottano uno stile di vita bohémien, lontano dalle mode dell’American Dream, confusi progressisti di sinistra, amanti della musica jazz ed afroamericana. Che è anche quella dei Teddy Boys inglesi, di James Dean e della ‘Gioventù bruciata’, del ‘Ribelle senza una causa’, un problematico rivoltoso adolescente, nei film e nella propria vita, che nel settembre 1955, a 24 anni, trova la morte al volante della sua Porsche: una icona pop di fascino duraturo, una contestazione del sistema approssimativa, ancora acerba.
Il mito della Beat Generation è portato in Italia, oltre che dal cinema, soprattutto dai libri di Kerouac, Ginsberg, Burroughs, Bukowski ed altri. L’America di “Nanda”, come veniva soprannominata dagli amici scrittori, Fernanda Pivano (Genova, 1917-Milano, 2009), traduttrice, scrittrice, giornalista, critica musicale. Una figura chiave per la diffusione della letteratura americana in Italia. Grazie a lei il pubblico italiano ha potuto conoscere molti autori statunitensi: da Ernest Hemingway a Jack Kerouac, da Allen Ginsberg a Charles Bukowski, a Edgar Rice Burroughs. Un sentimento che andò oltre le pagine tradotte, portandola a conoscere di persona gli scrittori più importanti del tempo, affascinandola e deludendola, a volte.
La bio della Pivano

‘Fernanda Pivano nacque a Genova il 18 luglio 1917 in una benestante famiglia alto-borghese, che ella stessa soleva definire vittoriana, secondogenita dei due figli di Riccardo Newton Pivano (1881-1963), direttore dell’Istituto di Credito Marittimo, di origini in parte scozzesi, e di Mary Smallwood (1891-1978), figlia a sua volta di Elisa Boggia e dell’inglese Francis Smallwood, uno dei fondatori della Berlitz School italiana. La Pivano aveva un fratello maggiore, Franco (1911-1956). La sua formazione avviene a Torino, dove si era trasferita con la famiglia nel 1929. Frequenta il R. Liceo classico Massimo d’Azeglio, dove ha come compagno di classe in quarta e quinta ginnasio Primo Levi e, come supplente di italiano, Cesare Pavese. Nel 1938 Pavese le porta quattro libri in inglese che segnarono il suo destino di scrittrice e traduttrice, facendola appassionare alla letteratura statunitense: Addio alle armi di Ernest Hemingway, Foglie d’erba di Walt Whitman, Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters e l’autobiografia di Sherwood Anderson. Nel 1940 consegue il diploma in pianoforte al Conservatorio di Torino. Nel 1941 si laurea in lettere, con una tesi su Moby Dick di Herman Melville. Nel 1943 si laurea in filosofia con Nicola Abbagnano, con una tesi dal titolo Il valore della simpatia nell’educazione. L’inizio della sua carriera letteraria risale al marzo 1943, quando è pubblicata da Giulio Einaudi, a Torino, la prima traduzione della Antologia di Spoon River, con la supervisione di Cesare Pavese’.
(https://it.wikipedia.org/wiki/Fernanda_Pivano)
Il primo lavoro di cui si occupa è, dunque, la traduzione dell’Antologia di Spoon River, scritta dal poeta nordamericano Edgar Lee Masters (Garnett, Kansas, 23 agosto 1868 – Melrose Park, 5 marzo 1950), poeta, biografo e drammaturgo, influenzato dal clima letterario del naturalismo di Zola e Maupassant. Libero pensatore, libertino, agnostico, vicino all’anarchismo. Un uomo della ‘controgenerazione del ’98 (nemico dell’imperialismo preconizzato da Theodore Roosevelt, Henry Cabot Lodge, dal Presidente McKinley, un Manifest Destiny planetario), antimilitarista, affatto nostalgico, critico dell’opzione geopolitica talassocratica adottata, dell’ipocrisia arrogante del ‘sogno americano’. Figlio di un avvocato politico per diletto, per alcuni anni sindaco democratico di Lewistown (fonte d’ispirazione di Spoon River), ed egli stesso odiatore di Lincoln, il vero autore di quel ‘Sistema americano’, imposto con la Guerra Civile, che necessitava di una unione federale, non confederale degli USA. Il libro, pubblicato dal noto editore MacMillan di New York, vendette 19 edizioni nel 1915 e nel 1940 già erano 70; moltissime le traduzioni. Qualcosa di inaudito per un libro di poesia, oggi considerato un classico della poesia anglosassone. Per qualcuno, addirittura, Masters è ‘il padre della letteratura moderna’; il libro lo standardo di una rivoluzione spirituale ‘contro il villaggio’ e ‘contro la mentalità puritana’. “At last. At last America has discovered a poet”, proclama Ezra Pound. Masters personifica altresì il movimento letterario conosciuto come «Rinascimento di Chicago».
Spoon River Anthology è la storia di una piccola città americana con le sue mille vite, ognuna delle quali chiusa nel suo dramma – che potrebbe essere replicata altrove – e, infatti, un’analisi squisitamente “politica” dell’Antologia risulterebbe sterile, inappropriata. È l’assoluta focalizzazione sullo spettro delle umane sensazioni ad offrire peculiarità alla raccolta, sono le storie d’amore, di guerra, di gelosia, la grettezza, il fallimento dell’idealismo, la rovina delle virtù degli antichi pionieri, spazzate via dalla civiltà del denaro, l’immoralità del sistema giudiziario, la stupidità e l’avidità. C’è qualche spazio per la fede nella vita, il coraggio, persino per l’esaltazione mistica. Le poesie parlano del regno dei morti, regno in cui la giustizia viene rivendicata. I morti raccontano in maniera quasi ossessiva alcuni dettagli delle loro vite; sono come inchiodati in un attimo decisivo della loro esistenza e portano con sé un un’immagine o un’emozione della loro vita terrena, descritta con le poche parole degli epitaffi delle loro tombe.
“Spoon River Anthology è una collezione di poesie pubblicata tra il 1914 e il 1915 sul Reedy’s Mirror di Saint Louis, Missouri, una rivista letteraria, per la quale l’autore utilizzò lo pseudonimo di Webster Ford. Ogni poesia racconta, in forma di epitaffio, la vita dei residenti dell’immaginario paesino di Spoon River – il cui nome deriva da quello di un omonimo fiume realmente esistente – che scorre vicino a Lewistown, città di residenza dell’autore – sepolti nel cimitero locale. Lo scopo di Masters è quello di demistificare la realtà di una piccola cittadina rurale americana, con rimandi incrociati che permettono di allargare lo sguardo sull’intera comunità. La raccolta include 212 diversi personaggi, per ognuno dei quali si forniscono informazioni sulle vite, sulle loro sconfitte, la ragione della morte. La prima edizione della raccolta pubblicata nell’aprile del 1915 contava 213 epigrafi, diventati poi 243 più La Collina nella versione definitiva del 1916. La raccolta comprende diciannove storie che coinvolgono un totale di 248 personaggi che coprono praticamente tutte le categorie ed i mestieri umani. Masters si proponeva di descrivere la vita umana raccontando le vicende del villaggio di Spoon River. Egli s’ ispirò a personaggi veramente esistiti a Lewistown e Petersburg, Illinois. L’autore, un avvocato di idee libertarie, pacifiste, si richiama, per la
struttura dell’opera, all’Antologia Palatina” (https://it.wikipedia.org/wiki/Antologia_di_Spoon_River).
Si tratta di una celebre raccolta di epigrammi attribuiti ad una cinquantina di poeti greci, compilata a Bisanzio nel X secolo, una copia arricchita della perduta antologia epigrammatica di Costantino Cefala. La Palatina consta di circa 3700 epigrammi (per ben 23.000 versi), suddivisi in 15 capitoli. Fu rinvenuta dall’umanista Claudio Salmasio nel 1607 nella Biblioteca di Heidelberg. William Marion Reedy, direttore del Reedy’s Mirror di Saint Louis gli prestò il testo.
Masters s’ispirò pure all’Elegia scritta in un cimitero campestre di Thomas Gray. Oltre che alla Comédie humaine di Balzac, in termini generali. L’idea, dirà, scaturì nel 1906, per un testo originalmente pensato in prosa, nel quale egli ‘dipingerebbe il macrocosmo descrivendo il microcosmo’. Nella Genesi di «Spoon River» racconterà i segreti della sua opera più celebre, grande e commovente enciclopedia poetica delle emozioni umane. ‘Mentre scrivevo l’Antologia’, affermerà, ‘ero ossessionato dai nomi e dalle storie: avevo sturato una bottiglia piena di anime. Vedevo la pietà e la dolcezza, i sarcasmi e le passioni, la splendente miseria che trabocca da noi fino alla fine. Purtroppo, l’opera mi procurò l’inimicizia di alcuni vivi, che videro svelati certi loro segretucci nei ritrattini caustici di alcuni morti. Si sa, i morti possono svelare tutto. I vivi, non ancora. I vivi hanno segreti e pudicizia. I morti sono privi di vergogna. Sono nudi e sinceri. Forse sono tornati innocenti’. L’Antologia è il cimitero immaginario di un paese immaginario (ma non troppo) dell’ Illinois, dove l’autore traccia, con linguaggio semplice, usando pure lo slang, talora non esente da volgarità, una radiografia cruda dell’America del Midwest, attaccando il suo provincialismo formalista e bigotto, la ristrettezza degli orizzonti, l’etica puritana; storie di uomini e donne rievocati dalle loro lapidi del cimitero tra virtù e bassezze, meschinità, infelicità dei giusti ed impunità del potere, sullo sfondo di un desolante, denso pessimismo.
Nella prefazione ad una delle edizioni dell’opera, Fernanda Pivano scriverà che:
“L’autore definiva questo libro ‘qualcosa di meno della poesia e di più della prosa’. Il tono degli epitaffi è narrativo, mai declamatorio, la struttura dei versi netta e scarna, la voce dei protagonisti sfumata, priva di un vero rimpianto per il passato. Durante il ventennio fascista la letteratura americana era piuttosto osteggiata dal regime. La prima edizione italiana porta la data del 9 marzo 1943. La traduzione fu a cura della Pivano che raccontò: «Ero una ragazza quando ho letto per la prima volta Spoon River: me l’aveva portata Cesare Pavese, una mattina che gli avevo chiesto che differenza c’è tra la letteratura americana e quella inglese». L’Antologia di Spoon River fu come un colpo di fulmine: «L’aprii proprio alla metà, e trovai una poesia che finiva così: ‘mentre la baciavo con l’anima sulle labbra, l’anima d’improvviso mi fuggì’. Chissà perché questi versi mi mozzarono il fiato: è così difficile spiegare le reazioni degli adolescenti». La Pivano iniziò a tradurre in italiano le poesie, pare senza dirlo a Pavese. Un giorno quest’ultimo scoprì in un cassetto il manoscritto e convinse l’editore Einaudi a pubblicarlo. L’iniziale ritiro del libro da parte delle autorità fu motivato dalla immoralità della copertina: copertina che fu cambiata in fretta ed il testo poté di nuovo circolare”. (https://it.wikipedia.org/wiki/Antologia_di_Spoon_River)

Sarà proprio Fernanda Pivano ad aiutare Fabrizio De André (Genova, 1940 – Milano, 1999) nella rivisitazione in canzoni di epitaffi di Spoon River. Questa collaborazione porterà, nel 1971, alla pubblicazione dell’album Non al denaro, non all’amore, né al cielo. Al cantautore genovese affascinava specialmente la figura del vecchio violinista Jones: «se la gente scopre que sai suonare il violino/ ebbene, tutta la tua vita dovrai strimpellare il violino». Con il quale egli s’identificava.
De André, che, esagerando, la Pivano considerava ‘il più grande poeta italiano vivente’, non rientrava nelle mie preferenze o passioni giovanili. Neppure quelle sue canzoni di emarginati, ribelli e prostitute, quel profluvio di facili idee anarchiche, pacifiste, antiborghesi, anticlericali. Che aveva debuttato nel 1963 con ‘Il fannullone’, figura di moderno antieroe, una sorta di poeta o cantastorie fra l’artista bohémien ed il clochard. Un canto alla libertà, ironico e struggente, il ripudio di un’esistenza borghese, l’ assunzione di responsabilità, il rifiuto di adattarsi ad una vita monotona e ripetitiva, contro la voce pedante e conformista del buon senso comune, la quale fa da contrappunto a quella, svagata e svogliata, del protagonista. Una storia con indubbi tratti autobiografici, accentuati, esasperati per desiderio di provocazione: la predilezione per la vita notturna, per il ‘cantar storie’.
Le musiche e gli arrangiamenti del 33 giri del 1971, Non al denaro, non all’amore, né al cielo, furono composte da De André con Nicola Piovani. L’idea del disco la ebbe il produttore discografico Sergio Bardotti. È un libero adattamento (eseguito insieme a Giuseppe Bentivoglio) di alcune poesie della Antologia di Spoon River, nove canzoni: La collina, Un matto (dietro ogni scemo c’è un villaggio), Un giudice, Un blasfemo (dietro ogni blasfemo c’è un giardino incantato), Un malato di cuore, Un medico, Un chimico, Un ottico, Il suonatore Jones.
Eppure quel “cantautore degli emarginati”, “poeta degli sconfitti”, aedo di uomini liberi che “cantano la libertà e l’amore libero” (anche se poeta vero io non credo lo fosse, ma egli sapeva utilizzare al meglio materiali altrui) poteva, entro certi limiti, piacere pure a un giovane/vecchio arnese di destra come lo scrivente. E, infatti, grazie a De André, scoprii come molti altri del resto, credo, l’Antologia di Spoon River. La lessi nella traduzione della Pivano, ovviamente. Testo che fu di grande ispirazione pure per Francesco Guccini. E nel 2018 il poeta Simone Consorti intitolò Spoon River Italia, dando voce a trapassati italiani degli ultimi anni, l’ultimo capitolo della sua raccolta Le ore del terrore (Forlì, L’Arcolaio).
Il successo del disco di De André determinò un effetto collaterale ed aumentarono le vendite del libro, che da parecchi anni era in fase stagnante. Un’operazione di marketing efficace, seppur involontaria… L’Italia tormentata e vitale degli anni ’70 scopriva i limiti del consumismo trionfante, si rispecchiava nel crudo, laconico, sarcastico realismo di Masters, a volte ironico, a volte commovente, nella sua denuncia dell’ipocrisia di politici, giudici, prelati; la disuguaglianza sociale stridente, lo sfruttamento di donne indifese, il dolore, la corruzione, l’opportunismo dei potenti. Messaggi eterni dell’essere umano che è ferito da un altro essere per prepotenza, ottusità, avidità, gelosia, vigliaccheria, debolezza… (seguirà una seconda puntata)








