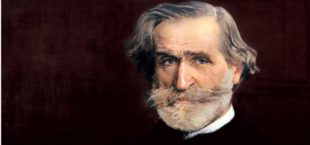 Per lungo tempo si è sottovalutata l’arte di Verdi in lingua francese. Eppure essa è durata dal 1847 al 1894, quando l’edizione dell’Otello per l’Opéra di Parigi lo portò a scrivere la sua ultima pagina sinfonica, i modernissimi Balletti esotici. Nel 1847 il Maestro aveva trentaquattro anni ed era già l’operista europeo più ricercato. Il Nabucco, I Lombardi alla prima Crociata, e soprattutto l’Ernani, derivante da un dramma di Victor Hugo, gli avevano aperto una grande strada. Era lo stesso tempo (dal 1843) che Wagner, non ancora immaginando di aver di fronte il più temibile rivale, occupava il posto di direttore dell’orchestra del regno di Sassonia a Dresda e vi componeva. Il tipo di Opera che si era internazionalmente affermato era il Grand-Opéra. Creazione parigina, ma di paternità soprattutto italiana. Le intuizioni di Salieri e Cherubini erano state raccolte dal marchigiano Spontini, che fu anche cultore a Berlino di Bach e Beethoven, dopo esserlo stato a Parigi di Mozart. Il primo vero Grand-Opéra della storia è suo, il Fernand Cortez, del 1809. Ma l’esaltazione di Napoleone civilizzatore si scontrò con le avverse fortune spagnole dell’Imperatore. La monumentale Opera esotica ebbe una seconda e miglior versione sotto Luigi XVIII nel 1817. Spontini vi fece seguire l’Olimpie, del 1819, pur essa esistente in varie revisioni (la pristina partitura è perduta) e il primo Grand-Opéra in lingua tedesca, l’Agnes von Hohenstaufen, che influenza lo stesso Wagner. A Parigi s’era insediato intanto Rossini, del quale i tre Grands-Opéras sono monumenti della musica, in ispecie il terzo, il Guillaume Tell (1829), un gigantesco Poema Sinfonico sulla Natura.
Per lungo tempo si è sottovalutata l’arte di Verdi in lingua francese. Eppure essa è durata dal 1847 al 1894, quando l’edizione dell’Otello per l’Opéra di Parigi lo portò a scrivere la sua ultima pagina sinfonica, i modernissimi Balletti esotici. Nel 1847 il Maestro aveva trentaquattro anni ed era già l’operista europeo più ricercato. Il Nabucco, I Lombardi alla prima Crociata, e soprattutto l’Ernani, derivante da un dramma di Victor Hugo, gli avevano aperto una grande strada. Era lo stesso tempo (dal 1843) che Wagner, non ancora immaginando di aver di fronte il più temibile rivale, occupava il posto di direttore dell’orchestra del regno di Sassonia a Dresda e vi componeva. Il tipo di Opera che si era internazionalmente affermato era il Grand-Opéra. Creazione parigina, ma di paternità soprattutto italiana. Le intuizioni di Salieri e Cherubini erano state raccolte dal marchigiano Spontini, che fu anche cultore a Berlino di Bach e Beethoven, dopo esserlo stato a Parigi di Mozart. Il primo vero Grand-Opéra della storia è suo, il Fernand Cortez, del 1809. Ma l’esaltazione di Napoleone civilizzatore si scontrò con le avverse fortune spagnole dell’Imperatore. La monumentale Opera esotica ebbe una seconda e miglior versione sotto Luigi XVIII nel 1817. Spontini vi fece seguire l’Olimpie, del 1819, pur essa esistente in varie revisioni (la pristina partitura è perduta) e il primo Grand-Opéra in lingua tedesca, l’Agnes von Hohenstaufen, che influenza lo stesso Wagner. A Parigi s’era insediato intanto Rossini, del quale i tre Grands-Opéras sono monumenti della musica, in ispecie il terzo, il Guillaume Tell (1829), un gigantesco Poema Sinfonico sulla Natura.
Ma Rossini a trentasei anni rinunciò a scrivere per il teatro. Se pensiamo che visse fino al 1868, sarebbe stato il più imbattibile concorrente. Verdi dovette farsela invece con un’altra generazione, Auber, Meyerbeer, Halévy e Donizetti, che in lingua gallica ha lasciato alcuni dei suoi capolavori. Gli altri tre sono considerati dai francesi gl’inventori del Grand-Opéra: ognuno si costruisce la storia a modo suo. Meyerbeer mescola tratti di genio a pedanteria scolastica o a pezzi di effetto facile; è quello ch’ebbe più successo. Ma Verdi è un’altra cosa. Prende la ricetta e se ne impossessa, poi la rivolta come un guanto. Sostituisce sia nella psicologia dei personaggi che nello stile al tipico e generico l’irrepetibile.
Nel 1847 riscrisse per l’Opéra I Lombardi alla prima Crociata. Ne nacque la Jérusalem, che per generazioni una miriade di cretini ha osato chiamare, testualmente, una minestra riscaldata. Senza considerare le meravigliose parti nuove, non si rendono conto che il mutato contesto trasforma le parti preesistenti; e talora basta al Maestro modificare un’armonia per cambiar di senso al tratto. Giuseppina, non ancor sua moglie, si era già trasferita a Parigi per aprirvi una scuola di canto. Conosceva il francese assai meglio di Giuseppe, che poi lo apprese benissimo: lo aiutò nella prosodia; in un tratto del manoscritto, un Duetto d’amore, le due grafie procedono intrecciate. La Jérusalem trasformò il loro amore nel vincolo indissolubile che sappiamo.
Nel 1855, a onta di un Libretto che Scribe aveva riutilizzato mutando epoca e luogo, Verdi crea uno dei suoi titoli più belli. Les Vêpres siciliennes si basano su di una leggenda storica, ma la sbalzatura dei caratteri è miracolosa; credo che sia uno dei più begli inni innalzati dalla musica all’amor paterno, corda alla quale il Maestro è sensibile più di qualunque altro compositore. Siamo già nel Secondo Impero. Ma Verdi non sopportava l’Opéra, con la sua pesantezza burocratica, il suo vetusto regolamento, i direttori d’orchestra scadenti che non poteva sostituire neanche con se stesso. Onde si tenne alla larga dal teatro, in un ambiente che sentiva anche ostile. Diede ancora una versione del Trovatore, con minime varianti ma con l’aggiunta di strepitosi Balletti. Poi giunse a quella che sarebbe stata la più gran de disperazione della sua vita.
Torna come fonte a Schiller, il grande poeta che riscriveva la storia a suo talento, come mostra la Giovanna d’Arco, musicata dal Maestro nel 1845. Questa volta ricorre alla Tragedia Don Carlos. L’Infante di Spagna, figlio di Filippo II, era in realtà gobbo e pazzo. Morì nelle carceri dell’Inquisizione, ove il padre l’aveva ristretto. Ma il Re era, già nella storia, uno psicopatico, e Verdi ne dà un ritratto che fa venire i brividi. Lo mostra soggetto al Grande Inquisitore, così come fa dell’Infante un puro eroe, affetto da una passione platonica per la sposa del padre, Elisabetta di Valois, e legato da un rapporto erotico col suo miglior amico. Il Maestro s’impegnò allo spasimo nella creazione. Il Don Carlos, insieme col Guillaume Tell di Rossini e con l’Aida (ancorché questa sia in italiano) e col Tannhäuser di Wagner è il più bel Grand-Opéra della storia. Verdi non potette mai ascoltarlo intero. Lo tagliarono alla prima rappresentazione. Lo tagliarono dovunque. Per la disperazione l’Autore eliminò l’intero primo atto, in una versione italiana. Poi lo ripristinò con tagli, vent’anni dopo la “prima”, sempre in italiano. Ma la Tragedia, che subì altre mutazioni, alcune meravigliosamente meliorative, va ascoltata in francese, per un melos particolare che i grandi Maestri italiani creano congiunto alla lingua. Le parti perdute vennero ritrovate solo nel 1973. La prima edizione completa, del 1866, comprese le parti eseguite solo alle prove, venne incisa. La versione con le parti perdute, ma con la mescolanza delle sostituzioni meliorative, venne eseguita a Bruxelles nel 1974 da Elio Boncompagni. Ma per lo più si continua a rappresentare il capolavoro in quattro atti: è sì d’Autore ma, ripeto, nasce dalla disperazione di tale Autore che vedeva dilacerata la sua creazione, ed è priva delle indispensabili premesse psicologiche e drammatiche, oltre a essere in traduzione. Non so se, incisione a parte, la partitura completa del 1866 sia stata mai allestita in scena. Lo ha fatto ora quello che considero il miglior soprintendente, italiano ma da anni a Liegi, ove dirige l’Opéra Royal de Wallonie. Stefano Mazzonis di Pralafera è autore anche della geniale regia, mentre sul podio un nostro direttore in costante crescita, il mantovano Paolo Arrivabeni, coglie nel timbro tutta la terribilità e, lo dico ancora una volta, la disperazione di un testo del più grande pessimismo storico che fu anche il dolore del suo Autore. Non un torso michelangiolesco, ma il Michelangelo scultore più cupo può essere accostato al capolavoro di un genio che non gli è inferiore.
Non sono convinto che l’edizione del 1866 sia la migliore in assoluto. Proprio come Wagner col Tannhäuser, Verdi non ha lasciato una versione definitiva del Don Carlos. Personalmente, ma questo oggi è affatto impopolare, io procederei a una cernita del meglio di pagine che si trovano riscritte anche più di tre volte, arrivando a un’edizione non “autentica” ma ideale. Però la prima creazione va conosciuta perché risponde alla prima volontà dell’Autore, e dobbiamo ringraziare Liegi e Mazzonis per aver dato un tale omaggio alla cultura musicale. In Italia il primo Don Carlos non lo ascolteremo mai, ne sono certo; e anche in altri paesi. Mancano le premesse di volontà e di preparazione intellettuale.
*Da Il Fatto Quotidiano del 2.2.2020








