 Herbert von Karajan era nato nel 1908: a Salisburgo, città inscritta nel suo destino. Il Festival, fondato da Richard Strauss e Hugo von Hofmannsthal, venne da lui ripreso in mano dopo la tragedia della guerra, e dopo che, alla morte di Furtwängler, egli divenne anche il direttore a vita dei Filarmonici di Berlino. C’era stata un’imbarazzante vicenda, negli anni seguiti al 1945. Furtwängler era stato “denazificato”. Dopo la sua morte la vedova è andata piagnucolando in giro per il mondo: asseriva che il defunto era antinazista e che restava al suo posto per proteggere i musicisti ebrei. Tanto era antinazista da dirigere ogni anno, il 20 aprile, compleanno del Führer, la Nona Sinfonia di Beethoven in suo onore, con tutto lo stato maggiore del Partito schierato ad applaudirgli. Karajan al Partito s’era iscritto nel 1935. Non ha cercato giustificazioni, non si è ricostruito postume verginità. Forse la pensava come la maggioranza dei tedeschi. Ma vorrei aggiungere che l’iscrizione, come il matrimonio, erano una necessità difensiva per un omosessuale. Non voglio dire ch’egli lo fosse esclusivamente. Ebbe anche una vita eterosessuale, con un terzo matrimonio e la nascita di due figlie, che desiderava ardentemente.
Herbert von Karajan era nato nel 1908: a Salisburgo, città inscritta nel suo destino. Il Festival, fondato da Richard Strauss e Hugo von Hofmannsthal, venne da lui ripreso in mano dopo la tragedia della guerra, e dopo che, alla morte di Furtwängler, egli divenne anche il direttore a vita dei Filarmonici di Berlino. C’era stata un’imbarazzante vicenda, negli anni seguiti al 1945. Furtwängler era stato “denazificato”. Dopo la sua morte la vedova è andata piagnucolando in giro per il mondo: asseriva che il defunto era antinazista e che restava al suo posto per proteggere i musicisti ebrei. Tanto era antinazista da dirigere ogni anno, il 20 aprile, compleanno del Führer, la Nona Sinfonia di Beethoven in suo onore, con tutto lo stato maggiore del Partito schierato ad applaudirgli. Karajan al Partito s’era iscritto nel 1935. Non ha cercato giustificazioni, non si è ricostruito postume verginità. Forse la pensava come la maggioranza dei tedeschi. Ma vorrei aggiungere che l’iscrizione, come il matrimonio, erano una necessità difensiva per un omosessuale. Non voglio dire ch’egli lo fosse esclusivamente. Ebbe anche una vita eterosessuale, con un terzo matrimonio e la nascita di due figlie, che desiderava ardentemente.
Finché il Festival lo resse lui, fu la più prestigiosa manifestazione artistica mondiale. Egli vi aggiunse le appendici raffinatissime del Festival di Pasqua e di quello di Pentecoste. Sui quali conviene soffermarsi anche per toccare uno dei più diffusi luoghi comuni sul Maestro. Si dice ch’egli vivesse solo per l’industria discografica, che fosse un industriale e basta. In genere si realizzava un disco dopo esecuzioni di successo. Mai si è visto il caso di un direttore che prima incide un’Opera, poi incomincia ad eseguirla dal vivo, perfezionando l’incisione grazie anche al contatto col pubblico. Mai prima di Karajan, mai dopo. Posso aggiungere che dopo la sua morte il Festival mi parve svuotato di significato. Ci sono tornato sempre più malvolentieri; ora che sono libero dai vincoli della critica musicale, non metterò più piede in quella città piovosa e torrida, dove fanno di tutto per dimenticarlo. Uno dei suoi principî era che il teatro musicale dovesse essere fedele alla didascalia d’autore. Divenne regista anche per questo; certe sue regie sono memorabili, come quella della Salome di Strauss. Si liberò persino di Strehler – ed ebbe ragione – dopo le superfetazioni che il grande regista aveva fatte al Flauto magico di Mozart. L’unico suo collega che condivide il principio è James Levine, e si sa come l’hanno ringraziato al Metropolitan.
Morì nella sua casa di Anif, presso Salisburgo, la mattina del 16 luglio 1989. Quel giorno avrebbe dovuto dirigere la prova generale di Un ballo in maschera, lo spettacolo inaugurale del Festival. Il Festival s’inaugurò regolarmente, e l’Opera di Verdi venne diretta da Georg Solti: the show must go on. Trovai sorprendente e scandaloso che la recita non venisse dedicata alla sua memoria. Poi, a Salisburgo, il Maestro è stato commemorato nel modo più degno da Riccardo Muti, che non ha dimenticato il suo debito di gratitudine verso chi, solo per averne ascoltato alcune esecuzioni, lo aveva invitato telefonandogli direttamente, senza conoscerlo. Muti diresse in memoria di Karajan una splendida Messa da Requiem di Verdi e un ancor più splendido Requiem tedesco di Brahms.
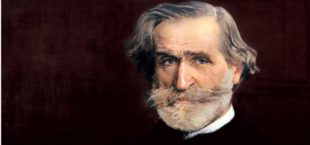 Quando si nomina Karajan, uno dei più grandi direttori d’orchestra di tutti i tempi, una sorta di riflesso condizionato porta ad associarlo a Beethoven, a Wagner, a Brahms, a Strauss; e a Bach, a Mozart, a Haydn. L’interprete verdiano e pucciniano è di primissima grandezza. La Messa da Requiem e l’Aida da lui dirette non hanno trovato mai un paragone possibile. Vi è una lontana Traviata della Scala, del 1964, la più struggente di tutte. Un Trovatore di Vienna. Meno bene ha fatto egli il Don Carlos: in quattro atti (ch’è una versione facilitata rispetto a quella autentica in cinque, scaturita dalla disperazione di Verdi che vedeva il suo capolavoro massacrato dai tagli), e con troppi tagli, ancora. E il Falstaff: dove allo splendore sinfonico egli unisce un’acquiescenza verso gli arbitrî di Tito Gobbi che ha una sola spiegazione: il disprezzo dei tedeschi verso la cultura italiana. Se avessero toccato una croma del Fidelio o del Crepuscolo degli dei avrebbe fatto l’inferno. In Verdi, che pure egli ha capito più di ogni altro connazionale, indulgenza.
Quando si nomina Karajan, uno dei più grandi direttori d’orchestra di tutti i tempi, una sorta di riflesso condizionato porta ad associarlo a Beethoven, a Wagner, a Brahms, a Strauss; e a Bach, a Mozart, a Haydn. L’interprete verdiano e pucciniano è di primissima grandezza. La Messa da Requiem e l’Aida da lui dirette non hanno trovato mai un paragone possibile. Vi è una lontana Traviata della Scala, del 1964, la più struggente di tutte. Un Trovatore di Vienna. Meno bene ha fatto egli il Don Carlos: in quattro atti (ch’è una versione facilitata rispetto a quella autentica in cinque, scaturita dalla disperazione di Verdi che vedeva il suo capolavoro massacrato dai tagli), e con troppi tagli, ancora. E il Falstaff: dove allo splendore sinfonico egli unisce un’acquiescenza verso gli arbitrî di Tito Gobbi che ha una sola spiegazione: il disprezzo dei tedeschi verso la cultura italiana. Se avessero toccato una croma del Fidelio o del Crepuscolo degli dei avrebbe fatto l’inferno. In Verdi, che pure egli ha capito più di ogni altro connazionale, indulgenza.
Ho detto “uno dei più grandi direttori” e non “il” più grande direttore di tutti i tempi: come molti non illegittimamente affermano. I più grandi sono stati Giuseppe Martucci e Gino Marinuzzi; poi, non dimenticando noi Toscanini, dobbiamo menzionare almeno Fritz Reiner, che di Karajan non è stato meno grande. Resta che il ruolo sociale e pubblico del direttore d’orchestra, oggi ridottosi quasi a quello di macchietta, è stato rivoluzionato nel Novecento da Karajan. Il non essersi compreso il senso di tale rivoluzione è la principale fonte di equivoci sul Maestro. Egli è accusato di essere una star massmediale, di essere un gelido produttore di dischi, di aver sottoposto la musica alle esigenze discografiche, di essere un uomo spietato e senza scrupoli.
Incominciamo dalla fine. Non l’ho conosciuto di persona. Ho raccolto sufficienti testimonianze sulla sua generosità e sulla sua gentilezza. Basta guardare il filmato della Missa solemnis di Beethoven con i Filarmonici di Vienna e cogliere il sorriso di squisita gratitudine che rivolge al primo violino dopo l’ “a solo” del Benedictus per comprendere l’uomo. Un altro particolare mi colpisce. A Salisburgo un ascensore privato collegava il suo camerino al garage aziendale del Festival. Finita ogni recita, egli dal camerino scendeva direttamente in garage e dopo un quarto d’ora era davanti alla sua minestrina di verdura a casa. Di complimenti, abbracci, autografi, se ne fotteva.
Aggiungo due cose che mi paiono importanti. Arrivò tardi a Mahler; lo accusavano d’insensibilità verso la musica del Novecento, e a un certo punto incise i pezzi sinfonici della triade viennese, Schönberg, Berg, Webern. Incisioni imparagonabili. Nell’un caso e nell’altro, egli dà una lettura totalmente classica che riporta questi compositori nell’alveo onde scaturiscono. L’opposto di quella abituale, fatta per metter in rilievo la “rottura d’Avanguardia”. Fin che gli si contrappone il sommo Mitropoulos, è giusto; ma se ci si riferisce a Bernstein, per non dire ai poveracci oggi osannati, cadono le braccia…
Poi: uno dei documenti più commoventi che sia dato di vedere. L’ultima sua incisione. Il Finale del Tristano e Isolda con Jessye Norman. Quasi non aveva più forze, salvo quella morale. La sua delicatezza, il rispetto religioso suo verso la musica e della grande artista verso di lui. Aiuta a capire chi sia Karajan. Negli ultimi anni, fiaccato da un male alla spina dorsale: era passato per dolorosissime operazioni, e ogni gesto sul podio era una fitta di spasimo.
Veniamo al disco. Gli si contrappone, quale opposto modello, la “purezza” di Furtwängler, che Adorno aveva soprannominato “il custode della Musica”. Karajan ai suoi tempi ha inciso più di chiunque altro. Ma le sue incisioni sono, sempre e comunque, modelli di profondità interpretativa: è colpa sua se egli è stato capace di splendori di timbro e fraseggio che nessuno aveva prima di lui scoperti? In realtà, il rapporto di Karajan con la riproduzione tecnica della musica ha qualcosa di faustiano: nel senso ch’egli è stato il solo a scoprire quale sfida la tecnica della modernità alla musica ponesse. Tale sfida della tecnica egli, unico, ha affrontato, e vittoriosamente. Il problema posto da Heidegger. Se n’è accorto qualcuno?
*Da Libero Quotidiano del 16.7.2019








