
Avrebbe avuto ottant’anni, se fosse stato ancora vivo. Purtroppo, Leucio Miele morì il 4 marzo del 1975. Alla fine dovette arrendersi al cancro, lui che non si arrendeva mai.
A Roma, alla fine dell’occupazione di Legge e dopo la fondazione di Lotta di Popolo, Riccardo Paternostro, per gli amici Fofò, conosciuto in quei mesi, mi chiese di accompagnarlo a casa per sostenerlo davanti ai parenti ai quali avrebbe dovuto spiegare come mai non avesse dato nemmeno un esame. I suoi lo mantenevano senza badare a spese, ma in cambio si aspettavano risultati. Arrivammo al suo paese, Rotondella a una novantina di chilometri da Matera, dopo un viaggio di saliscendi su per montagne e colline (all’epoca il percorso attraversava decine di paesi). Fui accolto bene e non mi fu difficile spiegare che la “rivoluzione” aveva impedito al volenteroso Riccardo di dare gli esami. Nessuno, nemmeno io, dissi accorato, aveva avuto accesso all’università occupata.
I primi due giorni furono una pacchia: roba squisita e ben cucinata, vino fatto con l’uva, frutta dai sapori perduti. Al terzo giorno, mi preparai a ripartire. «Qui – dissi più o meno – non c’è nessuno con cui valga la pena parlare, me ne vado». Fofò mi rispose che c’era una grande persona, invece, ma forse non avrebbe accettato di parlare con me.
Così incontrai Leucio la prima volta. Stava sulla spiaggia di Nova Siri, un paese a una dozzina di chilometri da Rotondella, seduto sotto l’ombrellone calzato e vestito, immerso nella lettura. Fofò lo salutò deferente, lui alzò la testa, fece un cenno e riprese la lettura. Fortunatamente stava leggendo “L’arco e la clava”, un libro di Julius Evola e io ne approfittai: «Guarda la combinazione, proprio la settimana scorsa Evola mi ha detto di voler preparare una nuova edizione».
Leucio mi scrutò, sorrise e mi invitò a sedere. Fofò, tutto soddisfatto, mi presentò (un tantinello esagerando) e restò in piedi; non c’era ombra sufficiente per tutti e tre per cui ci annunciò che sarebbe andato al bar «a prendere una cosa fresca» e che sarebbe ritornato dopo un po’. Leucio gli disse di non preoccuparsi per me, mi avrebbe portato a casa sua e lui era libero di tornarsene a Rotondella.
Lo so: è stato un lungo preambolo, ma raccontare come ho conosciuto Leucio è importante soprattutto per dimostrare che all’epoca quasi tutto quello che facevamo ci capitava per caso o, se volete, per Destino. Io non avevo programmato di andare in Lucania e Leucio non pensava minimamente di rimettersi a fare politica.
Aveva un eloquio affascinante e proiettava una forza straordinaria. Era piccolo di statura e magro, ma quando s’infervorava (e infervorava l’uditorio) diventava un gigante. Dopo qualche giorno, tornai a Roma e dissi ad Enzo Maria Dantini: «Ho trovato il Capo, lo devi conoscere e mi dirai se non ho ragione». Ovviamente, avevo ragione e cominciammo ad organizzare incontri e dibattiti per mezza Italia con Leucio protagonista. Furono settimane incredibili. Una volta, durante un’assemblea, andò via la luce, ma Leucio continuò a parlare e la sua voce nel buio crebbe in magia. Prima o poi, proverò a scrivere qualcosa di serio a proposito di Leucio Miele.
Non andai ai suoi funerali, né ho mai partecipato a cerimonie di commemorazione o dibattiti sulla sua figura. La sua morte segnò per me una fine assoluta e ci son voluti anni per metabolizzarla. Al momento credo che il modo migliore di parlare di lui a quarantaquattro anni dalla scomparsa sia di lasciare a lui la parola.
In una lettera mi spiegava che, per motivi di famiglia, aveva dovuto interessarsi di più della sua azienda e scongiurava la tentazione di trasformarsi in un padrone-sfruttatore.
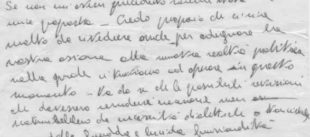
Scriveva: «Mi è letteralmente rovinata addosso Ia conduzione di una grossa azienda. La cosa non è semplice se pensi, tanto per esempio, che, fra le altre difficoltà presentatesi alla mia inesperienza, c’è anche quella di dover organizzare il lavoro giornaliero di trenta operai. Un lavoro tanto complesso ha letteralmente occupato tutti i miei spazi di libertà.
Non ho potuto far altro se non il “Massaro” e per giunta ad orario pieno e a ritmo massacrante. La cosa naturalmente non mi sconvolge. Accetto il tutto di buon animo in ossequio non tanto alla persona di mio padre Ia cui condizione umana e individuale mi interessa mediocremente, quanto al principio virile e paterno (nel senso della Sociologia tradizionale) che egli incarna.
Così ho creduto di poter accettare perfino Ia transitoria condizione di lavoratore. Posso comunque assicurarti che sono sempre vigile e controllo me stesso di modo che le condizionalità di ordine pratico legantesi alla mia nuova dimensione esistenziale non abbiano a prevalere. Questo perché nella situazione in cui mi trovo, c’e il rischio che un sottile processo d’introizione mi porti, sul piano fattuale, all’assunzione di taluni valori borghesi propri al mondo sfaldato del tellurismo contemporaneo.
E’ infatti possibile che in contesto esistenziale definito da spinte produttivistiche, finiscano per prevalere istanze mercantili necessitate dal profitto e dallo sfruttamento (…) Ma come ti dicevo sono vigile e non mi farò fottere. (…) Produzione, lavoro e roba del genere non portano luce agli Dei sui quali Ia Tradizione modella i suoi uomini».
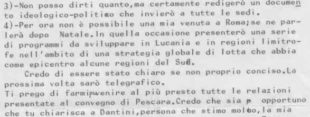
In un’altra lettera (scritta a mano: era la prima stesura, poi l’avrebbe dattiloscritta) che mi diede di persona la mattina che gli piombai a casa senza preavviso, stava tracciando le linee per un adeguamento di Lotta di Popolo alla nuova realtà politica. «Stavo scrivendo a te – disse – e il resto te lo dico a voce…». Istintivamente presi il foglio di carta e me lo misi in tasca. E ancora non mi perdono di non avere nemmeno una foto di noi due insieme.








