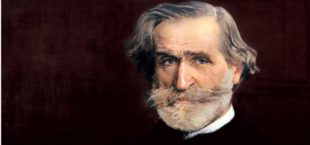
Nel novembre 1832 vi fu la prima rappresentazione del Dramma, subito proibito, di Victor Hugo Le roi s’amuse, fonte del Rigoletto di Verdi. “Forse il più gran dramma dei tempi moderni. Tribolet è creazione degna di Shakespeare!!”, scrive il Maestro. Credo c’egli non s’accorgesse di pensare già a se stesso. Degno di Shakespeare, per profondità e forza drammatica, è il suo carattere ben più di quello di Hugo.
Nel Dramma francese Verdi ritrova peraltro i temi fondamentali della sua creazione: l’amor paterno, il senso dell’onore. Manca l’amor di patria; ma v’è l’eros inteso quale sacrificio e sublimazione, il solo modo che, insieme con la rinuncia, a lui interessi. Pure, riesce a cantarvi l’eros in sé, quale sfrontatezza e gioioso cinismo, nello straordinario personaggio del Duca. Questo è un vero tratto shakespeariano: come l’occhio di Dio, i due sommi artisti possono raffigurare anche tutto ciò ch’è loro alieno. Ma il Duca è pur sempre un unicum nella creazione di Verdi.
Interessante l’equivoco estetico per il quale Hugo viene accostato al Bardo. In molte sue Tragedie personaggi comici fanno da contrappunto all’azione. È lo stile del teatro barocco; pur se il Becchino dell’Amleto dietro le battute ci dia i brividi. Qualunque cosa Shakespeare dalla tradizione o dalla convenzione assuma, trasforma in assolutamente suo. Ma questi ruoli buffoneschi sono affatto estranei all’azione principale. Il colpo di genio di Hugo sta invece nel fare protagonista di una Tragedia un essere ch’è la personificazione stessa del laido. Triboulet, giullare del re di Francia, è gobbo, infame, gode del male che commette e al quale incita come sola vendetta per la sua deformità fisica e morale. La rappresentazione della sua psiche è il centro del testo francese. Il colpo di scena, che mostra la doppia anima del buffone, è che abbia una figlia e sia capace di amarla in modo geloso e protettivo dopo esser stato per pietà amato dalla di lei defunta madre. Quasi sempre “in Cielo” stanno le madri in Verdi. Un’obiezione a tale tesi è che anche in Shakespeare v’è un personaggio infame e deforme, Riccardo Terzo. L’obiezione sarebbe infondata. In quanto Re, Riccardo è un protagonista tragico in senso classico. Uno dei più profondi libri mai scritti sulla poetica drammatica è L’estratto della poetica d’Aristotile di Metastasio: vi si afferma che i caratteri della Tragedia “non dalle morti, dalle stragi e da’ funesti fini ma dal corso di fatti grandi e strepitosi e dalla rappresentazione di personaggi reali discendono.” Nella sua Tragedia, Shakespeare compie una deformazione della storia ingiusta e violenta quanto quella di Tacito a proposito di Tiberio. In tutta la narrazione del principato del figlio di Livia il sommo storico crea una somma opera d’arte, ancorché basata sul falso, e nelle fosche ombre del personaggio immaginario da lui creato non possiamo non vedere in lui un precursore di William. Nella Tragedia del Bardo, il dialogo della quale procede quasi sempre nello Stile Sublime, il personaggio di Riccardo, astuto, simulatore, dissimulatore, odiatore del genere umano, il quale compie il male anche solo per il piacere di compierlo, è tuttavia del Male un tale genio, da assumere, non che l’altezza tragica, dimensioni gigantesche e persino eroiche: sin nella sconfitta e nella morte. In ogni suo aspetto, è un carattere colossale con pochi confronti.
Or ne Le roi s’amuse abbiamo sì un Re di Francia, Francesco Primo, ma non “fatti grandi e strepitosi”, solo il piccolo vizio di un piccolo uomo; e il protagonista Triboulet, per la sua infima, e per dir meglio estranea a ogni ordine, collocazione sociale, oltre che per la sua deformità, è quanto di più lontano ci sia da un “personaggio reale”. I canoni del teatro classico sono rovesciati, forse per la prima volta. La grande idea si traduce in una grande opera d’arte? Non ne sono certo. La metamorfosi la compie Verdi.
L’estetica del teatro musicale, sebbene quello comico di Rossini conosca sia il realismo che il grottesco, resta nell’Ottocento ancora quella classica settecentesca. Ma il grottesco di Rossini è solo grandiosamente comico (Mustafà, Don Magnifico), non è applicato alla categoria del Male come per la prima volta col Rigoletto avviene. Il sentimento in sé (l’ “affetto”) conta più del carattere che lo prova. Ciò è quasi una regola in Rossini, pur con le sue eccezioni; Donizetti, Bellini e Mercadante danno luogo a un inizio di trasformazione, che Verdi attua. Solo Verdi, sin dall’inizio della sua creazione, raffigura per intero non sentimenti siccome provati da personaggi, sibbene caratteri, individuali e irrepetibili, i sentimenti dei quali evolvono a seguito dell’azione drammatica. Ma pur sempre attraverso il mezzo artistico d’una trasfigurazione ideale. Per la musica il grande interrogativo è: come si fa a rappresentare artisticamente ciò ch’è deforme e infame senza che lo stile divenga esso stesso deforme e infame? Ecco l’abisso che separa Verdi da Hugo, il teatro musicale dal teatro di parola. Nel teatro musicale la forza di un elemento simbolico muta radicalmente il rapporto fra creazione e creatore, da un lato, fra creazione e chi tale creazione deve contemplare, dall’altro.
Non consideriamo ancora l’anima paterna di Rigoletto, fremente insieme e solenne: questa si scopre solo a metà del primo atto. All’inizio abbiamo una musica asimmetrica, dissonante, volgare: in certi punti essa mima lo stesso incedere zoppo del gobbo. La prima immagine di qualcosa di simile si trova in un’altra composizione geniale, l’ultimo tempo della Sinfonia fantastica di Berlioz, di oltre vent’anni precedente. In particolare, in due sezioni, all’inizio (primo accenno: primo Allegro, Do maggiore; e soprattutto: secondo Allegro, Mi bemolle maggiore), la stridula combinazione di ottavino e clarinetto piccolo altera in sei ottavi, con “acciaccature” grottesche che lo sporcano e rendono sconcio, il Motivo fondamentale dell’intera Sinfonia, l’idée fixe impersonificante la donna amata e idealizzata quale simbolo stesso dell’Arte. Esso è ridotto a un saltellio “zoppo” (semiminima più croma), una sorta di deformato trocheo, su dei furiosi balzi arpeggiati dei fagotti in quartine di semicrome seguite da una pausa. È l’angelica creatura che, nel Songe d’une nuit du Sabbat, divenuta strega al raduno diabolico, incede per saltelli zoppicando, e la zoppìa è ancor più accentuata, con pittura precisissima, dal sovrapporsi dei due ritmi, l’acuto e gli arpeggi dei fagotti. Quando, nel primo atto del Rigoletto, Monterone appare (“Ch’io gli parli!”), l’orchestra sviluppa l’idea di Berlioz con asimmetrici trochei cromatici (possiamo dirli tali se assumiamo che la sillaba “breve” è fatta di gruppi di biscrome, preceduti da un altro gruppo in anacrusi, che si giustappone a valori più lunghi), precisa immagine di Rigoletto che strascicando la gamba s’avvicina al vecchio irato prima d’insultargli platealmente coram populo. Ma Verdi possiede una sintesi e una sicurezza stilistica che il sommo Maestro francese acquisterà solo in seguito; questi, nella Sinfonia, svilupperà, rendendolo un pezzo monumentale, il movimento finale con ingegnose sovrapposizioni contrappuntistiche, l’ingresso del Dies irae, e una Fuga. A Verdi basta il “declamato” del giullare, Voi congiuraste contro noi, signore. Sulla lunga a di “congiuraste” (due semibrevi legate più una semiminima a cavallo di battuta) gli archi, all’unisono e raddoppî, disegnano una figurazione: semicroma più croma più pausa di semicroma; l’ultima semicroma finisce su di una semiminima che, prolungandosi attraverso la legatura di una semicroma, è di nuovo, nella sua asimmetria, nella sua irregolarità, il disegno dello storpio che zoppicando circonda il personaggio tragico e il suo dolore. Dopo “signore”, nella pausa della voce, un “gruppetto” acutissimo di biscrome di flauto, oboe, clarinetto, in eco, ti fa vedere lo sberleffo che il giullare rivolge alla vittima. Il procedimento si ripete sulla o di “e noi”. Indi, sulla i di “delirio” e sulla o di “ore”, la voce emette un trillo d’irrisione poggiante su di un accordo degli archi di settima sulla sensibile di Fa minore in posizione fondamentale e senza la terza, dunque vieppiù pungente; e i violini raddoppiano il trillo. Il grottesco insieme e l’orrido. A una fantasia “romantica”, simulante il sogno, o meglio il delirio da intossicazione, di un Sabba, egli contrappone il realismo drammatico di una fantasia classica.
 (Che poi “romantica” quanto a elemento, dirò così, descrittivo e programmatico, perché ispirata da un Romanticismo letterario molto francese, sia l’opera del giovane Berlioz, ma, come sempre in lui, assai classica nella forma, è un altro discorso. Classica, ma con un tanto di “scucitura dello stile” acutamente additata dal Fétis.)
(Che poi “romantica” quanto a elemento, dirò così, descrittivo e programmatico, perché ispirata da un Romanticismo letterario molto francese, sia l’opera del giovane Berlioz, ma, come sempre in lui, assai classica nella forma, è un altro discorso. Classica, ma con un tanto di “scucitura dello stile” acutamente additata dal Fétis.)
L’ assioma estetico dei due compositori, tuttavia simile, è: la raffigurazione dell’abbietto è possibile alla musica solo se si abbia contemporaneamente l’affermazione di ciò ch’è la bellezza in senso ideale. L’orrido non può in musica esistere di per sé, ma solo in quanto opposto alla bellezza classica. E questa non solo è presente nell’Opera, nell’effusione paterna di Rigoletto, piena di pathos, o nella sua invettiva contro i cortigiani, che lo eleva a ineguagliata altezza tragica, anche per la sua successiva preghiera rivolta a loro, che sono i veri personaggi abbietti del capolavoro. È presente nella qualità di prius della stessa esperienza artistica dello spettatore, perché giace nel deposito della memoria, ed è automatico termine di confronto. Né hanno senso le sfrontate canzoni del Duca se non in rapporto alla profondità e nobiltà di sentimento di Rigoletto e sua figlia Gilda. Sarà esattamente la stessa scelta compiuta da Wagner per raffigurare i suoi caratteri laidi, Mime, Alberich e Beckmesser. Siccome Beckmesser non è solo un personaggio drammatico, ma è anche l’esposizione di una tesi poetica (i Meistersinger von Nürnberg sono un trattato estetico in forma drammatica), il brutto ch’egli incarna è addirittura il brutto in sé, l’idea platonica del brutto: e lo si vede nella gara di canto con Walter, nella contrapposizione fra le due Canzoni e nella goffa imitazione che Beckmesser tenta di quella dell’eroe. Ho pochi anni fa dedicato un saggio all’idea della Bellezza nei Meistersinger.
Di più. Sarebbe assurdo, sebbene troppo lo si pratichi, eseguire le Canzoni del Duca in concerto: esse acquistano il senso solo dal piano drammatico. Egualmente e ancor più lo ha l’eseguire in concerto le due Arie cantate da Gilda nel primo atto, Signor né principe e Caro nome. Attraverso sofisticati processi di banalizzazione, e vorrei dire di bovarizzazione avanti la lettera, Verdi non fa che dipingere una scioccherella in preda alle illusioni, ripeto, bovaristiche d’una piccola mente. Il suo grande carattere nasce dopo il rapimento e dopo che il Duca la viola brutalmente nel suo proprio talamo. Dal dolore deriva un’alta eroina: ed ecco l’amore sublimato in sacrificio, prediletto da Verdi. Una conquista simile non sarebbe stata possibile a Hugo.
Una parola sulla Canzone del terzo atto, La donna è mobile. Il generico canto del Re immaginato da Hugo mentre Rigoletto regge il sacco ch’egli crede contenga il suo cadavere diviene una terza strofa di tale Canzone. Le prime due si terminavano con un Si naturale medio; questa con un Si naturale acuto. Come non vedere in questa nota acuta uno sfregio vittorioso del Duca, il quale se ne va, sottrattagli la spada, avendo di certo da Maddalena appreso di esser scampato a un mortale agguato? Dunque lo sfregio è direttamente rivolto a Rigoletto, mancato uccisore del Duca per mano di sicario. Persino una strofa di una Canzone strofica è per Verdi un possente mezzo drammatico. Il Triboulet di Hugo, atrocemente sorpreso nel mero teatro di parola, diviene qui un uomo pietrificato da un orrore che ancora, pur oscuramente conoscendolo, si rifiuta di riconoscere. La catastrofe del capolavoro di Verdi contiene anche una lezione morale. Il santo amor paterno di Rigoletto viene punito (effetto della “maledizione”) perché egli non è stato capace di trasformare il suo dolore in perdono, o almeno oblio, ma solo in sentimento di vendetta. Sul compianto disperato del gobbo su Gilda morente aleggia lo stoicismo antico fatto proprio dalla predicazione di Cristo: due pensieri alieni a Rigoletto. E lo stesso amor paterno ne viene inquinato, quasi, incapace d’esser convertito in perdono, fosse un “amore mal diretto”.
Un caro amico, Giovanni Vasso, lette queste pagine, mi ha fatto osservare che uno dei più grandi poeti americani, dalla morbosa fantasia romantica pur nutrita d’una formazione classica, immagina la vendetta d’un giullare. Un giullare pur egli deforme, pur egli costretto a far ridere il suo Re, pur egli animato da un sentimento delicato verso l’unica creatura che da lui si faccia amare, la ballerinetta nana. Si tratta di Hop-frog di Edgar Allan Poe, che venne pubblicato poco dopo la morte dell’Autore nel 1849. Al buffone l’atrocissima vendetta immaginata va a buon fine; come sovente in Poe, la fantasia macabra si combina con un grottesco di fondo. Non credo Verdi l’abbia letto; ma piacque, come tutti sanno, a Baudelaire. E sarebbe piaciuto assai a Rigoletto stesso.
L’invettiva da Rigoletto rivolta ai cortigiani nel secondo atto, sopra ricordata, lo eleva d’improvviso a statura regale, per poi mostrarlo spezzato e fragile perché il suo amore per la figlia, l’unico sentimento alto onde egli sia posseduto, lo fa indifeso. Forse l’illustrissimo modello di un simile brano, che esorbita dagli stessi confini della “Scena” fatta di parti declamatorie e parti liriche, è il delirio di Assur verso la fine del secondo atto della Semiramide di Rossini. Qui in particolare Verdi dice una parola nuova e potente. Ancor più inclassificabile dal punto di vista della forma, ma da tale punto di vista rigorosamente organizzato, è questo brano che fonde tutta la forza drammatica del “declamato” e dell’Arioso con quella lirica dell’Aria. Ma la forma classica non è rovesciata: è interpretata in modo nuovo e ampliata, anche per la fusione e collaborazione fra la voce e un’orchestra che interpreta, approfondisce, costruisce uno sfondo simbolico. Ancor più classico appare il brano se si pensa che ancor più, per la funzione dell’orchestra divenuta quasi un’autonoma proclamazione del destino, deriva dalla tecnica drammatica di Mozart.
Il paradosso, non chiaro a tutti, è dunque questo. La rivoluzione estetica del Rigoletto è assai più profonda e importante, oltre che alta sul piano del valore, del dramma di Hugo; ma mentre esso rovescia le categorie dell’estetica classica, il Rigoletto la stabilisce ancora una volta. Affermare che un nesso diretto stringe Verdi a Orazio e Virgilio può parere ardito; ma persino Wagner, che per non belle ragioni politiche affetta di disprezzare la latinità, senza di loro non sarebbe; e non dico di Berlioz, il più grande virgiliano della musica, oltre che con Verdi il più grande shakespeariano.
Il paragone volge a sfavore del poeta francese anche solo se si paragoni il suo Dramma col Libretto del Rigoletto. La sua bruciante sintesi è il frutto del dominio esercitato da Verdi, sovrano librettista di se stesso, sul proprio poeta drammatico. Ma Piave è un poeta di alta qualità, e spesso di altissima quando Verdi lo guida. Un testo pieno di lungaggini e giuochi di parole e acutezze come quello di Hugo diviene un emblema di concisione tale da attuare quasi la poetica dell’Anonimo Del Sublime. I tempi drammatici che il poeta e il compositore creano sono d’una velocità sconvolgente. S’immagini solo l’inizio, la mancanza d’ogni antefatto. Dopo l’ultimo accordo di Do minore del brevissimo Preludio, atto a illustrare l’’ “atmosfera morale” (così dice Rossini) del dramma, ex abrupto udiamo la musica, volutamente volgare, della banda, che accompagna la festa del Duca. (Sebbene la figura ritmica sia simmetrica e non asimmetrica, è possibile che un residuo mnemonico del citato passo della Sinfonia di Berlioz agisca sul suo profilo.) Qualcosa di simile la musica non l’aveva mai visto. E aggiungo: non solo volgare è la musica della festa. La seconda banda, questa volta d’archi, esegue un Minuetto, omaggio a quello dell’orchestrina del Finale I del Don Giovanni di Mozart, elegantissimo. Esso, insieme coll’altra danza, il Perigordino, è atto anche a stabilire l’atmosfera d’una Corte rinascimentale, abitata sì da uomini volgari ma pur sempre retta da elegante etichetta. E le due danze antiche situano anche la vicenda dal punto di vista storico. Mai si dovrebbe cambiarne epoca e luogo. Verdi crea colla sua musica anche l’ambiente, è scenografo, oltre che regista. Ambiente esterno, ambiente morale. Allo stesso modo, nel terzo atto, egli, coi soffi della tempesta, ci fa sentire l’odore delle acque del Mincio. Il passaggio del Dramma da Parigi a Mantova, nato da motivi di censura, non è un burocratico trasferimento. Sarebbe del pari assurdo se un regista volesse ambientare il Rigoletto giusta Hugo, alla Corte di Francesco Primo. Non so se non sia stato fatto; di certo, prima o poi qualche cretino, illuso d’essere un genio, verrà a proporlo ai cretini che andranno ad applaudirlo.
Il nome di Mozart, e quello del Don Giovanni, non hanno da essere, a proposito del Rigoletto, citazione episodica. Il Don Giovanni era un oggetto di culto dell’unico insegnante di composizione che Verdi abbia avuto, l’altamurano (come Mercadante) Vincenzo Lavigna, peritissimo contrappuntista formatosi al napoletano Conservatorio della Pietà dei Turchini; e sappiamo che questi ne inculcò lo studio e l’ascolto al discepolo con grande insistenza. Personaggio fondamentale del Rigoletto è il conte di Monterone, il basso che pronuncia la maledizione verso colui che irride all’onore di un padre. Ben altro rilievo acquista tale figura nel passaggio da Hugo a Piave-Verdi: qui Monterone è la vera chiave dell’azione, e l’idea della maledizione percorre tutta l’Opera in senso tematico, dal Preludio sino alle ultime battute. Quanto diverso l’accordo di settima diminuita quando, dall’uso generico, sovente eccessivo, che se ne faceva all’epoca, viene adoperato con somma arte! Monterone, non tanto per derivazione musicale, ma come idea drammatica, è una reincarnazione del Commendatore del Don Giovani: da immagine puramente metafisica diviene personaggio reale la parola del quale ha, tuttavia, anche effetti metafisici, se consideriamo il nesso causale che la lega alla vicenda di Rigoletto. Sia tale vincolo un dato di fatto – ossia: abbia la maledizione potere in fatto – , sia esso un fatto nella mente di Rigoletto, al fine drammatico cambia poco. Un altro possente legame è fra le due Opere. Nel Sestetto del secondo atto di Mozart, Sola sola in buio loco, il pezzo d’insieme viene trasformato in azione drammatica: azione assai analiticamente svolgentesi per via delle varie sezioni nelle quali il brano si compone. Ciò è un’assoluta novità: il pezzo d’insieme, se si eccettuano i Finali di Cimarosa, Paisiello, poi Mozart, nell’Opera comica, rappresenta sempre una cesura del tempo dell’azione: cesura dedicata all’espressione dei sentimenti di ciascuno, contrastanti di solito nel testo ma basata, tale espressione, su di un Motivo, o Motivi, comuni. Nel Sestetto di Mozart i personaggi in parte sfruttano variandoli Motivi comuni, in parte ne hanno di proprî con proprie figure ritmiche. La somma invenzione musicale si congiunge a somma regia, che puoi cogliere anche in ogni minima inflessione orchestrale. I grandiosi Concertati delle Opere buffe e serie di Rossini sono di regola una parentesi affettiva nel flusso dell’azione, e l’unità motivica vale a esprimere sentimenti varî e opposti. Il Quartetto del secondo atto, Bella figlia dell’amore, oggetto di una delle più belle Parafrasi-Fantasie di Liszt, parte dalla stessa tecnica drammatica e musicale. È più conciso del Sestetto del Don Giovanni, non essendo diviso in sezioni; è nondimeno un pezzo d’insieme d’azione e non solo di manifestazione di contrastanti sentimenti. D’azione, perché nel suo corso idealmente si consuma l’amplesso fra il Duca e Maddalena, e perché i sentimenti provati dai partecipanti sono un’ulteriore evoluzione della loro psiche. Ma quel ch’è straordinario, è che ciascuno dei quattro è un diverso carattere musicale e drammatico: il contrappunto di Verdi, fattosi dramma, congiunge, sovrappone, giustappone, quattro diverse figure ritmiche e tematiche. È il punto culminante di un secolare processo storico; nel caso specifico, ecco che cosa diventa quella che solo quale decennio prima era l’Aria cosiddetta “con pertichini”, ché da questa forma il Quartetto rampolla.
Un altro insuperabile esempio d’ambientazione è nella scena del primo atto fra Rigoletto e Sparafucile. Notte, buio. Dialogo furtivo. La “parola scenica” – la vera ossessione drammatica di Verdi – si attua dopo che violoncello e contrabbasso soli, accompagnati da un raffinatissimo tessuto di archi gravi divisi e dai soli clarinetti, fagotti e gran cassa, hanno esposto un Motivo che continuerà, con sempre mutate voci interne, ad accompagnare il dialogo fra i due. Gli archi passano dal “pizzicato” all’uso con l’arco. La “parola scenica”, ossia il declamato-Arioso, è plasmata con l’assoluta libertà di un vero dialogo sui generis; ma al tempo stesso il Motivo, fattosi una forma musicale “pura”, ossia il Tema con Variazioni, non abbandonerà mai i due personaggi. Ed è un motivo ambiguo, serpentino. L’uso di una forma musicale “pura” si trasforma in Verdi in un’ossessione: duplice: il sospetto, in Rigoletto, il guadagno ottenuto attraverso il delitto, in Sparafucile.
 In Verdi un altro miracolo artistico rampolla dalla stessa fonte. Ogni particolare della sua musica contiene la rappresentazione drammatica: non solo il sentimento espresso dalla parola, lo stesso gesto. È la più perfetta e insostituibile regia. In ciò, ripeto, solo Mozart gli è pari. Ancora una volta, sembra che la musica si faccia “altro da sé”; e invece nel Maestro italiano questo coincide con la più severa forma musicale. Solo ai sommi della musica è dato sciogliere questa contraddizione in termini.
In Verdi un altro miracolo artistico rampolla dalla stessa fonte. Ogni particolare della sua musica contiene la rappresentazione drammatica: non solo il sentimento espresso dalla parola, lo stesso gesto. È la più perfetta e insostituibile regia. In ciò, ripeto, solo Mozart gli è pari. Ancora una volta, sembra che la musica si faccia “altro da sé”; e invece nel Maestro italiano questo coincide con la più severa forma musicale. Solo ai sommi della musica è dato sciogliere questa contraddizione in termini.
Esprimo tali considerazioni visto il gran parlare che del Rigoletto si è in questi giorni fatto dopo due diversissime messinscene, l’una all’Opera di Roma, l’altra al Teatro Lirico di Cagliari. Ho ricordato che con la regia la musica di Verdi contiene persino l’ambientazione, naturale e scenografica; e solo il rispetto di essa attua la verità artistica della sua creazione (ciò vale anche per l’allestimento dell’Attila che ha aperto la stagione della Scala!). E il Rigoletto è la massacratissima fra le Opere di Verdi per le violazioni del testo musicale: tagli, aggiunte di pause, storpiature, note alterate, inaccettabili cambi di tempo, “parlando”, effettacci che per voler realizzare il grottesco sono solo grotteschi. Basta ascoltare anche le più celebri incisioni. In genere i cantanti non italiani, pur ottimi in altro repertorio, indulgono in questi effetti nell’ingenua convinzione che la musica italiana abbia qualcosa di pittoresco e poco legato alla forma. Fra i tanti grandi italiani svetta, per articolazione e capacità di canto e varietà di accenti e articolazione del “declamato”, Giuseppe Taddei: nella sua incisione il direttore è l’eccellente Angelo Questa. Ma anche i migliori interpreti, e con l’avallo di direttori solitamente rigorosi, non resistono a quel lunghissimo Sol nel monologo di Rigoletto del primo atto su È follia che Verdi vuole un Mi pronunciato piano: è un monologo interrogativo di un uomo avvolto dalla notte, prima ch’esploda il Do maggiore della gioia a Rigoletto procurata dall’incontro con la figlia. Non resistono di fronte a un lunghissimo Mi bemolle subito prima del Finale del secondo atto su “Un vindice avrai”: e Verdi vuole un secco, rapido Do, il quale fa da “nota comune” per la modulazione a La bemolle maggiore di Sì, vendetta, tremenda vendetta. I tenori e i direttori d’orchestra indulgono in tempo lento, pause, sospiri, “rallentando”, nel grande Recitativo del Duca col quale si apre il secondo atto, Ella mi fu rapita. Ch’è invece l’esplosione del furore di un onnipotente despota il quale, per “contrasto d’affetti”, per un istante poi s’illude che un amore – ancora non consumato: ecco la chiave – sia per dargli quella profondità di sentimento che nell’eros egli si gloria di non possedere. Tutto questo, e tante cose ancora, attribuisce a Verdi una volgarità musicale e drammatica che poi, per una erratissima convinzione, viene considerata propria dell’Opera cosiddetta “verista”. Verdi era così convinto del “criterio” con il quale ogni particolare della sua creazione è concepito che più volte negò ai teatri che non rispettavano il primo e la seconda l’autorizzazione a mettere in scena le sue Opere. L’edizione critica del Rigoletto, apparsa nel 1996, viene tuttora poco adottata dai teatri; ma è soprattutto la testa degl’interpreti che andrebbe radicalmente modificata, ché un’edizione critica non è che il primo strumento per una comprensione drammatico-musicale a pochi concessa. Non tutti i direttori d’orchestra che l’hanno adottata hanno poi ben concertato e diretto l’Opera. Detto generalmente: Verdi è Maestro ammantato d’ignoranza ed equivoci grossolani.
A Cagliari la regia di Pier Francesco Maestrini, con le scene di Juan Guillermo Nova, reintroduce la Mantova di Giulio Romano e il Mincio, in luogo della Repubblica Sociale dell’Opera di Roma. Soprattutto, a Cagliari un grande direttore e concertatore, Elio Boncompagni, ripristina la classicità della partitura: trasparente l’orchestrazione, sì da mostrare quanto cameristica essa sia; plastico, rilevato, il contrappunto: il Quartetto così eseguito è un modello interpretativo; stacchi di tempo in rapporto fra loro come in una Sinfonia classica, sì da far coincidere scienza e arte; e la volontà di Verdi attuata fino in fondo. I lunghi colloqui che negli anni ho avuti con Boncompagni sono valsi a illuminarmi più di ogni altra cosa sulla natura del Rigoletto, come del Trovatore, come del Don Carlos. Dopo la “prima” a Cagliari, ho sentito qualcuno commentare: “Non sembra Verdi, sembra Beethoven!”. Questa sancta simplicitas voleva dire una verità più grande: Rossini e Verdi sono, insieme, il nostro Mozart e il nostro Beethoven.
*Da Libero Quotidiano del 20.12.2018








