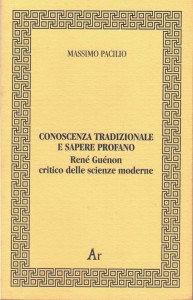Massimo Pacilio ha raccolto gli articoli di Evola apparsi su “La Vita Italiana” e da quasi 20 anni è autore delle Edizioni di Ar, con cui ha pubblicato anche un libro su René Guénon. Un tradizionalista, termine che sempre più spesso viene associato al meridionalismo o per meglio dire al Borbonismo.
Professor Pacilio, le Edizioni di Ar, da sempre attente al tradizionalismo, cosa riscontrano di tradizionale nel meridionalismo di oggi?
Quando parliamo di meridionalismo intendiamo un insieme di opere e di autori così eterogeneo da rendere difficile il disegno di una precisa linea di confine. Tuttavia, agli studi susseguitisi negli ultimi tempi va riconosciuta una funzione essenziale: la capacità di aver corretto la percezione del paesaggio etnico meridionale, collocando in una nuova luce gli elementi di una storia spesso oscurata e deformata. Sottratto, così, all’“agiografia risorgimentale”, il Meridione può essere inteso come ‘morfologia di una Nazione’ e, quindi, proprio perché espressione di una kultur, esso smette di rappresentare un concetto recluso nel campo degli studi sociali, per essere invece il riflesso di una tradizione che risale, non dimentichiamolo, ad un’epoca immune dalla “modernità”. In questo senso, non certamente nelle dispersive analisi economiche – che immancabilmente soffrono dell’urgenza dell’originalità a tutti i costi –, ma negli studi storici di recenti studiosi si possono ritrovare motivi riconducibili ad una visione tradizionale, soprattutto quando si riesce a cogliere aspetti come il legame profondo tra l’autorità regale e il popolo meridionale, oppure la capacità dei monarchi di restare “in ordine”, anche quando le vicende europee aprivano spazi al compromesso con i nuovi dogmi del liberalismo. Quando il meridionalismo, invece, si risolve nella semplice rivendicazione di un primato tecnologico, industriale o finanziario non fa altro che replicare, ma in una veste già logora, gli stessi motivi di coloro che furono i nemici del Meridione.
Sempre più si svelano i segreti della storia, sempre più si scopre sul ruolo fondamentale della massoneria e dell’Inghilterra nei fatti del risorgimento, non è anche una vittoria di chi ha sempre sostenuto l’esistenza del complotto mondialista?
Sì. Il pensiero tradizionalista ha da sempre riconosciuto l’esistenza di quella che è stata definita “la terza dimensione della storia” (Evola). Non è necessario essere “credenti” per veder operare nella storia agenti che hanno scopi non dichiarati o dissimulati. La necessità, per chi ambisce al potere, di non manifestare le proprie intenzioni è un’antica prescrizione nota sin dai tempi di Sun Tzu e ribadita anche nell’opera del Machiavelli. Oggi, nella propaganda di regime, il termine “complotto” – ancor più quando è accompagnato dall’aggettivo “mondialista” – è sinonimo di ossessione per la “dietrologia”, ma è altrettanto evidente che questa accusa, con cui si pretenderebbe di escludere dalla storiografia ciò che non è “scientificamente” dimostrabile, ha essa stessa uno spiccato carattere ideologico: serve, infatti, a legittimare l’ordine costituito. Dopo la seconda guerra mondiale, e in maniera più accentuata dopo il crollo del muro di Berlino, i regimi democratici non esibiscono mai, se non nelle aree periferiche, un volto repressivo, avendo riposto tutte le loro forze nel condizionamento e nella distorsione delle menti, ossia nell’impero del “pensiero unico”, del “politicamente corretto”. Il contributo più efficace alla costruzione di questa ideologia è venuto sicuramente da quegli ambienti che, convenzionalmente, definiamo “massonici” e che sono stati all’opera durante l’unificazione politica italiana. Il passaggio della Francia dalla monarchia alla repubblica e, ancora prima, la fabbricazione di quella Non-Nazione che sono gli Stati Uniti d’America costituiscono, insieme alle altre rivoluzioni liberali europee, il trionfo di quei progetti politici elaborati segretamente nelle logge e di cui attualmente la Massoneria è orgogliosa. Il Meridione fu una delle numerose vittime di questa trasformazione, ma è facilmente riconoscibile l’abissale distanza che separa gli artefici di questi cambiamenti dai popoli meridionali, che in quegli anni non solo non ottennero il miglioramento sociale che veniva loro promesso, ma che videro nell’emigrazione – e quindi nello sradicamento – la loro unica possibilità di sopravvivenza. Sin dai primi momenti, al di là della retorica, la stessa Patria, che dapprima venne esaltata per abbattere le monarchie, apparve come un ostacolo sulla via del “progresso”. Con la delineazione di una visione differente della monarchia borbonica si è aperta la possibilità di rileggere un intero periodo storico come contrasto all’opera di sradicamento che il secolo dei lumi aveva avviato.
Il meridionalismo, una geopolitica romantica o una concreta autodeterminazione?
Nelle forme in cui si è mostrato, il meridionalismo è apparso talvolta come la nostalgia di un passato mitico. Su altri versanti, invece, ha assunto i caratteri di un’indagine sociologica che si prefiggeva il compito di individuare le cause del divario tra Nord e Sud del paese, dando l’avvio ad una ricerca che si è poi dispersa nelle analisi di una quantità innumerevole di dettagli, tutti degni di considerazione, ma che non hanno permesso un’azione politica capace di colmare quel divario. Ciò che alla mentalità sociologica e scientista riesce difficile da accettare, infatti, è la impossibilità di ridurre un popolo, un’etnia, una razza, ad una grandezza meramente quantitativa, secondo i dogmi del materialismo. Nelle prospettive meridionalistiche capaci di superare il ristretto orizzonte scientista – vale a dire in quelle opere in cui emergono la morfologia etnica e la storia del legame profondo tra paesaggio umano e geografico – si possono rintracciare i fondamenti di una “concreta autodeterminazione”, che può fiorire proprio da una “geopolitica romantica”, se con questa espressione alludiamo ad una distanza da quel piano socio-economico su cui spesso si è esaurito il discorso del meridionalismo.
L’esempio della storia del Meridione d’Italia dovrebbe pur servire di insegnamento agli immemori politici italiani, dal momento che oggi possiamo assistere ad una impressionante “ripetizione dei fatti”. Il Meridione visse nella seconda metà dell’Ottocento, a seguito del suo forzato inglobamento nella nuova Italia unita, ciò che l’Italia di oggi vive in seguito al suo inglobamento nell’Unione europea. La moneta unica e la Banca centrale (che in Italia arrivò molti anni dopo l’unificazione) sono strumenti di controllo politico e di drenaggio di risorse, allora come oggi. Nonostante il secolo e mezzo intercorso, e facendo le dovute proporzioni, il fenomeno a cui abbiamo assistito è assolutamente identico: un’area egemone acquisisce il controllo di un’altra (allora attraverso la guerra, oggi mediante i trattati) e la impiega come riserva di manodopera a basso costo e luogo di smercio dei propri prodotti. Oggi stiamo assistendo al ripetersi della stessa situazione, a dimostrazione del fatto che – a differenza di quanto viene ripetuto dal “pensiero unico” – anche il popolo che non dimentica i propri errori è capace di ripeterli.
Si può dire che Aleksandr Dugin ed Edward Luttwak, pur partendo da considerazioni diverse, disegnano un futuro che sembra combaciare con quello che fu l’antico ruolo delle due Sicilie?
Molte affermazioni di Dugin – ad esempio la necessità di scardinare la globalizzazione imposta dagli Usa attraverso l’ideologia liberale e il mercato – sono senza dubbio di grande interesse. D’altronde, l’origine guénoniana di alcune di esse è evidente. Quando respinge, ad esempio, la pretesa universalità dei diritti umani, che altro non sono che l’imposizione generalizzata di un certo tipo umano moderno, sembra di rileggere certe pagine di Guénon contro il concetto di homme universel in Pascal. L’affermarsi di un punto di vista esclusivamente individualistico, che rappresenta l’essenza della modernità, è perfettamente chiarito in molte opere di René Guenon, ed è stato in seguito ripreso e ampliato da Julius Evola. E’ importante, tuttavia, chiarire che non si deve confondere la spinta individualistica con la legittima rivendicazione da parte delle comunità nazionali di un proprio spazio nel quale radicarsi. In Dugin questa differenza è ben visibile, mentre appare in maniera molto meno nitida in Luttwak. Oggi, infatti, si vuole surrettiziamente far passare il concetto secondo cui la difesa del proprio territorio sia una forma di “egoismo”, laddove è esattamente il contrario: è una volontà di conservare la propria Nazione, evitando che possa disperdersi nell’indistinto caos di una umanità senza forma. Quest’ultima sì, il cosiddetto melting pot, sarebbe il trionfo dell’individualismo, proprio nel senso in cui lo delineò Guénon: una umanità ridotta ad una sorta di sabbia, di cui ogni individuo è un granello infinitesimale e indistinguibile. Contro questa parabola esiziale vedo meglio delineato il pensiero dello scrittore russo, che ridefinisce gli elementi di una “rivoluzione conservatrice” adatta a questo momento storico. L’analisi di Luttwak non è in grado di andare oltre gli interessi statunitensi, e finisce per recuperare il ruolo dello stato-nazione solo per giustificare indirettamente l’egemonia degli Usa, di un paese, cioè, concepito e realizzato nelle logge massoniche; un paese che richiede, come condizione preliminare del dispiegamento del suo primato, una trasformazione dell’ambiente giuridico e istituzionale in senso democratico-illuministico, e quindi la distruzione di qualsiasi ordinamento che abbia una matrice tradizionale o etnica. (Da Il Roma, di Antonio Vasile)