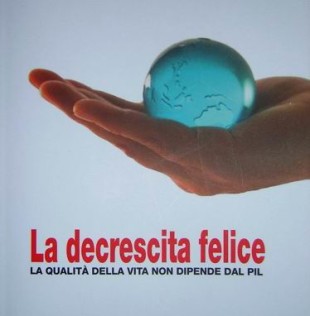 Quando Beppe Grillo auspica una “decrescita felice”, gli si risponde generalmente che l’Italia è già in decrescita e che il fenomeno non risulta per nulla felice. In realtà, la decrescita di cui parla Grillo non corrisponde alla recessione economica. Si tratta di una scuola di pensiero sui “limiti dello sviluppo” che ha le sue origini negli anni ’30 ed è attiva, anche se sottotraccia, da decenni negli Usa e in Europa, segnatamente in Francia, dove economisti e sociologi come Serge Latouche – tenuto in alta considerazione da Grillo – parlano di “post-sviluppo” e addirittura di “uscita dall’economia”. Secondo queste tesi, la crescita economica a tutti i costi provocherebbe uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e, in prospettiva, un’alterazione dell’equilibrio ecologico del pianeta. Ancora, oltre un certo limite di crescita la qualità della vita si abbasserebbe: troppo sviluppo risulterebbe controproducente.
Quando Beppe Grillo auspica una “decrescita felice”, gli si risponde generalmente che l’Italia è già in decrescita e che il fenomeno non risulta per nulla felice. In realtà, la decrescita di cui parla Grillo non corrisponde alla recessione economica. Si tratta di una scuola di pensiero sui “limiti dello sviluppo” che ha le sue origini negli anni ’30 ed è attiva, anche se sottotraccia, da decenni negli Usa e in Europa, segnatamente in Francia, dove economisti e sociologi come Serge Latouche – tenuto in alta considerazione da Grillo – parlano di “post-sviluppo” e addirittura di “uscita dall’economia”. Secondo queste tesi, la crescita economica a tutti i costi provocherebbe uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e, in prospettiva, un’alterazione dell’equilibrio ecologico del pianeta. Ancora, oltre un certo limite di crescita la qualità della vita si abbasserebbe: troppo sviluppo risulterebbe controproducente.
 Simili posizioni sono difese, fra gli altri, da autori come Maurizio Pallante nel suo libro “La decrescita felice” (da cui Grillo ha tratto il suo slogan) e dal succitato Latouche in vari testi, far cui un “Piccolo trattato della decrescita serena”.
Simili posizioni sono difese, fra gli altri, da autori come Maurizio Pallante nel suo libro “La decrescita felice” (da cui Grillo ha tratto il suo slogan) e dal succitato Latouche in vari testi, far cui un “Piccolo trattato della decrescita serena”.
Il dibattito in Francia su queste idee – sostenute da parte dei Verdi, della sinistra radicale e dell’estrema destra – è in corso da anni e ha toccato vette surreali, come quando il deputato Verde Yves Cochet ha proposto nel 2009 all’Assemblea nazionale francese di abbassare i sussidi alle famiglie dal terzo figlio in poi, perché un neonato ha “un costo ecologico paragonabile a 620 tragitti Parigi-New York”.
Il saggista francese Pierre Clermont ha analizzato, in un testo del 2004, quali dovrebbero essere le condizioni necessarie per realizzare una politica di decrescita. Secondo Clermont, l’arresto della crescita non potrebbe che essere imposto dallo Stato, dato che le imprese, in un’economia liberale basata sulla competizione, sono costrette a cercare di aumentare la loro produttività con l’innovazione e l’aumento del volume della produzione, per rimanere sul mercato. Per fermare questa situazione, la burocrazia statale dovrebbe imporre quote massime di produzione a ogni azienda, come si fa già in agricoltura. L’equilibrio economico non sarebbe più assicurato dal mercato e dal sistema dei prezzi, bensì dalle valutazioni delle necessità di domanda operate dalle amministrazioni statali, il che sarebbe molto difficile ma non impossibile, grazie ai moderni strumenti informatici. Ciò significherebbe una certa sicurezza per le imprese, ma affievolirebbe l’impulso all’innovazione, non più necessaria per battere una concorrenza ormai estinta. Inoltre, la fine della competizione comporterebbe anche l’arresto della pubblicità, perché le aziende non avrebbero più necessità di promuovere i loro prodotti per vendere più dei concorrenti. E la fine della pubblicità privata vorrebbe dire l’esaurimento delle fonti di finanziamento dei mass media (il movimento a favore della decrescita è stretto alleato delle organizzazioni “antipub”, che vedono la pubblicità commerciale come uno strumento da eliminare). Alla fine, sarebbe solo il potere pubblico a determinare quali media finanziare, quali eventi sovvenzionare, quali spettacoli sponsorizzare.
Secondo l’analisi di Clermont, un simile sistema potrebbe anche funzionare; si tratterebbe di un’economia stazionaria, ma con gli alti livelli di benessere dei Paesi occidentali. Il prezzo da pagare sarebbe però alto, perché in un regime in cui le imprese sono formalmente private ma di fatto “socializzate”, la proprietà privata – fondamento giuridico della libertà individuale – diventa una finzione. E senza proprietà privata non esiste autonomia dell’individuo rispetto al potere statale. Tutto ciò sarebbe realizzabile senza coercizione, senza apparati repressivi e anzi permettendo ai cittadini di lasciarsi alle spalle le angosce dell’economia libera: la competizione, la disuguaglianza, l’ingiustizia sociale.
Il risultato sarebbe un’economia stagnante ordinata da una sorta di totalitarismo consensuale o, per dirla con Clermont, un “comunismo confortevole”. La creatività, l’innovazione, la curiosità intellettuale e, in ultima analisi, la libertà, sarebbero le principali perdenti in un simile stato di cose. Infine, la classe politica ordinatrice della decrescita, in assenza di una società civile ed economica che abbia gli strumenti per esercitare una sua autonomia e una critica nei confronti del potere, diventerebbe autistica, anche con le migliori intenzioni. Scrive Clermont che “essendosi affrancata dal controllo della società, la classe politica la domina unilateralmente. I suoi membri non obbediscono che alle regole che si scrivono da soli: quelle di una confraternita o di una casta, funzionante come un corpo organizzato e gerarchizzato, che recluta i suoi membri per cooptazione, che prende le sue decisioni in maniera sovrana, senza riferirne a chicchessia – detto altrimenti, che funziona come un gruppo privato”. Non è forse questa una precisa definizione di ciò che Beppe Grillo dichiara di voler combattere?








