
“Quella lucentezza dapprima lo avvolse, poi lo nascose. Lo coprì con una piega del suo misterioso abito che, senza cucitura o legatura, velava l’Egitto per mille leghe. Il deserto lo prese. L’Egitto lo aveva catturato nella sua rete. Era perduto”.
Così come tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi anni del Novecento spopolava non solo il japonisme, ma anche, più in generale, la fascinazione per l’esotico mediata dagli artisti e dagli scrittori europei, soprattutto francesi, negli ultimi anni tra gli editori indipendenti italiani c’è stato un revival di quel genere che è stato definito Aegyptian gothic.
Se AbEditore, solo l’anno scorso, ha deciso di puntare sul suggestivo “Il gioiello delle sette stelle” di Bram Stoker, provvisto peraltro del primo finale alternativo “fanservice” della storia, e chi vi scrive, più modestamente, ha tradotto e pubblicato per la prima volta la plaquette sensual-orrorifica di Marinetti “La Mummia che sanguinava”, curata da Guido Pautasso, Edizioni Hypnos, nel 2017, ha optato per “Discesa in Egitto” di Algernon Blackwood, uno dei padri indiscussi del weird, autore del “miglior racconto nella storia della letteratura del soprannaturale” secondo… nientepopodimeno che H. P. Lovecraft.
Come spesso avviene per i racconti proto-weird (si pensi anche a quelli del genere “haunted house” di Bulwer-Lytton e di Charlotte Riddell) la trama di “Discesa in Egitto” è, invero, piuttosto scarna: il protagonista si reca in un tranquillo albergo egiziano per una terapia e vi incontra una coppia di eclettici archeologi, inglesi come lui, dediti a misteriose ricerche su steli e geroglifici e a non meglio precisati studi storici ed esoterici. Segue un visionario accesso di “mal d’Africa”, una “discesa” – non solo geografica – nei meandri dell’Egitto profondo, simile a quella di Orfeo nell’Ade, da cui il protagonista riemergerà sano e salvo, ma inesorabilmente cambiato. Non a caso i nostri nonni, detentori di una saggezza popolare un po’ conservatrice, per mandare al diavolo qualcuno, gli dicevano “ma va’ in Egitto”!
E se il “canto delle Sirene” che incanta il protagonista è una sorta di inno antico musicato da uno dei due archeologi, che gli farà vivere una sorta di delirio metempsicotico, ciò che della sua vicenda affascina il lettore contemporaneo – oltre all’atmosfera e ai paesaggi da sogno (o da incubo?) che non hanno mai smesso di ammaliare gli europei intenti a “cercare un altro Egitto”, da d’Annunzio a Salgari a Hugo Pratt e Battiato, da Agatha Christie alla Fausta Cialente di “Ballata levantina” – è il bizzarro poutpourri di scientismo e culto solare di Amon-Ra, che, pur risentendo di un certo spirito ottocentesco un po’ datato (“Magico, la parola che hai usato”, dice Moleson al protagonista dopo trenta pagine di vividissime elucubrazioni paganeggianti, “non ha alcun significato per me.
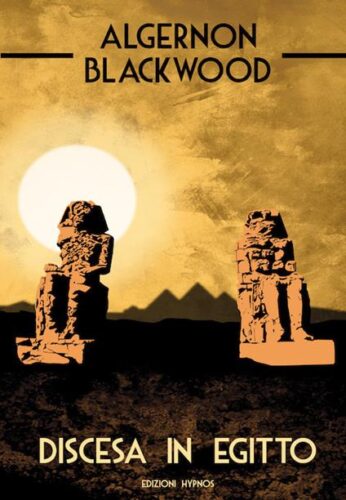
Se esiste una cosa del genere è puramente scientifica, una conoscenza non ancora scoperta o dimenticata”), non scade mai nel pacchiano, al contrario mantenendo intatta quell’allure e quel potere di “smisurata preghiera” – pagana, in questo caso – che appartiene solo alla grande letteratura, di “consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità”.








