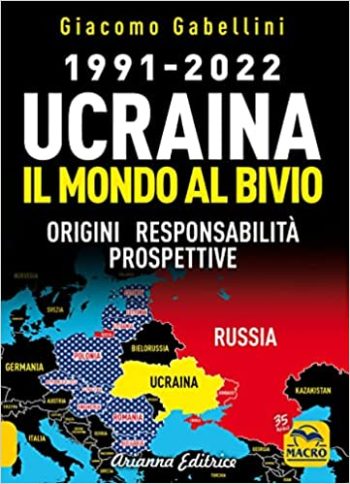
Il volume può essere acquistato qui.
Per molti anni, l’Ucraina è riuscita a conciliare il consolidamento delle relazioni con lo schieramento euro-atlantico con la preservazione di rapporti collaborativi con la Russia senza incorrere in particolari contraccolpi, ma anzi conseguendo risultati di indubbio rilievo. Il presidente Leonid Kučma e i suoi collaboratori erano pienamente convinti che le aspirazioni di prosperità coltivate da un Paese impoverito ma dotato delle caratteristiche e del peso geopolitico dell’Ucraina potessero essere appagate soltanto attraverso il mantenimento di posizione di equilibrio tra i due colossi, che consentisse a Kiev di scremare il massimo vantaggio possibile dall’alternanza di aperture e concessioni verso entrambi i fonti.
Sul piano pratico, il graduale consolidamento delle relazioni con gli Stati Uniti portò alla sottoscrizione di un memorandum per la cooperazione militare con il Pentagono, che aveva concorso a rendere l’Ucraina il terzo beneficiario delle sovvenzioni statunitensi (dopo Israele ed Egitto). Allo stesso modo, la partecipazione dell’esercito ucraino alle operazioni militari in Bosnia-Erzegovina e Kosovo aveva garantito a Kiev l’accesso ai finanziamenti del Fmi e della Banca Mondiale. Successivamente, la mobilitazione generale a favore degli Stati Uniti verificatasi all’indomani degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 aveva creato le condizioni feconde per l’instaurazione un clima di collaborazione culminato con il coinvolgimento della stessa Federazione Russa. Intravedendo nell’adesione limitata alla “crociata” contro terrorismo islamico proclamata da George W. Bush la possibilità di legittimare la durissima campagna militare scatenata anni prima in Cecenia, il Cremlino si adoperò attivamente per agevolare il dispiegamento militare in Afghanistan, mettendo le proprie basi militari a dispo- sizione per il transito di mezzi e rifornimenti.
Di questa provvisoria intesa tra Mosca e Washington, apparentemente cementata dal fruttuoso vertice di Pratica di Mare del maggio 2002 (in occasione del quale era stato istituito un partenariato tra Russia e Nato), si avvantaggiò naturalmente anche l’Ucraina, che non incontrò ostacoli di rilievo nel suo processo di avvicinamento allo schieramento euro-atlantico. Anche nel momento in cui emersero prove schiaccianti in merito alla fornitura del sistema radar Kolčuga – proibita dalle risoluzioni Onu – all’Iraq di Saddam Hussein da parte di Kiev, l’Ucraina non subì ri- torsioni. L’unica eccezione fu una momentanea sospensione dei finanziamenti Usa, immediatamente revocata nel momento in cui i massimi rappresentanti del governo ucraino manifestarono l’intenzione di entrare a far parte della Nato. Una volontà enunciata non soltanto a livello vocale, ma messa per iscritto con apposito decreto firmato da Kučma e quindi confermata ufficialmente nel maggio 2002 tramite relativa deliberazione del Consiglio di sicurezza ucraino presieduto da Yevhen Marčuk. La procedura di adesione scattò il 22 settembre con la sottoscrizione di un piano d’azione che identificava come obiettivo prioritario della politica ucraina l’integrazione nelle strutture di sicurezza euro-atlantiche. Un punto fondamentale, debitamente sussunto nel Libro Bianco della Difesa del 2004 dietro esplicita indicazione dell’allora mi- nistro della Difesa Yehven Marčuk, sotto la cui egida l’Ucraina inviò nell’Iraq occupato un contingente di 1.650 soldati e dispiegandone altrettanti in ben 11 missioni internazionali, tra cui Georgia, Kosovo e Liberia. La linea politica di avvicinamento allo schieramento euro-atlantico portata avanti da Kučma e Marčuk era naturalmente condivisa anche dal suo primo ministro Viktor Janukovyč, che nel maggio 2004 comparve in una conferenza stampa indetta a Bruxelles dall’Alleanza Atlantica per esprimere l’auspicio che «sia per noi possibile procedere con lo sviluppo dei nostri compiti specifici, inseriti nel quadro delle relazioni tra Ucraina e Nato».
Per anni, Janukovyč appoggiò senza obiezioni la “dottrina-Marčuk”, finché non cominciarono ad emergere chiari segnali di dissenso nei confronti della svolta “occidentalista” provenienti dalla frangia oli- garchica titolare di interessi direttamente riconducibili all’industria pesante dell’Ucraina orientale. Il nocciolo duro della contestazione era costituito dal cosiddetto “club di Donec’k”, una potente compagine imprenditoriale facente essenzialmente capo a imprenditori come Rinat Akhmetov e Dmytro Firtaš e fortemente dipendente dagli approvvigionamenti energetici russi. Governare senza il consenso di questi ricchissimi industriali dell’est era pressoché impossibile, perché le loro fabbriche e miniere situate nelle periferie di città come Donec’k, Luhans’k, Dnipropetrovs’k e Kharkiv producevano qualcosa come il 20% del Pil e il 25% delle esportazioni ucraine. Nel solo Donbass si trovano ragguardevolissimi giacimenti di carbone, ferro, titanio, manganese, mercurio, nichel, cobalto, uranio, terre rare di vario genere e idrocarburi non convenzionali (sia petrolio che gas di scisto). È in quest’area «che ha ciclicamente patito e/o messo a frutto la vicinanza con la Russia e gli scambi lungo 1.560 km di confine, che questi perso- naggi si sono affermati e hanno costruito le loro straordinarie fortune. Lì, quindi, hanno un radicamento profondo, fatto di legami economici, vecchi complicità anche transnazionali, nuovi interessi, conoscenza del territorio, investimenti, attività, capacità di generare posti di lavoro e produrre ricchezza, che pesa assai più del volatile consenso politico»2.
Il malumore suscitato dal rapido scivolamento dell’Ucraina verso lo schieramento euro-atlantista rappresentava il diretto contraccolpo sul versante interno degli sconvolgimenti geopolitici intercorsi quantomeno a partire dal 2003, anno in cui la Russia ricorse – di concerto con Cina e Francia – al diritto di veto per bloccare la risoluzione attraverso cui gli Usa richiedevano il via libera del Consiglio di Sicurezza dell’Onu per attaccare l’Iraq. Una presa di posizione tassativa, che coniugandosi con la ricostituzione dell’autorità nazionale, la sconfitta del terrorismo ceceno, il drastico ridimensionamento dello strapotere degli oligarchi e il trasferimento delle industrie strategiche sotto il diretto controllo dello Stato aveva concorso a restituire prestigio e credibilità internazionale alla Federazione Russa. In linea con il suo approccio pragmatico e pianificatore, Putin si era dedicato alla ricostruzione del Paese devastato dalla dissennata gestione el’ciniana, premurandosi tuttavia di ostacolare il meno possibile i progetti patrocinati dagli Stati Uniti e dai loro alleati/sottoposti europei. Secondo l’eccentrico intellettuale russo Eduard Limonov, il Putin di quegli anni «fu pessimo, perché impegnato a gestire il suo complesso d’inferiorità del piccolo ufficiale del Kgb. Gli piaceva la compagnia dei leader internazionali, Bush, Schröder, Berlusconi». Una compagnia che avrà indubbiamente gradito, ma di cui avvertiva la necessità per evitare l’insorgere di screzi tra l’ancora claudicante Federazione Russa e un fronte occidentale che, tra ammiccamenti e strette di mano, continuava ad assumere iniziative apertamente contrastanti con gli interessi strategici del Cremlino. Al punto da indurre Putin a ritenere che l’Occidente intendesse impedire alla Russia di riacquisire lo status di grande potenza.
Alla militarizzazione del corridoio eurasiatico, alla strumentalizzazione dei movimenti jihadisti operanti nel Caucaso, alla conclamata promozione di operazioni di “regime change” in Georgia e Bielorussia4, e alla realizzazione di gasdotti e oleodotti concepiti appositamente per neutralizzare per quanto possibile la leva energetica russa era infatti andato ad aggiungersi il ritiro (dicembre 2001) dall’Anti-Ballistic Missile Treaty (Abm), l’accordo firmato nel 1972 a Mosca da Leonid Brežnev e Richard Nixon. Un trattato rivelatosi particolarmente funzionale alla preservazione della pace, perché impegnava entrambi i contraenti a mantenere una sola base anti-missilistica a protezione della principale città cosi da lasciare il resto del proprio territorio nazionale esposto alle rappresaglie dell’altro nel caso in cui uno dei due avesse lanciato il primo colpo. Nonostante assicurasse una forma particolarmente efficace di deterrenza, il principio della reciproca vulnerabilità risultava incompatibile con la visione oltranzista elaborata dagli esponenti neoconservatori che manovravano l’amministrazione Bush. Il cui obiettivo, enunciato all’interno di un documento grondante del più spinto militarismo, consisteva nel rendere il Paese invulnerabile a qualsiasi attacco straniero e nel dotarlo di un arsenale bellico incommensurabilmente più potente rispetto a quello di qualsiasi altro Stato o coalizione di Stati. A tale scopo, l’amministrazione Bush aveva richiesto e ottenuto dal Congresso un netto incremento del bilancio del Pentagono, e denunciato quindi il Trattato Abm per avviare la sperimentazione di un sistema di difesa anti-missile modellato sotto alcuni aspetti al progetto elaborato un ventennio prima dall’amministrazione Reagan. Bush chiarì immediatamente che la decisione non avrebbe riportato le lancette ai tempi della Guerra Fredda, e soprattutto che non andava interpretata come una mossa offensiva nei confronti della Russia anche se apriva automaticamente il varco alla costruzione di una grande rete di difese anti-missilistiche in tutta l’Europa orientale.
Vale a dire la stessa macroregione del “vecchio continente” che il 29 marzo 2004, quando Putin aveva appena conquistato il suo secondo mandato (tempismo straordinario), sarebbe stata interessata dal più ampio allargamento ad est mai attuato dalla Nato. In quel giorno fu infatti formalizzata l’adesione in blocco di Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria e Romania.
L’ovvio risultato fu quello di insinuare nell’apparato dirigenziale della Federazione Russa un profonda sensazione di accerchiamento, stimolata anche dalle implicazioni strategico-militari del processo di espansione della Nato verso est: moltiplicazione delle missioni di
pattugliamento nelle acque del Mar Baltico e nel Mar Nero, intensificazione delle attività di sorveglianza e ascolto in prossimità dei centri del comando strategico russo di Smolensk e San Pietroburgo da parte degli aerei Awacs, spostamento massiccio di basi militari ed equipaggiamento bellico dalla Germania verso le Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Bulgaria, rafforzamento dei presidi sui punti d’accesso ai mari strategici della Russia.
L’irrequietudine russa andò montando ulteriormente quando, nel maggio 2004, l’Unione Europea annunciò l’arruolamento tra le proprie fila di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Let- tonia, Estonia, Lituania, Slovenia, Cipro e Malta. Si trattava di un evento meno traumatico rispetto a quello verificatosi appena due mesi prima (espansione della Nato), ma comunque destinato a rafforzare la presa economica occidentale sullo spazio ex-sovietico e soprattutto funzionale al consolidamento dell’influenza statunitense sul “vecchio continente” per effetto della complementarietà tra Unione Europea e Nato evidenziata da Brzezinski già nel 1997. Una prova tangibile di ciò la si ottenne nell’aprile di quello stesso anno, in seguito all’adesione dell’Ucraina allo Spazio Economico Unificato, di cui erano già entrati a far parte Federazione Russa, Bielorussia e Kazakistan. Il progetto era stato lanciato dal Cremlino nel settembre precedente in risposta all’esigenza di armonizzare le relazioni commerciali (con particolare riferimento all’energia) all’interno dello spazio ex sovietico, e aveva riscosso l’appoggio del governo di Kiev che vi intravedeva l’opportunità di incrementare notevolmente l’interscambio con tutti gli altri Paesi coinvolti. Lo Spazio Economico Unificato, dichiarò il primo ministro ucraino Viktor Jankukovyč in aperta polemica nei confronti della recente decisione di Bruxelles di non accogliere il suo Paese nella struttura comunitaria, «promuove lo sviluppo economico dell’Ucraina e ne accresce la competitività sui mercati mondiali, garantendo un accesso all’Unione Europea sotto nuove condizioni». Ma contrariamente alle previsioni formulate da Jankukovyč, l’adesione allo Spazio Economico Unificato rappresentava un ostacolo alle aspirazioni ucraine di integrazione nell’Unione Europea ed anche nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, specificarono all’unisono l’ambasciatore statunitense in Ucraina John Herbst e la vicedirettrice del Fmi Anne Krüger. Eppure, l’Ucraina aveva varato un sostanziale allineamento alle direttive statunitensi, con l’avvicinamento dell’Ucraina alla Nato, la mancata adesione alla Csi e al Csto e l’ingresso in un organismo chiaramente ispirato alle logiche di contenimento della Russia come Guuam.
Evidentemente, per l’Ucraina i margini di manovra si erano drasticamente ristretti, per effetto diretto delle manovre di espansione e “distruzione creatrice” portate avanti simultaneamente dall’Occidente nei teatri balcanico, caucasico, centroasiatico, baltico ed eusino.
Così, quando, alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2004, il presidente Kučma annunciò il ritiro dalla vita politica e propone come proprio successore il primo ministro in carica Jankukovyč, «diventa ben chiaro a tutti gli addetti ai lavori che si tratta di una partita decisiva per il futuro dell’Ucraina, che non potrà più restare sospesa tra Occidente e Russia» (Colonna 2014, pp. 93, 94). Conformemente al medesimo schema operativo sperimentato in Jugoslavia e Georgia, la poderosa macchina finanziario-mediatico-organizzativa imperniata sul National Endowment for Democracy si mise prontamente in moto a favore di Juščenko, candidatosi con il sostegno di Juljia Tymošenko. Per tramite delle Ong Freedom House, Konrad Adenauer Foundation, Albert Einstein Institute, Carnegie Endowment for International Peace e Open Society, il Ned favorì il rafforzamento sul territorio ucraino di movimenti quali Nasha Ukraina (“Nostra Ucrai- na”), Pora (“È ora!”) e Chysta Ukraina (“Pulisci l’Ucraina”). Grazie alle sovvenzioni e alla visibilità mediatica garantiti dal Ned, queste formazioni centrarono il doppio obiettivo di coinvolgere gli strati più giovani delle popolazioni urbane e mobilitare un vero e proprio esercito di osservatori internazionali. Nell’arco di poche settimane, giunsero in Ucraina migliaia di volontari inquadrati nell’Ukrainian Congress Committee of America, organizzazione smaccatamente russofoba composta da cittadini Usa di origini ucraine che nei decenni passati aveva annoverato tra i suoi appartenenti i reduci dell’Oun (Stepan Bandera); nell’European Network of Electoral Monitoring Organizations, che raggruppava attivisti appartenenti a Ong dell’Eu- ropa orientale finanziate per vie traverse dagli Usa e dalla Gran Bretagna; nella Us-Ukraine Foundation, fondata nel 1991 da Kateryna Čumačenko, consorte di Viktor Juščenko ed ex dipendente del Dipartimento di Stato sospettata di intrattenere legami con Wall Street e la Cia. Simultaneamente, nell’arco di poche settimane comparvero in piazza Majdan, a Kiev, per manifestare il proprio appoggio ai dimostranti Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, il senatore John McCain, Lech Wałeşa, il responsabile della politica estera europea Javier Solana, il presidente polacco Aleksander Kwaśnewski e il suo omologo lituano Valdas Adamkus…








