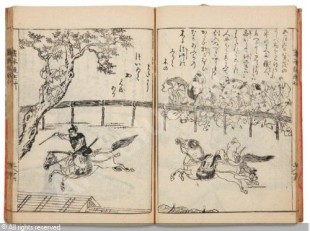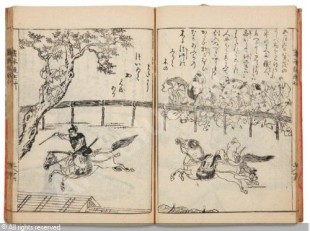
Gli zuihitsu (随筆, letteralmente: “seguire il pennello” ) sono degli scritti di tipo miscellaneo, spesso afferenti alla cosiddetta “letteratura buddhista”, che rappresentano uno dei momenti più alti nella storia della letteratura giapponese. In questo filone si inseriscono opere celebri quali il Makura no sōshi (枕草子, “Appunti del guanciale”, ca. 1002) di Sei Shōnagon, con la sua colta e sofisticata osservazione della vita di Corte, e l’Hōjōki (方丈記, “Ricordi di un eremo”, 1212) di Kamo no Chōmei – citato pure nell’ultimo film di Kurosawa Akira: Madadayo – Il compleanno (まあだだよ, 1993) – che presenta delle toccanti riflessioni sulla esistenza umana, ovvero sulla sua caducità, tema fondamentale nella letteratura classica del Sol Levante. A questi due autentici capolavori, si affianca forse il più celebre tra gli zuihistu, lo Tsurezuregusa (徒然草, “Ore d’ozio”[1], 1330-31). Una opera di rara acutezza intellettuale che gode tuttora di notevole successo, sia all’estero, dove è stata tradotta in numerose lingue, che in madrepatria. Infatti, ancora oggi questo testo viene letto nelle scuole in Giappone come esempio più significativo della tradizione classica. Esso si compone di 243 parti: riflessioni personali, aforismi, appunti e ricordi si alternano in modo spontaneo.
Il suo autore è Kenkō Hōshi (nato come Yoshida Kaneyoshi, ca. 1283 circa – 1352). Estraniatosi dalle dinamiche della Corte, egli si immerge nella Natura, la quale è lo specchio che riflette la società giapponese del Periodo Kamakura (1185 – 1333). Fattosi monaco e cambiato il proprio nome, quelle di Kenkō (essendo conosciuto con due nomi, preferiamo riferirci a lui in questo modo) non sono affatto le elucubrazioni di un solitario pensatore, bensì perspicaci osservazioni su tutti gli aspetti della esistenza e della realtà circostante: il passato, la società mondana, ma anche la posizione dell’uomo nell’universo, perciò l’essenza stessa della vita. Il “beato ozio” diventa allora un momento di ebbrezza conoscitiva che permette di acuire il proprio sguardo e di spingerlo verso la contemplazione, per poi passare alla stesura di queste brevi, penetranti, a volte persino ironiche
quisquilie, mirabili nella loro semplicità e bellezza. Il senso di questa straordinaria raccolta di “divagazioni” sta tutto nel suo incipit, dove si capisce come per l’autore il Buddhismo sia essenzialmente una assoluta e totale contemplazione del mondo: “Nel vuoto di ore oziose prendo la pietra da inchiostro e tutto il giorno mi perdo ad annotare a caso le sciocchezze che mi passano per la mente, e un’ebbrezza misteriosa mi assale”.Kenkō scrisse fuori dalla Corte e dai templi Zen, descrivendo un mondo in parte diverso da quello del
Makura no sōshi e dell’
Hōjōki, poiché l’autore si allontana sia nell’anima, sia nella scrittura da qualsiasi cliché prestabilito; la “fuga” di Kenkō dalla vita è alla fine totale, ma in essa non si palesa mai un senso di sconfitta, né di rassegnazione, rendendola un modello di quella che dovrebbe essere la dignità di uno scrittore, regalandoci una lezione che oggi più che mai è stata dimenticata: “[…] se non si dice ciò che ci urge in petto, si scoppia, io continuerò ad affidarmi al mio pennello” (19).L’autore annota, come detto, ogni quisquilia senza alcun motivo, solo perché gli passa per la mente, rendendosi così conto della relatività dei valori della vita. La varietà degli argomenti trattati è praticamente unica per la sua epoca. Trattasi di una specie di zibaldone che riunisce i pensieri di un uomo che guarda alla esistenza attraverso i propri occhi, ma che utilizza l’animo per giudicare, più che il cervello. Dissertazioni che si presentano al lettore senza alcun collegamento diretto tra di esse, ove traspare anche un fondo di negatività spesso presente nelle riflessioni di Kenkō, superbamente sintetizzato da questo semplice, quanto vero, concetto: “il mondo è pieno di menzogne” (73).Nello
Tsurezuregusa la vita è mostrata come una sorta di universo pulviscolare composto da
yoshinashigoto (“cose futili”), che fa di questo testo, come afferma il noto studioso Katō Shūichi, un “
renga[2] in prosa”, ovvero una catena di pensieri, scollegati per tema, ma non certo nel modo di esprimerli da parte di Kenkō: alla fine la frammentarietà della sua riflessione è solo strutturale, ma non intellettuale.
Chi poco conosce il Giappone medievale, forse penserà che gli zuihitsu rappresentino una specie di “elogio della solitudine”, ma così non è. Opere come lo Tsurezuregusa, che incarnano l’aspetto più umano e meno mistico della filosofia e religione buddhista, ci consentono di capire che solo lontano dal chiasso e dalle ingannevoli bellezze della società, l’individuo può utilizzare il proprio IO per comprendere finalmente il mondo, il quale si palesa agli occhi di chi ha imparato a osservarlo attentamente assai poco attraente.
@barbadilloit
[1] Meglio conosciuto come Momenti d’ozio, in questa edizione si è optato per mantenere il titolo utilizzato dal noto yamatologo Marcello Muccioli nelle diverse edizioni della sua traduzione, la prima risalente al 1965. Il testo qui preso in esame è a cura di Adriana Boscaro, ripreso da un lavoro iniziale di Luisa Randazzo.
[2] “Poesia a catena”, un genere letterario che si sviluppò in Giappone a partire dal XII secolo, dapprima come passatempo, poi come vera forma d’arte che prevedeva la collaborazione nella composizione di più persone allo stesso tempo.
Riccardo Rosati
Riccardo Rosati su Barbadillo.it
Visualizzazioni: 0