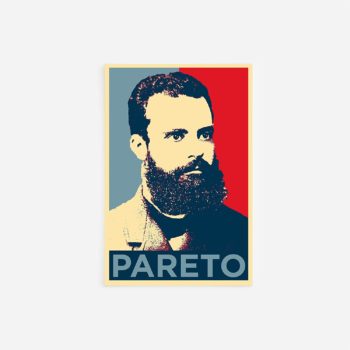
Vilfredo Pareto (1848-1923), uno dei maggiori sociologhi, era un reazionario nemico degli ideali della Rivoluzione francese e del Capitale di Marx, “libro santo del socialismo” che aveva “in grado eminente i caratteri che si notano in tutti i libri santi, ossia l’indeterminatezza e l’oscurità”. Nemico della filosofia di Auguste Comte, Pareto si ispirava al realismo politico, degno discepolo, in questo, ddi Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini. Si interessava di economia e di sociologia analizzando la società, gli aggregati umani e le loro dinamiche. I suoi testi sono classici del pensiero sociologico e del pensiero politico. Da I sistemi socialisti (1902) a Il mito virtuista e la letteratura immorale (1911), alla fine il Trattato di sociologia generale (1917). L’ultimo lavoro di Pareto fu Trasformazione della democrazia (1921), libro che riunisce quattro saggi apparsi l’anno prima della sua morte sulla “Rivista di Milano”. Si tratta di un atto di accusa contro le degenerazioni della democrazia, la quale non sarebbe un sistema di libertà, come proclamato dai suoi fautori. Questo libro è un libro di particolare attualità che illustra come degenerazione e decadenza fossero insite nel sistema politico democratico tanto che, dal 1921, anno di pubblicazione del volume, le condizioni delle società democratiche sono pesantemente peggiorate confermando l’analisi di Pareto.
Per analizzare la democrazia, Pareto riprende i temi centrali delle teorie esposte nelle opere maggiori, come quello dell’equilibrio nella società, che prevede che in ogni società si affrontano due forze differenti: una centripeta che spinge alla concentrazione del potere centrale e l’altra centrifuga che spinge verso la divisione. Questo confronto crea un moto oscillatorio nel quale, quando prevale la forza centrifuga, il potere centrale tende a indebolirsi e la “sovranità del potere” tende a perder forza. Così si riproduce una sorta di feudalità della quale sono protagonisti politici e sindacati, disposti a tutto – afferma Pareto – pur di conseguire vantaggi personali.
Il biennio rosso
Dietro questa analisi, in pieno 1921, c’era la crisi del “biennio rosso” con lo scontro fra Fascismo e Socialismo, con l’Italia in condizioni sociali e politiche molto precarie. Così avveniva una “trasformazione della democrazia” attraverso la “plutocrazia demagogica”: un ceto politico che vede uniti ricchi speculatori e lavoratori in buone condizioni economiche. Insieme rappresentano la degenerazione della democrazia. Pareto accusa quindi la plutocrazia e i meccanismi di corruzione della borghesia che si organizzano per conquistare il potere nel sistema democratico. Questo è un atto di accusa: dietro i buoni intenti sbandierati, le oligarchie che gestiscono il consenso popolare governano secondo i propri interessi per mezzo della democrazia. Il governo parlamentare tende a “privatizzare” lo Stato, a creare lobby di potere che soddisfino i propri appetiti e che garantiscano il potere assoluto.
Precursore del fascismo
Per la sua concezione élitista, Pareto fu considerato uno dei precursori del Fascismo. Benito Mussolini lo citava spesso. Conobbe il grande sociologo in Svizzera dove seguì le sue lezioni all’Università e lesse le sue opere maggiori. Il Fascismo, nella lettura paretiana, fu un elemento ottimistico che mostrava come le classi medie avevano ancora la forza di reagire, di esprimere le proprie posizioni di lotta contro il socialismo minaccioso. La sua scelta era per la “terza via”, condannando la democrazia, l’umanitarismo, il pacifismo, soprattutto la plutocrazia demagogica pronta a colpire la società più per la propria visione del mondo, piuttosto che incarnare una categoria economica. Definito “il Carlo Marx del Fascismo” da Fani Ciotti, che per primo lanciò questa definizione su Gerarchia, mensile diretto da Benito Mussolini, di certo Pareto rientrò fra i precursori. Forse è esagerata la definizione di Fani Ciotti ma è indicativa perché è sul piano delle idee che il sociologo e il Fascismo collimano.
* Trasformazione della democrazia, di Vilfredo Pareto (Pagine ed., pagg. 99; euro 15,00). Il volume è acquistabile presso la Libreria Europa di Roma










Il marchese Pareto fu certo un liberal-conservatore. Fu sedotto dalla personalità di Mussolini, ma ciò non fece di lui un fascista. Peraltro, già morì nel 1923.
E meno male che l’ho spiegato bene, anche se non sempre serve… Pareto non fu un fascista, fu di più: un PRECURSORE DEL FASCISMO. E’ sul piano delle idee che il sociologo e il Fascismo collimano, non sull’adesione. Anche se a caldo, per quei due tre anni in cui l’inizio del fascismo coincise con gli ultimi anni di vita di Pareto, il famoso sociologo approvò quasi tutto del movimento mussoliniano (signor Guidobono, legga di Luigi Montini il volume “Vilfredo Pareto e il fascismo”, Volpe ed. 1974).
E Gaetano Mosca, sulle stesse posizioni di Pareto, firmò il Manifesto antifascista di Croce e sempre si mantenne lontano dal regime fino alla morte negli anni ’40….
Il fascismo pescava a destra e sinistra, come confessò poi Mussolini stesso nella famosa voce Fascismo dell’Enciclopedia Italiana. Pareto e Mosca, teorici delle élites, erano certamente di destra (così come lo erano in Germania Jünger ed altri della cosiddetta Rivoluzione Conservatrice), ma lontanissimi dal Fascismo Sansepolcrista… Del resto anche Giolitti diede la fiducia al Governo Mussolini nel ’22 e sostenne poi la Legge Acerbo (premio di maggioranza)….Ma non per questo venne meno la sua adesione al liberalismo… Una cosa è l’ideologia, un’altra la contingenza politica, allora ed ancora oggi…
Mussolini si ‘servì’ anche di Pareto per ottenere il consenso della destra nel Paese (affatto scontato). Pareto venne retribuito dal medesimo con la nomina a Senatore, che per ‘ragioni burocratiche’ non si concretizzò..