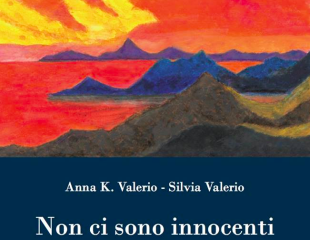
“Il problema di cui occuparsi non dev’essere per noi quello della ripartizione della ricchezza, ma come subordinare la ricchezza alla vita, alla bellezza”.
Mi sembra questa l’effigie più appropriata a introdurre, volendo tentare di sublimarne il messaggio, questa valevole pubblicazione delle Edizioni di Ar frutto del lavoro delle sorelle Anna e Silvia Valerio (a proposito, caso raro e fortunato in letteratura: andando a memoria mi sovvengono solo i fratelli Grimm e le sorelle Brönte…). Se le due non hanno certo bisogno di presentazioni, va detto che dal loro scritto emerge quella consapevolezza, tellurica, della fragilità della vita dell’uomo sulla terra, che è genuino attributo della loro terra. Mi piace, perciò, ricordarne l’origine: quella gemma incastonata sui primi monti delle Alpi Orientali che è Gemona del Friuli.
Scritto in una prosa vivida, coinvolgente e dallo stile originale – ma che allo stesso tempo si rende degno, con un realismo dalle sfumature sciasciane, della migliore tradizione letteraria italica – Non ci sono innocenti è romanzo che si legge tutto d’un fiato e che ci trasporta senza posa in un sensazionale viaggio: groviglio di storie, colori, sapori e rimembranze – storiche, ideologiche, umane – di un’Italia che fu, ma che condivide, con l’attuale, il degrado materialistico, la frustrazione, l’immobilità politica.
Un bellissimo romanzo, innanzitutto: perché se non sapessimo che si tratta “della storia vera di Freda e Ventura”, e il lavoro delle Autrici esser stato il risultato di un accurato lavoro di documentazione storica, – non fosse il libro che il delizioso frutto di una loro lisergica propensione alla fantasia onirica applicata alla letteratura (o il giocoso tedio di un qualche dio solitario che le avesse malignamente ispirate…) – ci sapremmo, comunque, di fronte a un’opera di pregevole fattura, storia d’amore e libertà, passione e avventura, la cui energia narrativa, ricca di ispirazione etica ed estetica, ne renderebbe il messaggio estremamente vivo e attuale.
Siamo nella Padova del biennio ’67-’69, in un’Italia drogata dal boom economico e allo stesso tempo intrisa di ipocrisia borghese e cattolica, in un Veneto dove a stento sopravvive, alienata, l’identità contadina. Ci sono le fabbriche, il cieco progresso, il conseguente benessere materiale e i conseguenti tumori degli operai. C’è la guerra in Vietnam, l’onda rossa di contestazione che arriva dalla Francia e che confusamente si propaga tra le fabbriche e le università. C’è Woodstock, il rock, gli hippies, le mode d’oltreoceano che contagiano l’Europa di un improbabile pacifismo dai colori sgargianti. Ci sono i rossi (rabbiosa e sognante maggioranza) e ci sono i neri (castrati e frustrati da un inesaurito dopoguerra). Ci sono parole e proclami ideali che si perdono nel vento delle piazze, negli interminabili comizi, negli effimeri ciclostili ideologici; istanze sociali che si frantumano contro il muro dell’utilità e dell’interesse che domina il mondo. La confusione, tanta, sotto il cielo. L’occasione propizia…
Giulio, l’Autocrate (colui che ha in sé la propria misura), sembra un uomo catapultato nel tempo in cui vive da un’epoca lontana. Principi altri, alteri, guidano ogni sua azione… Precoce e fervido lettore di Nietzsche, studioso di Platone (sulla cui teoria dello stato impernia il suo modello politico-ideale) e dei classici greci e latini, egli si muove con consapevole disincanto nella realtà mondana. Il suo agire, in amore come in politica, è contraddistinto da un coraggio e una passione inusuali, una visione delle cose che trascende i luoghi comuni e i pregiudizi ideologici dell’ambiente politico da cui proviene. Anarchico “da destra” (e non “di destra”), come egli stesso si definisce in un dialogo con dei compagni in un’università occupata nella quale entra (con nonchalance, pur consapevole della sua nomea di fascista), è frainteso anche nel suo stesso ambiente. Una generosità incomprensibile in un mondo improntato all’interesse tanto che, persino Viviana – la sua più… stretta collaboratrice – non concepisce come lui abbia “un desiderio sincero di contagiare i rossi, di attrarli”, credendo “volesse solo servirsi di loro”.
Sono gli anni in cui Freda è folgorato dall’eresia nazi-maoista. Il cavalcare la tigre della contestazione, il motto nietzschiano secondo cui a ciò che cade bisogna pure dare una spinta, “la consapevolezza che si poteva sperare politicamente solo in un collasso totale di quello che gli ideologi rossi chiamavano sistema. Qualsiasi crepa era buona, era ossigeno. Inutile puntellare il muro che deve cadere. Meglio affrettarne la caduta: mettersi dall’altra parte, dalla parte di quelli che premono, incitarli, dominarli.”
In questi ragionamenti (che prevedono la raccolta di armi così come di uomini pronti ad usarle) sembra seguirlo inizialmente solo il Vecchio, il quale, memore delle sue conoscenze tecniche, si prodiga alla costruzione di quei giocattoli, fatti di timer, fili e circuiti che devono combaciare alla perfezione, atti a diffondere il verbo rivoluzionario, a dare una scossa ai lenti e impacciati borghesi. A tendere un agguato alla storia.
La progressiva entrata in scena di Giuseppe Cavallante (Ventura, Giovanni, “amico indimenticabile”, alla cui memoria il libro è dedicato) cangia i colori della storia fino a darle i toni di un fine e struggente romanticismo. Nella profondità del suo sguardo triste, nella sua opera culturale in cui impegna tutto se stesso e i suoi averi, emerge il disperato anelito a una rivoluzione impossibile quanto necessaria. D’altronde “era più facile credere ai miracoli che alla miseranda realtà’”.
Tra diserzioni, macchine che si rompono, imprevisti (ma anche un colpo pirotecnico al rettore di Padova riuscito decisamente bene) la storia entra progressivamente in possesso del Caso – bambinello capriccioso ma imparziale – fino a fermarsi appena prima del dicembre ’69, per perdersi in una rarefazione onirica finale.
L’epilogo, non scritto, è l’evento-voragine in cui andò inghiottito il sogno sessantottino, precipitando l’Italia negli Anni di Piombo. Sarebbe significato, per Freda e Ventura, l’inizio della clausura preventiva. Uno “scherzo di cattivo gusto”, come ebbe a definirlo l’Editore. La farsa dei processi avrebbe caratterizzato Piazza Fontana come la strage in cui, sorvolando sulla condanna ideologica ‘a posteriori’ del 2005, “non ci sono colpevoli”.
Capovolgendo questa prassi, ignava e democratica, il libro delle Valerio, con quella schietta veridicità che solo la forma del romanzo poteva trasmettere, ci offre una visione incomparabile a questa storia di cui si sapeva solo attraverso la lente distorta delle verità giornalistica e giudiziaria.