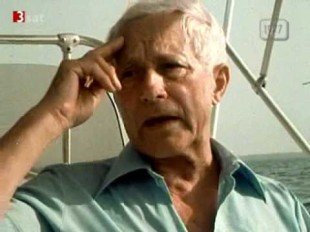
Ambiguità. A discapito degli stereotipi teutonici, che da sempre circondano l’altera figura di Ernst Jünger, è forse questa la parola che ne sonda il pensiero con più efficacia. Muschio sulla corteccia a nord, il sole che rende gialli i limoni a sud. Viaggi, trasposizioni fisiche e mentali, coraggio di guardare il mondo anche nel verso opposto. Il ginepro e la ruota dentata, la capanna e la ciminiera, il gelso e la polvere da sparo, botanica, l’entomologia e il microscopio che ne scruta i segnali senza tregua. Polarità che restituiscono, dopo l’ovvia impressione di contrapposizione, un sincretismo oltre-umano, traducibile in una pericolosa forma d’ordine superiore, quell’ultimo passo del viandante che permette di guadagnare il crinale. Sempre il penultimo, in realtà. Come Nietzsche/Zarathustra puoi osservare il mercato dabbasso. Oppure gli astri per aria più vicini, in silenziosi tramandamenti di scribi, inchiostro su carta d’iniziati, codici e segreti da tradurre in allusioni. Più precisamente, nel fatto che all’interno della perfezione celeste s’annidi l’incongruenza dell’umano mal trattenuto – Titano, Prometeo, Faust, alchimista, demiurgo in camice bianco, dittatore uncinato e tecnocrate banchiere, a discendere – cosicché nel siderale altare macrocosmico, tutto si rovescia nel piccolo, creato e creazione, specchiandosi tragicamente all’infinito. Specularità in absentia Dei. Si tratta di una piccola chiave, tenendo pur conto che il labirintico castello “abitato” dallo scrittore tedesco si chiude ermetico dietro mille serrature, fortezza di ferro, alveare di piombo, e poi all’improvviso stupore: casa sull’albero. Si svela dove e quando non te l’aspetti, caro lettore.
Ambiguità, da etimo, “intorno, da due o più parti, giro, tortuosità, che può prendersi in due o più sensi”. Difatti qui non s’intende il termine nell’accezione morale, piuttosto con uno stratagemma ludico, trova pertinenza nel cromatismo alternato di una scacchiera. Chissà se Heidegger, con una torre in mano, avrebbe acconsentito a dire Epica del gestell. Ci sono le sagome aristocratiche e cavalleresche perfettamente intagliate nel legno, poi le masse di pedoni rese uniformi dai dettami totalitari omologanti, c’è il campo di battaglia coi vessilli contrapposti, eppure… concentrazione e studio nel duello, strategia e intuito, si manifestano solo attraverso una simulazione. La vita è così rifatta, dall’uomo, entro i confini di una wunderkammer artificiosa. Si gioca contro la scacchiera, non contro il bianco o il nero. Partita difficile, tanto che il rischio per il commentatore è quello di arroccarsi nella terminologia elitaria delle regine grigie, proprio come i tecnicismi degli scacchisti. Eviteremo ciò con una semplificazione estetica: per Jünger una cosa è esattamente quella cosa – non un pretesto borghese, non un’allegoria didattica, lungi da consolazioni fantastiche o romanticismi piagnucolosi – descritta con tale perfezione da risultare straniante, talvolta disturbante; come in certi quadri surrealisti, dove l’oggetto reso nel dettaglio fluttua solido in paesaggio liquido. Egli tiene fermo e saldo un dato, lo analizza minuziosamente, lo possiede lucidamente, quindi ci costruisce attorno una cosmogonia mitica. Si fa così a mutare i secondi in eoni.
Prendiamo certe figure jungeriane emblematiche – il soldato in trincea, l’impersonale operaio, il ribelle sulla via del bosco, l’anarca antiborghese, l’eremita ultimo umanista – tutte accumunate da una parvenza positiva, nei film americani sarebbero “i buoni”. Ecco, proprio questo trastullo manicheo non aiuta alla comprensione. Da Nelle tempeste d’acciaio (1920) alle tarde memorie de Il contemplatore solitario (1995) la doppia cometa dello scrittore di Heidelberg somiglia più a una monade allo specchio d’acqua, che alla necessità di trovare un nemico. L’altro è sodale, poco importa della divisa che indossa, oppure cavia. Per Jünger l’avversario è sempre stato il campo di battaglia, forse pure il tempo nella forma di chi aveva davanti. Kronos famelico, tramutatosi sotto il dominio della tecnica, da steppa per duellanti a cavallo, a teatro meccanico degli orrori. Così accadde che l’avversario diventò nemico, quando con una granata non sei più obbligato a fissarlo negli occhi, quando tutto diventa numero lontano, fredda tabella di marcia e fosse comuni. L’indistinto della guerra moderna, l’indistinto della produzione industriale, l’indistinto della consumazione massificata. L’indistinto che designa capi pragmatici, capipopolo o guardiani di pecore, al di fuori delle obsolete aristocrazie. Quindi la riflessione, pur muovendo nel conforto di pietre miliari ai lati, sfugge dai romanzi e dai diari, evade dal tracciato, per bussare alle porte di Sophia e contempla – come nel caso di LSD e del rapporto con Hoffman – pure ritualistiche assunzioni di stupefacenti. D’altronde non li avrebbero chiamati così, visto che la stupefazione rientra appieno nella pratica del bambino, dell’eroe e dell’iniziato. Del martire e del mistico, del ribelle e dell’ardito. Allora siamo caduti in trappola, volendo semplificare Jünger, ci siamo persi nella boscaglia, perché c’era il cartello con la freccia.