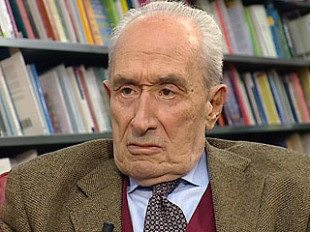
Che tenesse molto alla fama di scienziato della politica fra i più stimati e citati al mondo, è fuor di dubbio. E, del resto, quella notorietà se l’era conquistata con una produzione teorica solidissima, iniziata nel 1957 con Democrazia e definizioni, l’opera seminale da cui sarebbero scaturite molte delle sue riflessioni successive. Ma chiunque lo abbia conosciuto almeno un po’ sa che a Giovanni Sartori stava altrettanto a cuore un’altra reputazione. Amava apparire anche per quel che era soprattutto (ma non solo) fuori dell’accademia: un bastian contrario quasi per antonomasia, un vogatore controcorrente, un disturbatore dei manovratori dei dibattiti pubblici. Uno che diceva, secondo un proverbio che di certo non gli dispiaceva, pane al pane e vino al vino. E che indossava a meraviglia i panni che, critici e commentatori gli cucivano addosso, del “fiorentino spirito bizzarro”: arguto, brillante e polemico, capace di affondi tanto decisi e repentini da farlo apparire a volte come un attaccabrighe.
D’altronde, se il suo nome e le sue idee sono giunti ad un pubblico ben più ampio di quello dei frequentatori delle alchimie politologiche, lo si deve non alle pietre miliari del suo lavoro scientifico – volumi come Democratic Theory, Parties and Party Systems, Elementi di teoria politica, Ingegneria costituzionale comparata e non pochi altri, a cui vanno affiancati gli importanti ed influenti articoli sulle più prestigiose riviste internazionali e i testi dei richiestissimi interventi in convegni e simposi – ma agli sferzanti editoriali depositati sulle prime pagine del Corriere della Sera e alle interviste o alle repliche che ne seguivano, ogni volta che con uno di quegli scritti aveva gettato un macigno nello stagno della routine politica quotidiana. I nomignoli di cui ha gratificato i pasticciati sistemi elettorali nati dallo sconquasso della Prima Repubblica – l’iniziale Mattarellum e il successivo Porcellum – sono immediatamente entrati nell’uso giornalistico e di lì si sono infilati nel chiacchiericcio dei talk show, consegnandosi all’effimera perennità della cronaca. La sua battaglia mai terminata, anche se mai vittoriosa, per l’introduzione in Italia del sistema di voto a doppio turno ha segnato l’intero ventennio della transizione italiana post Tangentopoli, e suscita tuttora una periodica eco. E già mezzo secolo fa la vocazione di Sartori a “popolarizzare” le sue interpretazioni della dinamica politica lo aveva consacrato, simultaneamente, come studioso di grande solidità ed efficace comunicatore. Suo era stato infatti il coordinamento del primo lavoro argomentato su un tema destinato ad ampia discussione come Correnti, frazioni e fazioni nei partiti politici italiani e poi, soprattutto, l’articolo in cui aveva lanciato la formula del “pluralismo polarizzato” per descrivere e spiegare la situazione di immobilismo in cui, a suo avviso, si era impantanato il sistema politico italiano dalla fine degli anni Sessanta in poi. Impasse di cui rendeva responsabile la natura “anti-sistema” delle ali estreme dello spettro partitico, il Msi a destra (di cui poco gli importava) e il Pci a sinistra, che era il suo vero bersaglio, poiché, non disponendo di un “potenziale di coalizione”, cioè non potendo essere accettato come partner di governo, contribuiva a bloccare il sistema facendo invece pesare, magari per interposto sindacato, il suo “potenziale di ricatto”.
Vigorosamente controbattuto, ma con minore successo, da altri politologi perlopiù di simpatie comuniste e perciò indispettiti dalla fotografia che quella formula scattava, il paradigma del pluralismo polarizzato, pur avendo solide radici teoriche ed empiriche, nasceva in primo luogo dal versante delle passioni e delle preoccupazioni del Sartori-uomo. Un aspetto della sua persona che, forse per timore reverenziale, è stato sin qui assai poco studiato, ma che direbbe molto di un itinerario che, come è stato scritto, è stato sempre quello di un intellettuale militante, sia pure sui generis. Perché dagli umori che lo attraversavano Giovanni Sartori sapeva trarre spunti importanti di riflessione, che riversava poi prima in analisi scientifiche e poi, almeno a partire da un certo periodo, in divulgazioni giornalistiche.
Il primo passo in questa direzione, Sartori lo mosse con il già citato Democrazia e definizioni, che ebbe poi una versione americana ampliata, vero punto d’avvio del suo enorme successo nella comunità accademica internazionale. Da liberale classico, che aveva esordito con i primi scritti filosofici su Hegel, Kant e soprattutto Benedetto Croce, il suo obiettivo era, nel contempo, chiarire le distanze teoriche storicamente esistenti tra liberalismo e democrazia e tuttavia ancorare, nell’epoca presente, la seconda al primo, negando la possibilità alle sedicenti “democrazie popolari” instaurate nell’Est Europa di rivendicare quell’etichetta. Del popolo e della sua onnipotenza in materia di legittimazione dell’azione politica, che vedeva insinuarsi in alcune letture “perfezionistiche” della democrazia, Sartori era infatti (e sarebbe sempre rimasto) diffidente, e ciò lo portava a nutrire una marcata ostilità verso il socialismo, in qualunque sua versione. Diffidenza che, diventata più acuta, lo avrebbe spinto – secondo la testimonianza di alcuni suoi allievi dell’epoca, pur respinta a posteriori dall’interessato – ad abbandonare a metà anni Settanta l’Italia minacciata dal compromesso storico e dal possibile sorpasso del Pci sulla Dc – e a rifugiarsi nel buen ritiro newyorkese della Columbia University.
A quel primo connubio fra meditazione scientifica e indignazione civica altri ne sarebbero seguiti, e tutti avrebbero lasciato traccia.
Delle polemiche sui partiti e sui sistemi elettorali abbiamo già fatto cenno, e chi rilegga oggi Teoria dei partiti e caso italiano, del 1982, può coglierne l’ampia portata, che si estese ulteriormente alla stagione del riformismo sbandierato e mancato con Seconda Repubblica? Sì, ma bene del 1992 e Come sbagliare le riforme del 1995. Ma già altri bersagli si profilavano all’orizzonte, via via che Sartori ampliava il raggio del suo pessimismo, estendendolo dalla classe politica alla tecnologia, alla religione e all’uomo in quanto tale. Nel mirino delle sue bordate entrò così, per prima, la televisione con la sua opera di annichilimento – mediante l’assunto ingannevole del “vedere è credere” – della capacità di astrazione e riflessione, con l’urticante Homo videns. Di lì a poco fu il turno della Chiesa cattolica con la sua predicazione del “crescete e moltiplicatevi”, fustigata ne La terra scoppia e poi, assieme alla devastazione climatica, ne Il Paese degli struzzi. E, come è noto, un posto di rilievo in questo girone dei peccati della politica e della società, venne occupato dalla degenerazione personalistica del potere, incarnata dal Berlusconi de Il sultanato. Ma più di ogni altro male dell’epoca, ad angustiare Sartori erano le ricadute dei flussi migratori incontrollati, cui dedicò le pagine taglienti di Pluralismo, multiculturalismo e estranei e molte di quelle del suo testamento ideologico-culturale, La corsa verso il nulla, del 2015, con cui sperava di impartire ai contemporanei “10 lezioni sulla società in pericolo”.
Speranza vana, perché neanche ad un bastian contrario da molti stimato è consentito varcare le colonne d’Ercole del politicamente corretto. E a quell’ultimo Sartori le porte del dibattito intellettuale nelle sedi che contano sono rimaste chiuse. (pubblicato in versione ridotta su Il Fatto quotidiano)









