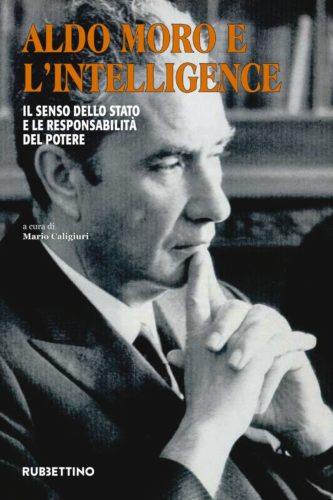
Una parte significativa della bibliografia riguardante Aldo Moro è focalizzata sul periodo del sequestro, della prigionia e dell’epilogo drammatico di una vicenda che ha quasi oscurato una lunga attività politica, costellata di incarichi a Presidente del Consiglio e a Ministro degli Esteri.
Curato da Mario Caligiuri e pubblicato dalla casa editrice Rubbettino nel 2018, “Aldo Moro e l’intelligence – il senso dello Stato e la responsabilità del potere” è un volume collettaneo incentrato su un tema – quello dei rapporti tra l’intelligence e il politico pugliese (esperto e cultore della materia) – penalizzato da una generale carenza di studi storico-scientifici e analizzato rigettando sia il cosiddetto approccio del “doppio Stato” sia una visione ingenua della gestione delle relazioni internazionali.
Come si apprese anni dopo dal Memoriale scritto mentre era ostaggio delle Brigate rosse, Moro utilizzò da neosegretario della DC le intercettazioni fornitegli dal generale De Lorenzo, capo del SIFAR, durante la convulsa crisi politica del luglio 1960 (“più pericolosa e destabilizzante di quella del 1964”) per costringere alle dimissioni l’esecutivo scudocrociato di Tambroni, che istituì un servizio a protezione di alte personalità politiche sottratto alle competenze del Viminale e progressivamente degenerato in strumento di pedinamento e di raccolta informazioni, cioè in un’illegittima attività spionistica che danneggiò, fra gli altri, colleghi di partito e di governo.
Ben più determinante dei moti di piazza della sinistra, una manovra parlamentare sotterranea orchestrata dal partito di maggioranza determinò la caduta dell’esecutivo, avviando il recupero dei socialisti nell’area di governo e creando un “nuovo polo” di sostegno politico per le carriere dei militari e per i servizi, nei confronti dei quali Moro nutrì una sorta di venerazione perchè fermamente convinto che rappresentassero uno strumento a protezione della democrazia.
Dopo la divulgazione dei fascicoli relativi agli scandali delle intercettazioni del SIFAR e del piano Solo – che dal suo punto di vista si configurarono come un pericolo imminente per la tenuta del partito, dello Stato e delle Forze Armate e fermo restando che il secondo evento “pur avendo le caratteristiche di un intervento militare, si tradusse nella realtà in una pesante interferenza politica per bloccare il centrosinistra” – egli si oppose all’istituzione di commissioni parlamentari di indagine e non denunciò De Lorenzo e il Presidente della Repubblica Segni. Prevalse, cioè, la propensione a disinnescare sul nascere i conflitti e la volontà di coprire gli apparati tramite il reiterato utilizzo degli omissis, in base alla logica della difesa del principio di neutralità dei servizi e del segreto di Stato quale strumento previsto dalla legge; in tal senso non esitò a criticare una sentenza della Corte costituzionale che previde più tardi l’obbligo di motivarne l’apposizione.
Custode di segreti inconfessabili e bersaglio di campagne giornalistico-parlamentari che ne indebolirono l’immagine (basti pensare a quella che lo identificò nel fantomatico “Antelope Cobbler”, dietro il quale si sarebbe celato il Presidente del Consiglio beneficiario delle tangenti dello scandalo Lockheed), fautore di una gestione oligarchica del partito alternativa alle “tentazioni autoritarie” di Fanfani, Moro – il quale individuò nelle correnti interne lo strumento idoneo a far assolvere alla DC la politica più idonea nella comunità nazionale e ad ottenere l’unità del partito, propedeutica alla difesa della centralità del medesimo nel sistema – sostenne che l’importanza del dissenso e la valorizzazione del pluralismo dovessero essere necessariamente bilanciate dalla consapevolezza che solo una piena assunzione della responsabilità politica da parte del segretario avrebbe garantito la sintesi e la mediazione.
Se da un lato la “guerra sotterranea” tra i generali si articolò nel tempo nella contrapposizione tra un’ala filoaraba raccolta intorno a Miceli (direttore del Sid, da lui protetto) e quella filoisraeliana guidata da Maletti (capo del reparto D del controspionaggio militare, vicino ad Andreotti), dall’altro il fallimento dell’unificazione socialista influì non poco sulla crisi del centrosinistra concepito – secondo la formula inizialmente ideata dal politico pugliese – sulla base della pregiudiziale anticomunista.
Moro si oppose agli accordi – ignoti nei contenuti e verosimilmente patrocinati dal generale Aloia d’intesa con Rumor e Piccoli – finalizzati all’attuazione di un piano d’emergenza “ispirato dal Governo ad organizzazioni di prevenzione e difesa dell’ordine pubblico di fronte alle manifestazioni eversive delle ultime settimane”, riferisce una nota dell’Ufficio Affari Riservati del 14 ottobre 1969.
In difficoltà e in minoranza nel partito, lo statista democristiano rilanciò la “strategia dell’attenzione” verso i comunisti attirandosi le critiche – tra gli altri – di Fanfani, La Malfa e Tanassi. Sottoposta alle più svariate interpretazioni e deformazioni tale apertura era effettivamente controversa, a maggior ragione in considerazione del fatto che egli aveva appreso in precedenza dai servizi che il PCI stava segretamente attivando “brigate” comandate da ex partigiani, pronte a confluire in nuclei di reparti organizzati che avrebbero reagito di fronte ad un eventuale colpo di Stato. Il contrasto ad iniziative quali lo scioglimento dell’UAR da parte di Taviani e la rimozione di Miceli – coinvolto in inchieste giudiziarie – ad opera di Andreotti trovò fondamento nella convinzione per cui, in un quadro politico eccezionalmente incerto e vulnerabile di fronte a manovre destabilizzanti, il rafforzamento dell’intelligence era considerato indispensabile.
Sullo sfondo del processo di riequilibrio degli indirizzi della politica estera in senso filo-palestinese, voluto anche al costo di provocare fibrillazioni e abbandoni nella maggioranza da parte dei repubblicani e nell’auspicio che l’Europa si attivasse per impedire lo scivolamento dei regimi arabi verso l’URSS, gli autori ripercorrono minuziosamente la lunga stagione di terrore posta in essere in Italia dalle frange oltranziste dell’OLP impegnate nella strategia dei dirottamenti aerei, da Settembre nero fino al Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, quest’ultimo probabilmente collegato all’ambasciata libica di Roma. Precisi interessi economici relativi alle forniture petrolifere e all’esportazione di merci verso i paesi arabi – insediatosi alla Farnesina, Moro si dichiarò favorevole anche alla cessione di armi – trovarono puntuale riscontro in appunti inviati dal Sid, che sollecitarono il Ministero degli Esteri ad attivarsi in tale direzione.
Nel frattempo, si verificarono avvenimenti oggi non di rado dimenticati: basti ricordare l’arresto ad Ostia di cinque miliziani pronti a compiere un attentato. Due di essi furono riaccompagnati in Libia da funzionari dei servizi, al termine di estenuanti trattative e sulla base di un escamotage giuridico che consentì loro di beneficiare della libertà provvisoria in applicazione della cosiddetta legge Valpreda; gli altri tre furono successivamente rimpatriati previo pagamento di una cauzione di venti milioni di lire effettuata – secondo la testimonianza di Miceli – direttamente dal Sid, plausibilmente interessato a chiudere un occhio di fronte a gravi azioni criminose pur di ingraziarsi il colonnello Gheddafi.
L’ampio spazio dedicato alla genesi e alle caratteristiche del “lodo Moro”, che tra le sue varie sfaccettature implicò l’impegno italiano a sostenere la causa araba nelle sedi internazionali affinché l’OLP venisse riconosciuta unica e legittima rappresentante del popolo palestinese, conferma il grado di priorità attribuito alla volontà di scongiurare attentati ritorsivi rispetto a considerazioni di carattere etico o giuridico. Se da un lato il magistrato Carlo Mastelloni si vide apporre il segreto di Stato con riferimento ai rapporti tra l’Italia e i palestinesi, dall’altro il garante del buon funzionamento di quel patto – peraltro non intaccato dalla misteriosa strage di Fiumicino del dicembre 1973, con riferimento alla quale l’esecutivo fu costretto a mentire di fronte ad un’interrogazione parlamentare di Pino Rauti – era il colonnello Stefano Giovannone.
Capocentro del servizio militare a Beirut, egli ricoprì di fatto per un periodo l’incarico di “factotum” della sicurezza di Moro, con il quale strinse un solido rapporto personale destinato a durare anche quando quest’ultimo divenne Presidente del Consiglio. Come si evince da una missiva indirizzata a Piccoli, egli si rivolse proprio al colonnello per esortarlo ad attivarsi ai fini della propria liberazione dalla prigione delle Brigate Rosse; altre lettere avallano, d’altro canto, l’esistenza del lodo facendo riferimento alle scarcerazioni “facili” dei palestinesi evidenziando le asimmetrie con il proprio caso.
Curiosamente i giudizi più positivi sull’operato di Moro da parte statunitense emersero dopo il rapimento; se le aperture verso i comunisti ed il dialogo con Berlinguer erano stigmatizzate in quanto operazioni spregiudicate e pericolose, le diffidenze e le perplessità – amplificate dall’indubbia incompatibilità del personaggio con Henry Kissinger – non furono tuttavia unanimi. Rapporti della CIA espressero valutazioni non proprio negative su un eventuale esecutivo DC-PCI, accreditandone la credibilità nella prospettiva del risanamento finanziario dell’Italia.
Deluso dalla crisi di un sistema democratico bloccato, in cui il controspionaggio militare aumentò in maniera esponenziale la propria capacità di influenza politica ed i servizi – dei quali pure invocò, al culmine della stagione degli anni di piombo, l’intervento contro gli estremisti in clandestinità – erano ridotti a strumento di lotta per il potere, Moro fu tra gli artefici della riforma (entrata in vigore nel 1977) che ebbe l’obiettivo di porre termine allo scontro tra le amministrazioni degli Interni e della Difesa, istituendo il SISDE e il SISMI a perfezionamento di un sistema duale da egli sostenuto. La contestuale smilitarizzazione delle forze di polizia – patrocinata dall’“allievo” Francesco Cossiga – fu motivo di contrasto tra i due, pur nell’ambito di una sostanziale stima ed amicizia reciproca.
Anche se non esaustivo per i motivi sopra citati, il volume offre un contributo notevole e rispecchia – a modesto parere di chi scrive – l’immagine di un indiscusso protagonista della storia repubblicana, dall’elevato spessore politico-diplomatico ma dai tratti – non solo caratteriali, bensì propri dell’agire – talvolta complessi, oscuri e contraddittori.









Alla fine, però, ci hanno perso tutti: Moro, la DC, la governabilità, l’Italia… Oscuro e contraddittorio Moro lo era. Da giovane ne provavo un’istintiva repulsione…
Occorre leggere il recente libro di Mario Segni sulla “fake news” del presunto colpo di Stato del 1964.
Moro è quanto di peggio si meritasse l’Italia.