 Tra i maggiori scrittori francesi del Novecento, Henry de Montherlant si pone all’incrocio tra André Gide, Maurice Barrès, P. Drieu La Rochelle e L. F. Céline. Georges Bernanos vide in lui “forse il più grande tra i nostri scrittori viventi”, mentre lo storico della letteratura Henri Clouard, nella sua “Storia della letteratura francese”, lo proclamò “il più grande dei viventi”.
Tra i maggiori scrittori francesi del Novecento, Henry de Montherlant si pone all’incrocio tra André Gide, Maurice Barrès, P. Drieu La Rochelle e L. F. Céline. Georges Bernanos vide in lui “forse il più grande tra i nostri scrittori viventi”, mentre lo storico della letteratura Henri Clouard, nella sua “Storia della letteratura francese”, lo proclamò “il più grande dei viventi”.
Henry de Montherlant nasce a Neuilly nel 1896 da una famiglia nobile originaria della Catalogna stabilitasi in Piccardia. Educato in un istituto religioso, nello stesso anno viene nominato presidente della Accademia letteraria e finisce bocciato. Si appassiona ben presto alla tauromachia, in cui, lui, cattolico pagano, e perciò non cristiano – dirà di essere stato un “cattolico all’italiana”-, sente il richiamo degli antichi riti sacrificali pagani, e a soli quindici anni uccide il suo primo toro. Man mano vengono a delinearsi i tratti essenziali della sua personalità: amore per lo sport (nel 1920 corre i cento metri in 11 secondi e 4/5), per il pericolo, per la nobiltà. Si aggiunga la familiarità con la Chiesa e con la storia romana (“Ero follemente preso dai miei romani quanto Don Chisciotte dai suoi eroi cavallereschi”): nella Chiesa romana Montherlant vedrà l’erede per eccellenza dell’impero romano; una Chiesa privata però della sua componente orientale, messianica, cristiana.
In tal senso, il “Paradiso all’ombra delle spade”, tra i suoi scritti più rappresentativi, appare particolarmente illuminante. Nell’opera Montherlant distingue tra due “filosofie” che hanno impresso il loro “sigillo” sul mondo: l’una “femminile”, inverificabile, nata in Oriente “come i miraggi” e causa di “disordine”, la cui progenie è rappresentata da “cristianesimo, bizantinismo, Riforma, concetti di libertà e di progresso, rivoluzione francese, romanticismo, umanitarismo, (…) bolscevismo”. Il suo emblema è il sentimentalismo, il “cuore”. L’altra, “virile”, “fondata sulla natura e sulla ragione: spirito e corpo”, il cui obiettivo è l’ordine, cioè “un valore di qualità”. La sua espressione massima è rappresentata da “Roma antica, dopo la conquista della Grecia”. Tra i suoi eredi illustri Montherlant addita il “cattolicesimo romano, il Rinascimento, i concetti di tradizione e d’autorità, il classicismo, i nazionalismi, i protezionismi materiali e morali.”.
L’antica Roma aleggia sul destino di Henry de Montherlant: a partire dal giorno di nascita, il 21 aprile, anniversario della fondazione di Roma, che lascia presagire il suo futuro di grandezza. La lettura in gioventù di Friedrich Nietzsche e Barrès lo inzia agli ideali di coraggio e di lealtà e all’etica dell’onore. A vent’anni si arruola volontario per il fronte: assegnato alle retrovie, se ne distaccherà portandosi in avanguardia. L’esperienza della guerra gli fa scrivere: “Si diventa veramente uomini in tre mesi di guerra che in una vita intera di pace”. Ma con questo non intende giustificare la guerra; più tardi scriverà: “Se vogliamo abolire la guerra, bisogna dare agli uomini di cuore, soprattutto giovani, qualcosa che abbia il medesimo valore (…). Dobbiamo portare in pace le virtù della guerra (…) io vorrei una pace che ci dia occasioni di coraggio e di altruismo”.
La fama gli arride ben presto: a trent’anni vedrà giungersi dall’Italia il riconoscimento di Gabriele d’Annunzio; l’abruzzese dirà di lui: “è un poeta di gran razza”. Ma la celebrità gli viene presto a noia: “Il 1924 – scrive – mi portò la notorietà e me ne tolse l’appetito”. Montherlant dà via i suoi mobili e lascia la Francia con due valigie, le quali, scrive, “dovevano costituire per più di dieci anni il mio unico bagaglio”. Inizia a viaggiare per il Mediterraneo: Italia, Spagna e Nord Africa. Entra in una fase di profonda crisi esistenziale, che si attenua finalmente nel 1930: “Dal 1930 in poi sono stato molto felice (…). Della crisi metafisica – perché viviamo? – sarebbe meno giusto dire che s’era risolta, che dire che s’era integrata, e che vivevo con lei… Ieri la domanda: a quale scopo? mi affliggeva: oggi mi placa”.
Critico nei confronti degli eccessi del colonialismo in Algeria, scrive “La Rose de Sable”: un grande romanzo in cui è racchiuso il suo anticolonialismo. L’opera vedrà la luce solo nel 1968: Montherlant, patriottico senza essere nazionalista, temeva potesse “nuocere alla Francia già indebolita”. Giungiamo alla tetralogia delle “Les Jeunes Filles” (“Le Ragazze da marito”, Adelphi, 2000): una storia di amori non corrisposti e per niente desiderati, da cui traspare una lunga meditazione sul mondo di oggi, sulla condizione dell’amore nel mondo moderno, in cui a prevalere sono i tanto detestati “valori femminili” – sentimentalismo, conformismo, appiattimento sulla quotidianità – a svantaggio dei “valori virili” dell’amicizia, dell’onore e dell’ordine. Va da sé, l’opera farà molto chiasso e verrà fortemente osteggiata dalle femministe, su tutte Simone de Beauvoir : nel “Deuxième Sexe”, la compagna di Sartre giudicherà “Le Jeunes Filles” una “cafoneria”. Un romanzo che è l’opera di un moralista, virile e raffinato: uno degli ultimi esteti decadenti: una incarnazione novecentesca, con qualche variante, del dannunziano Andrea Sperelli.
Durante gli anni del governo collaborazionista di Pétain, Montherlant si tiene in disparte, indipendente. Stringe comunque relazioni con alcuni esponenti dell’Institut allemand, come Heinz-Dieter Bremer, che tradurrà alcune sue opere in tedesco. La pubblicazione di “Le Solstice de Juin” (“Il Solstizio di Giugno”, Akropolis, 1996), dedicato alla battaglia di Francia del maggio-giugno 1940, gli vale però l’accusa di collaborazionismo. Nell’opera Montherlant descrive la svastica come emblema della “ruota solare” ed esalta l’eroismo individuale, l’”alta libertà di spirito”:
“un sentimento a tratti altamente inquietante (…) quanto “la saggezza” e “ogni forma d’ascetismo in questo mondo; modi di costringere e superare la natura, e quindi di sfuggirle. In breve, possedere la libertà di spirito, significa essere saggio; ma non palesarla al primo venuto significa essere ancora più saggio. (…) Qualcuno ha detto che l’arte di governare è l’arte di nascondere la violenza. L’arte di farsi accettare è in gran parte l’arte di nascondere la propria libertà di spirito”.
Una raccolta che gli procurò non pochi attacchi e accuse, determinati soprattutto dall’altezza 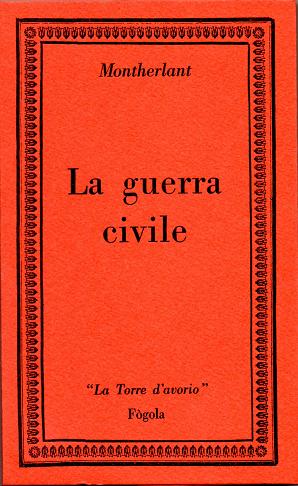 alla quale Montherlant si pose e dal respiro che egli si concesse per trarre la morale dagli avvenimenti, e che nel dopoguerra gli impedì di scrivere sui giornali per un anno. Seguirono i drammi “religiosi” – tra questi, “Port-Royal”, recentemente edito da Aragno -, l’antidemocratico “Il Cardinale di Spagna” (1960) e il dramma “La guerra civile” (1964), che in Italia giungerà nel 1976 prefato e tradotto da Piero Buscaroli. Qui la “guerra civile” (“la bonne guerre, la vraie guerre”) diviene categoria eterna e universale. La “guerra civile”, per Montherlant, si ripeterà, essendo la storia di Roma il microcosmo di tutta la Storia: quel che è “opus romanum” è “opus humanum”. Un ritorno in extremis “ai suoi romani”, dunque. Tra il 1960 e il 1972 occuperà il 29° seggio dell’Académie française, ma senza convinzione. All’amico Henry de Monfreid, in vena di diventare accademico, infatti dirà: “Avete avuto una bella esistenza (…). Perché diavolo volete diventare accademico?”[1].
alla quale Montherlant si pose e dal respiro che egli si concesse per trarre la morale dagli avvenimenti, e che nel dopoguerra gli impedì di scrivere sui giornali per un anno. Seguirono i drammi “religiosi” – tra questi, “Port-Royal”, recentemente edito da Aragno -, l’antidemocratico “Il Cardinale di Spagna” (1960) e il dramma “La guerra civile” (1964), che in Italia giungerà nel 1976 prefato e tradotto da Piero Buscaroli. Qui la “guerra civile” (“la bonne guerre, la vraie guerre”) diviene categoria eterna e universale. La “guerra civile”, per Montherlant, si ripeterà, essendo la storia di Roma il microcosmo di tutta la Storia: quel che è “opus romanum” è “opus humanum”. Un ritorno in extremis “ai suoi romani”, dunque. Tra il 1960 e il 1972 occuperà il 29° seggio dell’Académie française, ma senza convinzione. All’amico Henry de Monfreid, in vena di diventare accademico, infatti dirà: “Avete avuto una bella esistenza (…). Perché diavolo volete diventare accademico?”[1].
Il Bushidō, lo Zen e la lettura di Evola lo accompagneranno nei suoi ultimi giorni, prima della sua stoica uscita da questo mondo col cianuro. Pierre Pascal, yamatologo e iranista, amico comune a Montherlant e al filosofo tradizionalista, ha scritto:
«Mentre presentivo che Henry de Montherlant sarebbe uscito presto da questo mondo di morte e mentre tentavo di fargli compagnia e di non lasciarlo completamente solo con il suo fatale pensiero, ebbi l’idea di evocare per lui il patimento fisico che, da tanti e tanti anni, sopportava Julius Evola. Cinquantasei giorni prima l’equinozio del settembre 1972, mi pervenne la risposta: “Ho letto e leggo Julius Evola. Il contrario Vi deluderebbe, penso. Ora, io ignoravo tutto dello stato corporale di questo raro spirito. È quello che è. ‘Ma egli vede!’“».
Una volta cremato, le sue ceneri furono disperse, a Roma, intorno al Tempio di Portuno: il “tempio della Fortuna Virile”[2]. Era il 21 settembre 1972.
[1]Stenio Solinas, “Il corsaro nero : Henry de Monfreid l’ultimo avventuriero”, Vicenza, Neri Pozza, 2015.
[2]Nel suo primo testamento aveva dichiarato: “Se muoio nella mia patria e nella mia casa, desidero che il volto del mio cadavere sia ricoperto con la maschera di Conflans; che si metta sul mio cuore l’Eros funebre che si trova sullo scomparto superiore dell’armadio della mia camera; che sul basso ventre si posi la testa del toro di Guadalest, per essere così sepolto.”.








